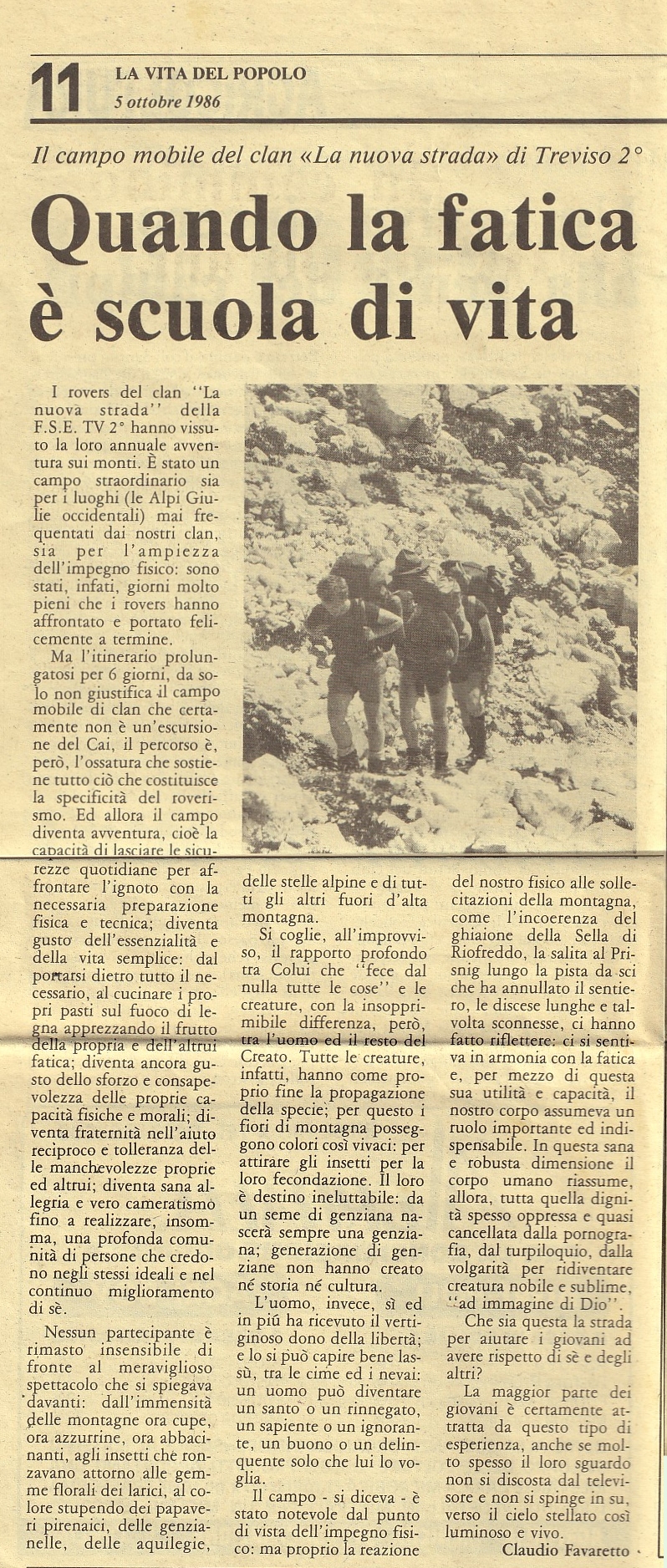|
[Torna]
pubblichiamo alcuni degli scritti
inerenti lo scautismo che Claudio ha prodotto nel corso degli anni nelle
riviste associative e non solo
Dal libro "100 anni di
scautismo cattolico a treviso"
capitolo delle testimonianze riportiamo
il testo scritto da Claudio
RIANDANDO CON LA MEMORIA

Devo scrivere un po’ di me per far capire la
drammaticità degli avvenimenti intercorsi nei primi anni ‘70 in ambito
scautistico. Sono testimonianze storico-personali.
Ho pronunciato la Promessa scout il 4 gennaio 1954 nelle mani
dell’allora capo riparto Gino Piazza. La sera precedente avevo
partecipato alla Veglia d’armi nella chiesa di santa Maria del Rovere,
veglia guidata dall’indi menticabile don Ugo de Lucchi.
l mio sentiero scout fu sereno e proficuo. Divenni csq. il 6 febbraio
1955, fondando la sq. Castoro. L’anno successivo guidai i Castori in un
campo di sq. in quanto non poté essere svolto quello di riparto dal
momento che Checco, succeduto al fratello, fu impegnato con esami di
diploma. Durante la missione per conquistare la specialità di ciclista,
assieme al mio compagno di viaggio individuai nella valle di san Lucano,
nei pressi di Taibon agordino, un posto da campo che sarà utilizzato nei
due anni seguenti, 1957 e ‘58.
Passai in clan in ottobre del ‘58, clan che allora era cittadino perché
riuniva tutti i rover dei relativamente pochi riparti di allora.
Purtroppo, il 23 aprile del 1959 don Ugo morì, lasciandoci veramente
smarriti. Ma a settembre arrivò don Giovanni Bordin che, con tutt’altro
stile, lo sostituì.
Nel 1961 il Gruppo TV 1°, che era nato nel 1955 per riunire i vari
riparti che avevano vissuto una vita propria e scollegata, si sdoppiava
e nasceva il nostro TV 2° con pochissime unità (santa Maria del rovere,
santa Bona) ma con grandissimo entusiasmo che produsse, in breve tempo,
un’espansione ragguardevole.
Agli inizi di novembre divenni responsabile della sq. libera di san Pio
X, che diventerà Riparto nell’autunno successivo.
Nel 1962 partecipai, assieme al compianto Ciano Furlanetto, al campo
scuola di 2° tempo a Colico, sul lago di Como. Il capo campo era
nient’altro che quel Salvatore Salvatori che aveva guidato, assieme ad
altri capi storici come Osvaldo Monass, Gino Armeni, Fausto Catani, la
rinascita dell’ASCI nel 1944.
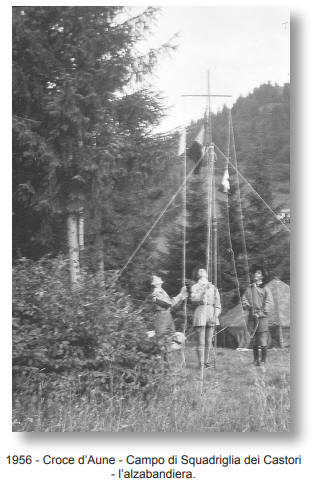 Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell
proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto
fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e
sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da
ragazzino. Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell
proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto
fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e
sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da
ragazzino.
Ne elenco in disordine solo alcuni:
- la meraviglia della vita all’aperto che ti fa sentire attivo, utile,
forte e libero da certe imposture sociali e che ti fa conoscere da
vicino il Creato di cui tu stesso fai parte.
- la tecnica scout che ti sostiene nelle avventure, ma anche nei momenti
di pericolo, che ti rende utile al prossimo.
- l’uniforme che ti identifica e che ti richiede talvolta forza d’animo
e sempre coerenza.
- il civismo che non è solo corretto comportamento nei confronti degli
altri e rispetto per ciò che è pubblico, ma anche senso di appartenenza
ad una nazione, ad un popolo, ad una storia, ad una cultura, ad un modo
di sentire e valutare.
- lo stile che vuol dire comportamento aperto senza eccedere e riservato
senza infingimenti e ipocrisie.
- la comunità gioiosa ed equilibrata.
- l’aiuto fraterno sincero e disinteressato.
- lo spirito di servizio accettato liberamente fin dalla pronuncia della
promessa e scelto in età adulta con profonda adesione agli ideali
evangelici.
- la spiritualità vissuta con la mente, con lo spirito ed anche con il
corpo perché tutto è dono di Dio: l’intelligenza, la sensibilità, il
fisico.
- l’osservanza della Legge e della promessa.
- la cavalleria e la cortesia nei confronti delle ragazze.
- l’autonomia della propria identità maschile.
- l’ammirazione e l’affetto per B.P. uomo straordinario come soldato
(cfr le sue innumerevoli avventure) e geniale come educatore.
Nel 1968 scoppiò in Francia prima, in Germania poi, dopo la cosiddetta
contestazione giovanile, passata alla storia anche come il “68”.
Dapprima confuso poi più articolato, il movimento ebbe anche momenti di
forte violenza, con occupazioni di università, scioperi di studenti ed
operai, scontri con la polizia, contestando tutto e tutti. In
particolare si criticò profondamente tutto ciò che poteva limitare la
libertà individuale, diventata una sorta di Assoluto a cui tutto doveva
essere sottomesso, a partire da ogni forma di autorità. Nulla doveva più
essere vietato né in campo morale né civile. Famosa l’espressione
“vietato vietare”. Il primo ad essere colpito fu il concetto di
autorità. L’onda d’urto colpì dapprima l’università, poi la famiglia, la
chiesa, infine tutte le forme di gerarchia, comprese quelle delle
associazioni giovanili, compreso lo scautismo.
Fu un movimento così profondo al punto che stiamo ancora subendo le sue
aberrazioni, come l’odierna crisi della famiglia drammaticamente
insegna. In Italia si può dire che la contestazione nasca con
l’occupazione della facoltà di Sociologia di Trento per poi espandersi
alla Cattolica di Milano e un po’ alla volta anche alla scuola
superiore.
Per quanto riguarda lo scautismo, la crisi si insinuò un po’ alla volta.
E un po’ alla volta dovemmo subire, io e i capi di allora, un’infinita
serie di enormi falsità sia sotto il profilo psicologico che
metodologico. Sembra impossibile che ci sia stato qualcuno che in buona
fede credesse a tali bugie! Eppure ce ne furono tanti, alcuni dei quali
per ignoranza o per desiderio di mettersi in mostra, o per ambizione
personale.
Tutto quel mio mondo di ideali concreti ed attuati fu scosso. La prima
azione fu la conduzione femminile dei branchi. Fu detto che una donna
sarebbe stata più adatta a guidare un gruppo di bambini! E la figura di
Akela con tutto ciò che ne consegue? Il fatto vero era che parecchi
rover romani non apprezzavano il servizio in branco, non avendo capito
la bellezza pedagogica-educativa del Libro della Jungla. Anzi Kipling fu
considerato un autore imperialista, per cui nacquero le più strampalate
metodologie di alberi, fate, gnomi, ecc. Dal momento che le giovani capo
branco, le famose “cheftaines” letteralmente capo-tana, scopiazzate dal
contemporaneo scautismo francese, anch’esso ovviamente in crisi, non
avevano un ambiente di formazione, si pensò di inserirle in un clan,
come se non esistesse un fuoco di scolte! Da lì la nascita delle unità
miste di terza branca, i Flan, nome, a mio parere, assolutamente
insensato. Da quel momento fu tutta una corsa verso la assurdità e la
falsità psicologica degli educandi. Nacquero i Branchi misti, con i
lupetti e le lupette, nacquero i riparti misti, addirittura, nei primi
anni, con le squadriglie miste. Mi ribolle il sangue ricordando come
possa essere stata contrabbandata come una grande conquista il fatto di
avere in sieme ragazzine e ragazzini con la speciosa giustificazione che
già tanto a scuola erano insieme e anche in famiglia. Come se non si
sapesse quanto un ragazzo senta il desiderio di vivere in quell’età con
i suoi coetanei, cimentarsi con loro, avere la possibilità di vivere
avventure da grandi e non cincischiare con le ragazzine. Eppure la
stampa associativa di allora, “L’esploratore” riportava grandi titoli
del tipo: “AGI+ASCI= AGISCI” per preparare un po’ alla volta la nascita
di un’unica associazione.
Io ero Capo Riparto e soffrivo a dover combattere contro quella che
doveva essere un aiuto educativo ed invece mi metteva in continua
difficoltà.
In parallelo a quanto scritto sopra, ecco le proposte o le critiche al
“mio” scautismo:
1. la vita all’aperto era deviante, perché allontanava i giovani dai
veri problemi sociali, bisognava abolirla, ”Lo scautismo lascia il bosco
per entrare in città” era lo slogan.
2. Un branco di Lupetti di Conegliano partecipò, guidato dal suo Akela,
ad un picchettaggio in una fabbrica, forse la Zoppas.
3. la tecnica scout viene ridicolizzata: cosa serve imparare il morse
quando ci sono le radio trasmittenti? Senza capire lo sforzo educativo
richiesto ad un ragazzino per memorizzare e la soddisfazione di riuscire
a comunicare con gli altri: una sorta di magico mondo segreto.
4. l’uniforme è colonialista e ricorda la prevaricazione degli Inglesi
sui popoli di mezzo mondo. Inoltre nasconde le differenze di classe: in
uniforme non si riconosce un bambino di famiglia povera da uno ricco,
mentre è importante far capire fin da piccoli che bisogna battersi per
l’uguaglianza sociale! E poi in borghese nessuno riconosce che sei uno
scout.
5. L’alzabandiera al campo va abolita perché è un retaggio fascista e
nazionalista.
6. I ragazzi devono esprimersi liberamente, senza codici particolari di
comportamento.
7. La comunità deve essere assolutamente spontanea: non esiste un capo,
non esiste la Corte d’Onore, ma il Consiglio della Legge, una sorta di
assemblea generale di tutto il riparto. Il Capo è una sorta di “Unus
inter pares”. Non deve esistere “Un’educazione direttiva”. Tutte le
decisioni, a qualsiasi livello, devono essere prese in forma
assembleare. Non esiste il capo, ma solo una sorta di porta voce
dell’assemblea.
8. Quando il riparto è misto, non esiste “UN” capo ma la “Diarchia” cioè
la direzione comune di capo donna e capo uomo. Non succede così anche in
famiglia?
9. Lo spirito di servizio viene stemperato in modo impressionante con la
assurda divisione dei riparti in due età: 12-14 ranger; 14-16 pionniers.
I quali ultimi fanno per lo più viaggi di tipo turistico, in barba al
concetto del csq. che aiuta i suoi squadriglieri.
10. La spiritualità deve essere una libera scelta: non ha nessun valore
educativo la preghiera; la messa al campo, se c’è, è facoltativa. Si
arrivò alla cancellazione della frase “Con l’aiuto di Dio” nella
formulazione della promessa per non turbare la libertà degli educandi.
11. Degli articoli della Legge alcuni perdono importanza, come quello
dell’obbedienza agli ordini (il 7°), il 10°; ma tutta la Legge, come la
Promessa assumono un’importanza molto relativa.
12. L’articolo 5° (cortese e cavalleresco) perde significato dal momento
che le ragazze sono dei semplici squadriglieri che bisogna richiamare se
necessario anche con parole e gesti forti: non sono l’altra metà del
mondo da scoprire un po’ alla volta nella loro genuinità e freschezza.
13. Per vivere insieme alle ragazze nello stesso riparto o addirittura
nella stessa squadriglia i ragazzi devono rinunciare a molto della loro
genuinità maschile: i giochi fatti di forza fisica, di coraggio, di
spirito di avventura devono essere addolciti per permettere anche alle
ragazze di parteciparvi. Così le ragazze devono un po’ adattarsi allo
spirito maschile: gli uni e le altre devono rinunciare a qualcosa della
loro identità proprio nell’età in cui si pongono le basi dell’età adulta
dove ci saranno uomini veri e donne vere.
14. B.P. venne considerato un militarista, un colonialista, un uomo che
non poteva aver fatto nulla di buono. Lo scautismo così com’era stato
vissuto fino a quel momento doveva essere rifiutato e fondarne uno nuovo
aderente alla società cambiata: all’uomo della frontiera doveva essere
sostituito l’uomo della lotta di classe.
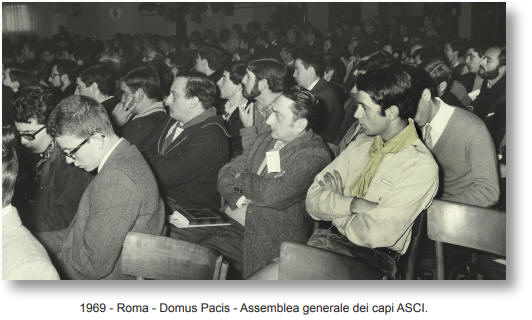 Gli ultimi anni 60 ed i primi 70 furono caratterizzati da un continuo
logorio sia a livello nazionale che locale, con continue riunioni tra i
fautori del nuovo corso e coloro che giudicavano lo scautismo di B.P.
ancora valido ed efficace. L’ultima assemblea generale dell’ASCI si
svolse, se non erro, nel 1969 a Roma. Fu una cosa triste: del vecchio e
genuino scautismo non era rimasto quasi niente. Fu convocata dall’allora
presidente, Salvatore Salvatori, il mio capo campo. Erano passati solo 8
anni, eppure il vecchio leone non contava più niente. L’incontro si
doveva svolgere in borghese: noi scrivemmo un telegramma di protesta e
ci recammo a Roma in uniforme. All’ingresso della “Domus pacis” c’era
Salvatori che quasi pianse vedendoci in uniforme. Evidentemente non era
riuscito ad imporsi sui nuovi smaniosi di novità. Gli ultimi anni 60 ed i primi 70 furono caratterizzati da un continuo
logorio sia a livello nazionale che locale, con continue riunioni tra i
fautori del nuovo corso e coloro che giudicavano lo scautismo di B.P.
ancora valido ed efficace. L’ultima assemblea generale dell’ASCI si
svolse, se non erro, nel 1969 a Roma. Fu una cosa triste: del vecchio e
genuino scautismo non era rimasto quasi niente. Fu convocata dall’allora
presidente, Salvatore Salvatori, il mio capo campo. Erano passati solo 8
anni, eppure il vecchio leone non contava più niente. L’incontro si
doveva svolgere in borghese: noi scrivemmo un telegramma di protesta e
ci recammo a Roma in uniforme. All’ingresso della “Domus pacis” c’era
Salvatori che quasi pianse vedendoci in uniforme. Evidentemente non era
riuscito ad imporsi sui nuovi smaniosi di novità.
L’assemblea si svolse senza ordine alcuno. Una mozione fu votata di
notte, quando la stragrande maggioranza era andata a letto. Di lealtà ne
respirammo veramente poca. Tornammo a casa con l’esatta sensazio ne che
ormai eravamo agli sgoccioli.
Si giunse infine all’aprile del 1974.Stranamente il direttivo dell’ASCI
e quello dell’AGI si erano riuniti nella stessa struttura, una delle
tante di Roma. Così, stranamente, entrambi i direttivi votarono lo
scioglimento delle rispettive associazioni e la nascita della nuova,
l’AGESCI.
Dopo tale risultato, tutti si riunirono insieme e la nuova assemblea
dopo la comunicazione dei rispettivi responsabili (io ricordo solo il
maschile che era la buon’anima di Bruno Tonin, di Vicenza), acclamò la
nuova nascita con l’esortazione “bacio, bacio!!” che avvenne tra i due
responsabili. Che bello!.
Non ci fu un’assemblea, non furono coinvolti i capi brevettati, non si
lasciò il tempo alle realtà locali di discuterne: un colpo di mano
vergognoso!.
Noi del Treviso 2° e una parte delle ragazze del Treviso 1° non
accettammo il fatto compiuto: a ottobre non versammo la quota del
censimento e con quei soldi fondammo un’associazione “Gruppi e Ceppi
Scout Cattolici Treviso”. Come Treviso, altre realtà non aderirono
all’AGESCI come alcune di Roma, di Jesi, di Palermo, ecc. Nell’aprile
del 1976 alcuni capi romani fondarono, di fronte ad un notaio di Roma
l’Associazione Guide e Scouts d’Europa Cattolici, aderenti alla
Federazione dello Scautismo Europeo.
A settembre anche la realtà trevigiana aderì alla nuova associazione che
svolse il primo campo scuola nel novembre dello stesso anno a
Montegemoli, in Toscana.
Questo è quanto la mia memoria mi riporta! Salvo errori ed omissioni!
↑▲↑
Da Azimuth 1-2011
La nascita dei
“Gruppi e Ceppi Scout Cattolici” a Treviso
Claudio Favaretto
 Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel
1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo
Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da
ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non
riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che
aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con
tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di
quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,
Commissariato Regionale), sia a livello nazionale. Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel
1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo
Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da
ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non
riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che
aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con
tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di
quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,
Commissariato Regionale), sia a livello nazionale.
All’ultima Assemblea Nazionale dell’ASCI, dopo aver mandato un
telegramma di protesta, partecipammo, forse noi soli di Treviso, in
uniforme. La convocazione, infatti, parlava di intervento in borghese,
quasi ci si vergognasse della nostra uniforme!
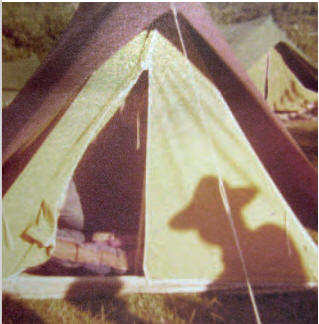 Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi
del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti: Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi
del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti:
1) conduzione femminile dei branchi;
2) clan misti;
3) precisa scelta politica;
4) critica all’uniforme;
5) critica alla Legge Lupetto ed Esploratore;
6) gestione collettiva delle unità;
7) abolizione della squadriglia di B.-P. diventata un semplice gruppo
spontaneo;
8) scelta cristiana vista solo come una delle ipotesi;
9) abolizione dell’alzabandiera perché la bandiera era un simbolo
nazionalistico.
Mi soffermo solo un attimo solo sul primo punto dell’elenco. Per noi, e
non solo per noi, ovviamente, la figura di Akela nel metodo lupetto è
insostituibile e per il bambino diventa uno dei modelli da seguire. Come
si poteva proporre una figura femminile?
Come ben si sa, malgrado tutte le opposizioni provenienti da ogni parte
d’Italia, i Consigli Generali dell’ASCI e dell’AGI il 4 maggio 1974,
alle ore 23,50 approvarono l’unificazione delle due associazioni dando
vita all’AGESCI.
 Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di
un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i
capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione
presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci
arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben
consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,
350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di
concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione
di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974. Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di
un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i
capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione
presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci
arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben
consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,
350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di
concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione
di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974.
Ci dedicammo con enorme entusiasmo e con tutte le energie disponibili a
far funzionare questa nuova struttura.
Così furono distribuiti i compiti: uniformi, statuto, stampa, economia,
formazione Capi. Tutto doveva essere costruito e messo in condizione di
funzionare.
Questa Federazione durò due anni, mentre il Capo Gruppo,
l’indimenticabile Francesco Piazza, cercava agganci a livello nazionale.
Trovò alleanze in Piergiorgio Mingo di Jesi, Sergio Durante e Attilio
Grieco che gli parlarono della Federazione dello Scautismo Europeo.
Il Direttivo della nostra Federazione di Treviso, dopo aver esaminato lo
Statuto degli Scouts d’Europa, convenne che questa era finalmente la
nostra collocazione, che non ci chiedeva di rinunciare a nessuno dei
valori in cui credevamo, anzi ne aggiungeva uno di importante:
l’Europeismo, cioè la dimensione internazionale, tanto cara a B.-P. E
dall’ottobre del 1976 facciamo parte, noi tutti, dell’Associazione Guide
e Scouts d’Europa Cattolici.

↑▲↑
Da Azimuth 6-2011
Monsignor Giovanni Bordin
Claudio Favaretto
 Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del
Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don
Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I
campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave
perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse
inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in
parte. Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del
Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don
Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I
campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave
perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse
inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in
parte.
Giungevano voci che sarebbe arrivato un giovane sacerdote, conoscitore
di musica, ma assolutamente digiuno di Scautismo. Bisogna sapere che don
Ugo era un grande intenditore di musica e che molti di noi erano sia
cantori che Scout.
Eravamo, perciò, un po’ delusi, ma desiderosi di incontrare il giovane
prete, che giunse, finalmente, uno dei primi giorni di ottobre.
Ci piacque subito: corpo robusto, faccia rotonda, sorriso aperto,
cordialità contagiosa. Si rese subito conto che veniva a raccogliere una
grande eredità spirituale lasciata da don Ugo, e con umiltà cercò di
capirla ed interpretarla in modo molto rispettoso.
Un po’ alla volta entrò nello spirito e nella prassi dello Scautismo,
così che lentamente divenne il nostro punto di riferimento. Una cosa ci
stupì subito, oltre all’umiltà: la sua grande disponibilità. Non si tirò
mai indietro, anche di fronte a richieste che forse potevano arrecargli
dei fastidi. Ad esempio, non avendo mai dormito sotto tenda, la novità
poteva essere poco gradevole: egli reagì facendosi fare una tenda alta,
robusta e larga, in cui si potesse muovere agevolmente, data la sua
massiccia corporatura.
L’inconsueta realizzazione fu ironicamente battezzata dagli Scout
presenti al suo primo campo “caponera”!
Fu un uomo di profondo equilibrio e di grande saggezza, che prodigò nei
suoi contatti con capi e ragazzi, quando
 andavano a trovarlo per un
consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni
importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva
esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della
nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale
nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena
formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e
Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che
investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi
presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali
nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,
imponeva. andavano a trovarlo per un
consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni
importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva
esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della
nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale
nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena
formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e
Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che
investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi
presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali
nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,
imponeva.
Dopo alcuni anni di permanenza in parrocchia, don Giovanni scelse di
entrare tra i Sacerdoti Oblati perché gli sembrava di fare troppo poco
rispetto a quanto aveva sognato per la sua vocazione. In questa veste fu
richiesto dal Vescovo di allora di dirigere la “Vita del Popolo”, il
settimanale diocesano. Egli non aveva dimestichezza con quel mondo, ma
accettò come sempre con umiltà, circondandosi, però, di una squadra di
collaboratori molto validi che garantirono un vero successo nella
diffusione del settimanale nelle famiglie della diocesi.
 Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche
involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al
campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima
di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste
piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel
1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia
macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo
dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a
vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la
macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca
di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.
Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane
pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente
dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna
il cane proseguì il Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche
involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al
campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima
di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste
piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel
1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia
macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo
dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a
vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la
macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca
di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.
Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane
pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente
dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna
il cane proseguì il
 suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente
una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.
Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,
utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella
messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni
preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi
chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio
di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce! suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente
una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.
Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,
utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella
messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni
preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi
chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio
di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce!
Don Giovanni accompagnò lungo il cammino della vita quei numerosi
adolescenti che lo accolsero nel 1959. Egli celebrò i nostri matrimoni,
battezzò i nostri figli, ricevette le nostre difficoltà e i nostri
dubbi: è stato veramente una guida per noi.
Vent’anni fa, fu incaricato dal Vescovo di dirigere la parrocchia di
Riese Pio X. Che strano: era stato mandato proprio nella parrocchia da
dove era proveniva e dove era sepolto quel sacerdote ch’egli aveva
sostituito: don Ugo de Lucchi. Anche nella nuova realtà don Giovanni
seppe profondere, malgrado le malattie, tutta la sua carica umana e
spirituale che erano parte della sua straordinaria personalità. L’ho
avvertito durante il funerale quanto fosse benvoluto: perché chi fa il
bene non può che essere amato. E lui di bene ne ha fatto molto, e di
questo sarà da Dio sicuramente ricompensato. Ed ora riposano in pace
vicini, i due nostri cari assistenti.
↑▲↑
Da Azimuth 4-2012
Un amico degli scouts
Claudio Favaretto
“Che uccello è la mangusta?” Questa domanda spiritosa e improvvisa ci fu
rivolta dal vescovo in visita al campo della Valle solitaria che si
stava svolgendo non lontano dal passo della Mauria, nel 1964.
L’assistente ed io l’avevamo ricevuto, come si conviene, con il riparto
schierato in quadrato. Poi il Vescovo volle visitare il campo. Era stato
negli anni giovanili assistente Scout in una parrocchia di Vicenza, per
cui sapeva bene come valutare un campo. Allora le squadriglie, dopo il
“crack” raggiunsero i propri angoli per accogliere l’illustre ospite.
Dapprima si presentarono i Gheppi. Come si sa, il grido di squadriglia è
proprio un grido, non una comunicazione, per cui chi lo sente non
capisce proprio nulla. Così il vescovo, che mi chiese: “Cosa hanno
detto?” Al che risposi. “Gheppi, nel volo sicuri!”. Dopo aver salutato e
spronato la squadriglia a ben operare, raggiungemmo l’angolo dei Picchi.
Anche qui la presentazione di squadriglia fu indecifrabile, per cui
dovetti spiegare che il loro motto era “All’invito del bosco!”.
Soddisfatto, il vescovo fu accompagnato all’angolo delle Manguste che si
presentarono con un incomprensibile “Siamo sempre ardimentose!”. Allora,
rivolto verso
 di
me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la
mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far
comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,
come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare
pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando
mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.
Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,
dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II
a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle
idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che
anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una
certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano
il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero
diventati da lì a poco pontefici. di
me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la
mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far
comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,
come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare
pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando
mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.
Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,
dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II
a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle
idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che
anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una
certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano
il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero
diventati da lì a poco pontefici.
Proprio con Giovanni Paolo II intrattenne un bel rapporto, come
dimostrano i soggiorni di quest’ultimo nel Castello di Lorenzago,
pertinenza della Diocesi trevigiana. La sua cura pastorale fu rivolta
soprattutto alle parrocchie, parecchie delle quali furono create proprio
da lui, come quella di San Pio X° a Treviso, dove iniziai il mio
servizio di capo. Nella sua lunga missione pastorale ha somministrato il
sacramento della Cresima a migliaia di ragazzi e ragazze, ha ordinato
oltre duecento tra sacerdoti e diaconi. Sensibile ai valori dell’arte,
ha istituito il Museo diocesano di Arte sacra; inoltre ha riformato il
seminario, ha costruito “Casa Toniolo” come sede delle associazioni
cattoliche, ha edificato la “Casa del clero” per accogliere i sacerdoti
anziani, ha acquistato la casa di villeggiatura di Lorenzago. Come si
capisce, è stato un presule pieno di iniziative. Monsignor Mistrorigo ha
avuto un’enorme importanza nella nostra storia associativa. Infatti, il
21 ottobre 1984 emanò il “Decreto di erezione in associazione pubblica
della sezione diocesana degli Scouts d’Europa”. Fu, quindi, uno dei
primi vescovi a riconoscere canonicamente la nostra associazione, sia
pure a livello locale, in quegli anni così difficili. Il 12 giugno 2004,
il “Centro studi Don Ugo De Lucchi” volle festeggiare i 50 anni di
episcopato del vescovo, invitandolo ad un incontro presso la “Casa Scout
Anna e Franco Feder” a Treviso. Il vescovo esordì dicendo: “Sono
contentissimo di essere qui, perché sono parente degli Scout: nonno e
bisnonno!”. Dopo aver passato in rassegna alcuni dei suoi molti ricordi,
Mistrorigo affermò: “Ora siamo in un periodo di magra per quanto
riguarda il mondo dell’associazionismo; l’unica associazione che rimane
in piedi è lo Scautismo”. Poi il vescovo ha ricordato la figura del
nostro indimenticabile don Ugo De Lucchi, di cui espresse le doti, “un
misto di zelo e dinamismo” e il dolore per la prematura scomparsa: “Ma
dal cielo sono convinto che continui a seguire benevolo i suoi Scout”.
A conclusione dell’incontro, il vescovo ha pronunciato una vivace
definizione e un fervido augurio: “Cosa sono gli Scout? Sono giovani in
piedi. Questa è la vostra missione di domani: stare in piedi ed aiutare
gli altri ad alzarsi. Io vorrei che voi foste all’avanguardia nella
vostra diocesi. E ricordate che quando sarò di là, guarderò se gli Scout
si comportano bene!”. Rimase operoso anche per i lunghi anni successivi
al termine del suo mandato di vescovo titolare, dedicandosi alla stesura
e pubblicazione di testi di contenuto biblico e liturgico ed aiutando
nell’amministrazione del sacramento della Cresima. Negli ultimi tempi
aveva perso l’uso della parola, ma il suo sguardo era ancora vivo e
penetrante. È tornato alla casa del Padre sabato 14 gennaio 2012. Pochi
giorni dopo, il 26 marzo, avrebbe compiuto 100 anni. Grazie, don Antonio
Mistrorigo, ti porteremo con noi: ci hai sempre voluto bene e ci hai
aiutato nei momenti difficili e complessi della nostra storia
associativa.
↑▲↑
Da Azimuth 3-2013
ESTOTE PARATI
Claudio Favaretto
Il 6 maggio del 1976, alle 21,06, un terribile terremoto colpì il
Friuli. L’impatto emotivo sulla nazione fu enorme, alla vista di interi
paesi rasi al suolo, con un impressionante numero di morti, in continuo
drammatico aumento.
Come al solito, oltre alle forze preposte, molti volontari partirono da
ogni parte d’Italia. Anche numerosi Clan e Fuochi della nostra neonata
Associazione partirono per raggiungere le zone terremotate.
Io, Capo Clan, ero insegnante di liceo e non potevo abbandonare il posto
di lavoro nella parte conclusiva dell’anno scolastico. Perciò partimmo
appena liberi dagli impegni scolastici, attorno alla metà di giugno.
Ma io ero molto perplesso. Sapevo bene che tanti volontari erano più di
intralcio che di aiuto. Mi chiedevo in cosa saremmo potuti essere utili
noi, quindici ragazzi, privi di strumenti adatti a rimuovere macerie e
inadatti a intervenire in qualche modo su una popolazione smarrita e
bisognosa di ogni cosa. Devo dire che partii di malavoglia, senza farlo
trasparire ai miei Rovers. Ma l’“Estote parati” era pur sempre il nostro
motto, per cui accettai la sfida.
I Clan e i Fuochi che ci avevano preceduto avevano svolto il loro
servizio a Vito d’Asio, un paese che non avevo neppure mai sentito
nominare prima di allora. Giungemmo nel tardo pomeriggio, dando il
cambio a due Clan, uno di Treviso ed
 uno di Roma. uno di Roma.
Il paese era stato completamente distrutto per cui era stata allestita
una tendopoli su un prato fuori dal centro abitato. Nei pressi era stata
edificata una costruzione in legno che fungeva da cucina e da mensa per
gli abitanti e per coloro che lavoravano alla bonifica del sito. Erano
presenti anche alcuni soldati, comandati da un tenente, con compiti
logistici. Ci era stato assegnato uno spazio non lontano dalla tendopoli
per piantare le nostre tendine, cosa che facemmo, allestendo anche una
sorta di cucina-soggiorno riparata da teli, secondo tradizione. Poco
lontano si era accampata anche una pattuglia di Scolte, con la loro
capo, che svolgevano il loro servizio contemporaneamente a noi.
La sera stava scendendo, gli altri Clan se n’erano andati e io mi
interrogavo sul significato della nostra presenza: mi sembrava che
fossimo quasi degli intrusi in un contesto già organizzato.
Cenammo in mensa, assieme a tante persone, per poi recarci a riposare,
dopo esserci messi d’accordo con il responsabile della tendopoli, un
bravo e simpatico giovane, tarchiato, cordiale e deciso, che il giorno
seguente noi saremmo stati disponibili alle richieste della gente, per
servizi adatti alle nostre capacità.
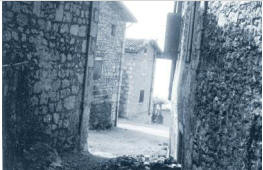 Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca
dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le
loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di
servizio. Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca
dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le
loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di
servizio.
Aiutammo a sistemare la legna, a rastrellare il fieno, a diradare
piantine di granoturco, a mettere in ordine masserizie, a raccogliere le
immondizie.
Le Scolte, d’altra parte, distribuivano, a chi ne faceva richiesta, capi
di vestiario giunto da ogni parte d’Italia ed anche da diversi stati
europei. Ma mi restava un po’ l’amaro in bocca di sentirmi quasi di
peso, perché anche noi usavamo della mensa. Così decidemmo di cucinare
per conto nostro: durò poco, perché la signora che gestiva la mensa ci
disse che la nostra presenza insieme agli altri era non solo gradita, ma
desiderata: non erano certamente i nostri pasti a mettere in crisi la
loro cucina.
Ciò mi fu di grande insegnamento. Perciò ritornammo a condividere i
pasti con tutti i paesani e i lavoranti con cui, un po’ alla volta,
entrammo in relazione. Gli abitanti erano con noi estremamente cordiali
e grati dei piccoli servizi che facevamo: avevano perso quasi tutto, ma
erano così ospitali e generosi che ci invitarono più di una volta a
pranzo o a cena, a condividere quel poco che avevano.
Una cosa veramente commovente ed educativa per il clan intero. Ma il
vero servizio, senza che lo cercassimo, si presentò sotto altra forma.
 La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di
noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle
preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della
tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine
per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben
maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il
fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei
saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni
di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare
insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia. La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di
noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle
preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della
tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine
per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben
maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il
fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei
saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni
di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare
insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia.
Dalla sera successiva la nostra giornata si concluse puntualmente con il
fuoco cui parteciparono sempre più persone: così dal tenente di Vito
d’Asio si passò al maggiore per finire al colonnello, giunto l’ultima
sera con la moglie e un numero enorme di soldati. Naturalmente ai canti
dovemmo aggiungere giochi, scherzi e ban. L’attesa era diventata così
grande che alcuni soldati rinviarono la loro licenza pur di restare fino
alla fine della nostra settimana di servizio.
La conclusione dell’ultimo fuoco fu veramente straordinaria: dopo le
preghiere recitate compostamente da tutti, cantammo il canto dell’addio
e devo dire che la commozione prese tutti. Eravamo andati per obbedienza
a quell’“Estote parati” che ci contraddistingue, e ci ritrovavamo con la
consapevolezza di aver svolto uno dei servizi più belli e nobili: aver
fatto felici almeno per qualche ora, persone o colpite dalla tragedia o
inviate a svolgere impegnativi compiti.
↑▲↑
Da Azimuth 2-2014
Ritratto di Don Rino Olivotto
Una persona di cui non ci si può dimenticare
Claudio Favaretto
Si è spento mercoledì 22 gennaio 2014 Mons. Rino Olivotto, 85 anni, per
molti anni Assistente dei nostri Gruppi Scout di Treviso e di alcuni
campi scuola associativi. Di seguito il ricordo di due Capi.
L’avevo incontrato per la prima volta per strada, mentre passeggiava con
un comune amico, che me lo presentò. Era grande, massiccio, di fiero
portamento, proporzionata la testa dove risaltavano i bianchi capelli
rimasti nella nuca, vivacissimi gli occhi dietro le lenti di leggera
montatura, grande la bocca dalle labbra carnose che si aprivano
frequentemente in un cordiale sorriso. Era sicuramente una di quelle
persone che non si dimenticano. Poteva avere fra i cinquanta e i
sessant’anni.
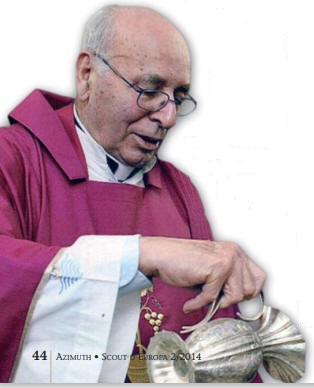 Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed
imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del
Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda
collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22
gennaio scorso, con la sua dipartita. Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed
imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del
Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda
collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22
gennaio scorso, con la sua dipartita.
Ero andato a trovarlo pochi giorni prima, in seminario. Mi accolse, come
di consueto, con cordialità affettuosa ed insieme ricordammo fugacemente
, data la mia fretta, i begli anni condivisi nel servizio, a volte
faticoso, ma sempre gioioso. Ci lasciammo con il proposito di rivederci
presto. Ed invece...
Mons. Olivotto, per noi tutti don Rino, era rimasto affascinato dallo
Scautismo fin dal primo momento. Il rispetto delle regole, la lealtà, il
senso del servizio gratuito, l’entusiasmo dei giovani anche di fronte
alle difficoltà, la condivisione della fatica e della gioia, la
Spiritualità della Strada, il rispetto e l’amore per il Creato, pallido
segno visibile della bellezza del Creatore: tutto ciò era consonante con
la sua personalità. Aveva studiato al Collegio Capranica di Roma, lì
inviato dai superiori del seminario di allora, che avevano colto
l’intelligenza e le risorse umane di quel giovane prete. Ritornato,
insegnò per un trentennio Teologia morale in Seminario di Treviso.
Eppure la sua cultura non pesò mai nei rapporti interpersonali,
specialmente con i giovani che lo sentirono subito un loro fratello
maggiore, capace di capirli, di sostenerli e di incoraggiarli.
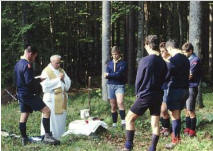 Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo
affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,
in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.
Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu
anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di
corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di
montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste
per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il
riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di
conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza. Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo
affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,
in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.
Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu
anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di
corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di
montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste
per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il
riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di
conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza.
Quella macchina gli serviva anche da riparo, perché, avendo tolti i
sedili da un lato, ne aveva ricavato un vano giusto per il sacco-letto.
Era felice di condividere
 con noi la gioia del fuoco da cucina e la
fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco. con noi la gioia del fuoco da cucina e la
fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco.
Amava moltissimo celebrare la Messa all’aperto, con l’altare allestito
sul luogo con i mezzi di fortuna che la natura ci offriva di volta in
volta. Si compiaceva di tutto ciò che il clan faceva, a partire dal
luogo scelto per il pernottamento. “Ma che bel posto!” esclamava, anche
se non sempre ciò corrispondeva a verità. Il suo ottimismo trascinava i
giovani e i capi, che sentivano in lui una solida presenza e un virile
aiuto.
Pur dotato di grande carisma, si adattò sempre umilmente alla
personalità dei capi con cui svolse il suo servizio, profondamente
convinto della laicità dell’Associazione. Dopo aver ascoltato la
relazione di un’attività ben riuscita, usciva con un’espressione rimasta
proverbiale: “Godo!” ad esprimere una profonda partecipazione
all’evento.
Di squisita attenzione umana ed educativa, costruì tutte le relazioni
interpersonali con profonda delicatezza, anche nei momenti più difficili
e con le persone di carattere spigoloso.
Caro don Rino, tu hai saputo infondere in tutti coloro che hanno avuto
la gioia di conoscerti, il senso promettente della vita, riuscendo a far
vedere, al di là delle difficoltà, un orizzonte positivo. Caro don Rino,
tu hai saputo con noi godere delle piccole grandi cose che il Creato ci
offre e ci hai fatto intuire che il cielo sereno altro non è che il
lembo azzurro del manto di Dio.
Buona strada, Gabbiano bianco!
↑▲↑
Da Azimuth 2-2017
Europa e Scouts d’Europa
Claudio Favaretto
I l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare
con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati
di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro
ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.
Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo
scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati
aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma
fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere
insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare
a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di
anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra
mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di
risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano
drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano
provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi
nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,
città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà
e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente
raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che
non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo
processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché
l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia
e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace
tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla
loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’
perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che
pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente
merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in
esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il
Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare
che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE
(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno
successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri
con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti
umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato
a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e
del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di
razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il
carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime
indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,
motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di
condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni
di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la
Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono
sempre contese. l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare
con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati
di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro
ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.
Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo
scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati
aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma
fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere
insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare
a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di
anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra
mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di
risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano
drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano
provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi
nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,
città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà
e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente
raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che
non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo
processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché
l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia
e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace
tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla
loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’
perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che
pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente
merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in
esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il
Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare
che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE
(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno
successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri
con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti
umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato
a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e
del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di
razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il
carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime
indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,
motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di
condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni
di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la
Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono
sempre contese.
Nel 1957, come si è già visto nacquero la CEE e l’Euratom. Dieci anni
più tardi i tre organismi sovranazionali esistenti vennero unificati e
coordinati da una Commissione Europea, sostenuta due anni dopo dal
Parlamento Europeo. Nello stesso anno nacque lo SME, Sistema Monetario
Europeo con il compito di evitare contrasti tra le divise dei vari
stati, in preparazione di una moneta unica.
 L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da
spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986
aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990
venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della
vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa
comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione
Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si
realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri
adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno
Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e
senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.
Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da
spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986
aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990
venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della
vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa
comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione
Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si
realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri
adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno
Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e
senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.
Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria,
Malta e Cipro. Sembrava che il sogno alimentato per molti anni dai più
sensibili statisti fosse finalmente diventato realtà.
Ma i problemi cominciarono a scuotere la costruzione europea,
soprattutto sotto la spinta di due imprevisti fattori: la disordinata e
massiccia l’immigrazione dai paesi del terzo mondo e la crisi economica.
Rispuntarono tensioni all’interno dei vari stati in cui cominciarono ad
affermarsi partiti politici antieuropeisti che attribuivano e
attribuiscono all’Europa la responsabilità delle difficoltà economiche e
sociali oltre all’insicurezza personale. Si è giunti pertanto alla
drammatica uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, in seguito ai
risultati del referendum del 23 giugno dello scorso anno, la famosa
Brexit. Ci vorranno due anni di trattative per giungere alla separazione
definitiva, ma la scelta inglese ha scosso l’Europa. Altri movimenti
antieuropei hanno preso coraggio da questo fatto soprattutto in Francia,
ma anche la nostra Italia non ne è immune.
Ma noi Scouts d’Europa siamo profondamente europeisti, a partire già dal
nome! Noi abbiamo sempre creduto all’abbattimento delle frontiere e alla
libera circolazione
delle idee e delle persone. Noi pensiamo che la fraternità
internazionale sia il più valido antidoto all’insorgere di tensioni,
rivalità e perfino odi tra i popoli. Per questo facciamo parte di una
UIGSE- FSE che significa Unione Internazionale delle Guide e Scouts
d’Europa – Federazione dello Scoutismo Europeo a cui appartengono ben 17
associazioni ufficiali oltre a cinque in attesa di riconoscimento. Per
questo partecipiamo di slancio agli incontri internazionali: dalle
Giornate Mondiali della Gioventù agli Eurojamboree e agli Euromoot. Ma
sono diventati frequenti anche incontri organizzati a livello locale tra
unità di nazioni diverse per esempio per i campi estivi di scout o di
guide ma anche di rover o scolte.
Forse non tutti i politici sanno quello che noi scout sappiamo. La
bandiera europea che sventola anche sui pennoni dei nostri campi ha un
significato profondamente religioso: l’azzurro ricorda il manto della
Vergine e le 12 stelle si rifanno alla citazione dell’Apocalisse laddove
si parla di una ‘Donna vestita di sole con una corona di 12 stelle’,
sempre a proposito della Madonna. E a Lei chiediamo di far sì che
l’Europa riprenda il suo cammino di unità, di giustizia e di pace.

↑▲↑
Intervento di Claudio al fuoco di
bivacco del centenario
31 luglio 2007 in Casa Scout Anna e Franco
Feder
RICORDO DI CHECCO
Mi è stato
chiesto di fare un breve intervento attorno a questo fuoco di
bivacco, di raccontare qualche aneddoto tratto dalla vita scout.
Ma questa
sera penso che sia importante dire una testimonianza di Checco. Per
uno strano disegno, il suo funerale coincide con il centenario dello
scoutismo che lui tanto capì, amò e fece amare. Di fronte ad una
personalità così grande e complessa ognuno di noi può aver colto
sfumature diverse e molto personali. Perché le personalità ricche si
possono leggere da molteplici angolazioni e mai completamente.
Io ero un
ragazzino quando lo conobbi, alla mia prima uscita di riparto, e ne
rimasi affascinato. Cercavo ogni scusa per andarlo a trovare a casa
sua, in vicolo Monte Piana, perché ero assetato di cultura. E lui
era molto colto.
Voi sapete
che ogni casa possiede un proprio odore: la sua sapeva di acqua
ragia, di colori ad olio, di mobili antichi.
Il mio
povero appartamento popolare a confronto era un niente.
Ricordo che
alle pareti c'erano dei suoi quadri, ma anche alcuni del nonno
paterno, pittore di valore anch'egli.
E poi
ceramiche dipinte, e alcune delle sue prime prove di artista, tra
cui un quadro con un glicine, se non ricordo male, che egli aveva
dipinto sul fondo di una scatola da scarpe quando aveva sedici anni.
E per me era già straordinario.
Ma la stanza
che mi piaceva di più era la «stanzetta Pipolini», dove c'era un po'
di tutto: scene di teatro dei burattini, tele, drappi, ricordi della
guerra che egli aveva vissuto sempre in quel luogo. In quella
stanzetta posai come Mowgli per dei cartelloni che servivano per la
mostra scout svoltasi nell'estate del 1954 a Palazzo dei Trecento.
Sempre a proposito della guerra, ricordo che mi raccontò che quando
c'erano
gli
allarmi aerei, la
famigliola, Checco, Gino e la mamma Dina, si
rifugiavano nella cantina, ospitando anche dei
vicini. Ma una notte fu bombardata la vicina caserma De
Dominicis e la paura fu grande. Mentre tutti
pregavano, egli confessò ad alta voce alla mamma di
essere stato lui a fare non so quale marachella.
Allora la signora Dina, donna di fiero carattere,
incurante delle bombe, gliele suonò di santa
ragione, nonostante l'intercessione dei presenti, per
i quali la mancanza commessa era nulla di fronte
al pericolo.
I nostri legami s’infittirono quando egli divenne
capo riparto. Ed allora io, come tanti dei presenti,
mi accorsi di quanta generosità, di quanto spirito di
servizio era capace. Spesso si licenzia
dal
lavoro per
venire al campo.
Erano gli anni meravigliosi del binomio Checco -Don
Ugo.
Bisogna ammettere che tutti noi che li abbiamo
vissuti siamo stati fortunati a crescere accompagnati
da persone così straordinarie e significative.
Ciascuno di noi si sentiva importante, grazie a loro, per
la vita del riparto.
Poi, con il passare degli anni, le distanze dovute all'età si
ridussero sempre più: tra quindici e
venticinque anni le distanze sono enormi, tra
ventidue e trentadue, molto meno.
Così nell'agosto del 1963 passammo insieme alcuni
giorni in una casera in Alpago: io studiavo e lui
dipingeva.
C'eravamo messi d'accordo con un vecchio contadino
che aveva la stalla poco lontano, che ci
portasse il latte la mattina. Ma il buon uomo
arrivava alle cinque e mezzo, bussando fragorosamente alla nostra
porta, gridando: «Giovinetti, il latte!» E Checco rispondeva
immancabilmente «se’l ‘ndasse
a farse...».
Perché bisognava riconoscere che Checco non fu mai
uno sportivo e per lui l'alba
era una cosa misteriosa e tormentosa.
Malgrado questo si sobbarcò imprese epiche come i due
campi in Francia, specialmente quello del
1972, quasi prova della futura nuova associazione,
che sarebbe nata nel 1976.
La storia più recente è conosciuta da tanti e
ciascuno ne conserva gelosamente nel cuore parole,
gesti, risa
e anche profondi dolori.
La perdita dell'Anna Maria lo segnò profondamente e
in modo definitivo.
Un giorno mi confidò: «Vedi, quando vedo una cosa
bella o faccio un bel quadro non so più a chi mostrarli».
Malgrado fosse circondato dall'affetto di tanti
amici, alcuni dei quali lo hanno assistito fedelmente ed
amorevolmente fino all'ultimo e ai quali va tutta la nostra
gratitudine si sentiva solo nell'animo.
E poi l'ictus che lo colpì dodici anni fa lo rese
ancora più solo.
Tutti noi abbiamo patito nel vedere una persona così
brillante e creativa, costretta al balbettio e all'inerzia.
Ma le espressioni del volto e degli occhi tradivano
la passata ricchezza interiore.
Per finire voglio solo aggiungere che sempre sono
rimasto impressionato dalla sua personalità e
dalla scelta profonda di servizio scout e più
schiettamente cristiano.
Un uomo così straordinario poteva pensare solo a se
stesso, alla sua carriera che si presentava
strepitosa se a vent'anni aveva già vinto il premio
Internazionale «Cittadella» per l'incisione.
Eppure aveva un animo così generoso che in gran parte
la trascurò, senza mai perderla, certamente,
per l'ideale scout.
E poi la dimensione creativa: io restavo incantato a
vedere uscire dalle sue mani un paesaggio
meraviglioso, o un volto, o una caricatura.
Tra l'altro scriveva in modo affascinante, prose e
poesie: queste abbiamo potuto goderle un po'
tutti. Grazie a Gianni che ce ne ha fatto conoscere
due abbastanza recenti.
E come dimenticare i suoi canti, sempre pieni di
slancio e di fiducia nell'avvenire, con quella Fede nella
Provvidenza che egli non ha mai abbandonato.
Possiamo dire veramente di essere stati fortunati ad
aver avuto un genio per amico e maestro.
Che il Signore lo ricompensi di tutto il bene che ha
fatto!
CASTORO DEL FIUME - Claudio.
Intervento
scritto di Claudio su Luciano Furlanetto in occasionedella mostra
degli acquerelli del 2014 al battistero del Duomo di Treviso
Ricordo di Luciano Furlanetto per tutti gli amici Ciano
Dividerò questo semplice ricordo in quattro parti:- l'amicizia-
lo scoutismo- gli affetti familiari- l'arte.
L'amicizia
Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, in seconda media. Lui era
già formato mentre io ero ancora piccolino, per cui i vecchi banchi
di legno di un tempo per Ciano erano troppo corti e per me troppo
lunghi. Diventammo subito amici e compagni di banco, con le
caratteristiche di cui sopra.
Lui era già bravo in disegno, materia in cui ero - e sono rimasto-,
una schiappa. Ma riuscivo bene in latino, per cui ci si aiutava nei
compiti domestici e questo rinsaldava ancor più il nostro sodalizio
che si ampliava anche con i discorsi e le reciproche confidenze che
costituiscono un sostrato importante nell'amicizia tra adolescenti.
Dopo la terza media le nostre strade scolastiche si divisero: Ciano
frequentò il liceo artistico, allora presente solo a Venezia, mentre
io mi avviai a malincuore verso un istituto tecnico industriale a
Mestre.
Ma la nostra amicizia non si interruppe, anzi si rafforzò per un
legame che da allora ci legò per sempre: lo scoutismo.
Lo scoutismo
In seconda media io divenni caposquadriglia e naturalmente cercavo
nuovi adepti. Cominciai a corteggiare Ciano che a quel tempo faceva
parte di una squadretta di basket della parrocchia di Sant'Agnese.
La mia perseveranza fu premiata e già nell'estate di quell'anno, il
1955, Ciano partecipò al campo estivo a Domegge di Cadore, con la
mia squadriglia, i Castori. Salvo
qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni
familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla
casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:
un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a
casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno
lasciato. Salvo
qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni
familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla
casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:
un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a
casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno
lasciato.
Insieme abbiamo percorso l'Italia e l'Europa per innumerevoli
incontri nazionali e internazionali, per campi scuola, per uscite,
per riunioni. La nostra collaborazione è stata costante e fedele,
tanto da diventare modello, anche per gli altri capi, di corretti
rapporti, cosa non sempre facile quando si lavora insieme.
La sua disponibilità e la sua lealtà erano veramente profonde. La
sua sensibilità lo portava a privilegiare i contatti umani e nei
campi scuola curava particolarmente la conoscenza e l'amore per la
natura, così come la profondità e la bellezza della liturgia.
Eravamo così affiatati che quando c'era un incontro al chiuso e non
in tenda, sceglievamo di dormire insieme per non disturbare gli
altri, visto che il nostro russare era simile al lavoro di una
segheria ed era ben noto ai vicini. Ma prima di addormentarci ci si
augura sportivamente "Vinca il migliore!".
Gli affetti familiari
E' questo un ambito così privato ed esclusivo nel quale non mi
permetto certo di entrare.
Dico solo che, da quanto ho potuto notare, Ciano è stato un marito
esemplare per attenzione e disponibilità, ed un padre preoccupato
per la crescita dei figli, verso i quali ha sempre manifestato
delicata ma continua attenzione educativa, unita ad un profondo e
rispettoso affetto.
L'ultimo piano affettivo è stato quello dei nipoti, nel cui
confronto era tenerissimo e pronto a registrare nel suo profondo
ogni gesto di affettuosa gratitudine.
L'arte
Conservo ancora il quaderno di caccia del 1955, nel quale Ciano mi
disegnò, ad acquerello, alcuni fiori che la nostra squadriglia aveva
raccolto per una "caccia natura", termine scout per definire una
ricerca sulla natura del luogo.
Questo per dire quanto sia stata precoce la chiamata all'arte
pittorica di Ciano. La sua è stata una vera vocazione che
fortunatamente per lui e per noi egli ha seguito per tutta al vita.
Per lui perché non c'è niente di più appagante che seguire la
propria vocazione, per noi perché abbiamo potuto godere per molti
anni della sua creatività.
Ciano ha utilizzato diverse tecniche nel corso degli anni, seguendo
l'impulso del momento o la richiesta della committenza. Così ha
usato l'affresco nella chiesa di San Floriano, la terracotta nella
chiesa della sua parrocchia, Sacro Cuore, la ceramica sempre a San
Floriano. Ma penso di poter dire che la tecnica prediletta sia stata
l'acquerello, probabilmente per la velocità di esecuzione unita alla
pressoché infinita scelta dei colori. Su un foglio di grana grossa,
egli tracciava con la matita veloci segni di contorno, poi intingeva
il pennello nell'acqua e sceglieva e creava le tonalità che aveva in
mente. Era stupefacente osservare con quanta sicurezza la mano
seguiva il pensiero creativo. Così ha disegnato anche durante i
lunghi giorni di degenza , quasi per lasciarci ancora un'ultima
testimonianza della sua bravura e della sua profonda fede.
E questa mostra lo testimonia.
↑▲↑
da Azimuth 5 2013
Altro ricordo
scritto di Claudio su Ciano
Ci conoscemmo sui banchi di scuola: era la 2a media, sezione F. La
scuola aveva sede in centro città, in un palazzotto del 1600, poco
adatto alla vita degli studenti e al di fuori di ogni attuale regola
antincendio, antisismica, senza vie di fuga, salvo quella
effettivamente usata delle scale al termine delle lezioni: era
proprio una via di fuga.
I banchi erano del tipo “compact”, in legno massiccio, con i
sedili facenti blocco unico con il piano di studio.
Per questo motivo, a me che ero piccolino, la distanza tra sedile e
piano risultava eccessiva, ma per Ciano, già sviluppato fisicamente,
era inadeguata per difetto, per cui le sue ginocchia sporgevano dal
piano di lettura.
Ciano era più alto di me, ma anche più grande, avendo ripetuto le
prime due classi. Egli non amava le materie teoriche, specie il
latino, ma aveva già una chiara predisposizione per il disegno.
Infatti, terminate le medie, frequentò con successo il Liceo
artistico.
Nacque così tra di noi un sodalizio negli studi, per cui ci si
aiutava a vicenda, maturando un po’ alla volta un’amicizia profonda
che, salvo qualche periodo dovuto alle necessità che la vita
talvolta impone con durezza, è durata fino all’altro giorno.
 Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,
un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua
esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo
consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo
nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta
parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo
squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,
non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori
non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello
Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento
educativo. Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,
un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua
esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo
consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo
nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta
parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo
squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,
non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori
non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello
Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento
educativo.
Vorrei ricordare alcuni episodi della nostra comune vita scout,
altrimenti mi sembrerebbe che il ricordo si riduca ad una
elencazione di qualità. Al campo del 1958, svoltosi a qualche
chilometro da Taibon agordino, lui era già aiuto capo e utilizzava
qualsiasi scusa per andare in paese con la Lambretta
dell’assistente, anche più volte al giorno, per portare la posta,
diceva lui. L’allora capo campo, l’indimenticabile Checco Piazza,
compose per Ciano la seguente canzoncina: “Il postino della Val
Bissera, va in paese da mattina a sera, dove va, chi lo sa, per un
bollo, per un bollo va in città!”.
In tutti noi nacque il sospetto che la “tabacchina” dove
egli acquistava i bolli, fosse una bella ragazza.
Per mancanza di spazio ricorderò solo un’altra caratteristica che
rinsaldò ulteriormente la nostra amicizia. Noi costituimmo la più
formidabile coppia di russatori che l’associazione abbia mai avuto!
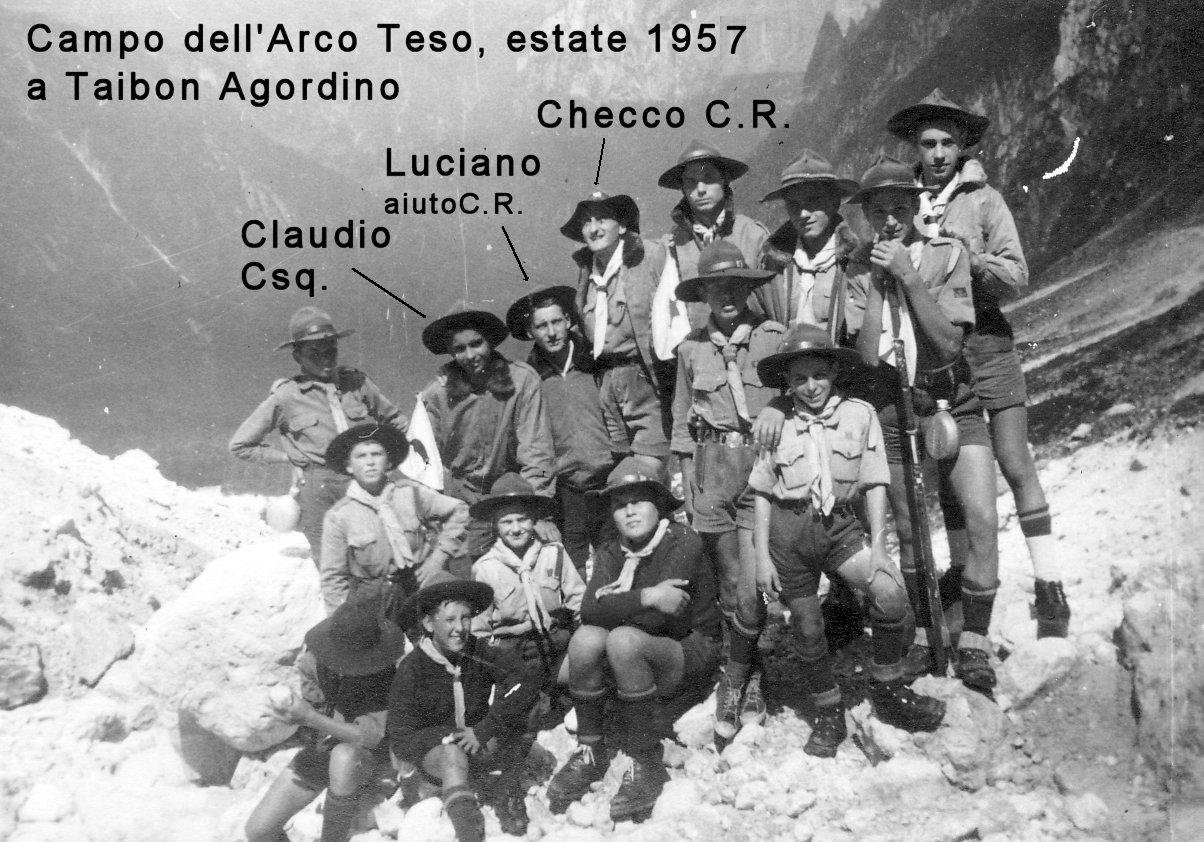 Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri
non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano
al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire
nella stessa camera. Ma prima di infilarci sotto le coperte ci
dicevamo: “Vinca il migliore!” e dopo poco cominciava la
battaglia. Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri
non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano
al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire
nella stessa camera. Ma prima di infilarci sotto le coperte ci
dicevamo: “Vinca il migliore!” e dopo poco cominciava la
battaglia.
Appartiene alla storia associativa anche la presunta presenza di
orsi ai Campi scuola di Genga, mentre si scoprì che si trattava
“semplicemente” di noi due concertisti.
Ciano è stato un capo straordinario che diede il meglio di sé
durante la preparazione e
lo
svolgimento dell’EJ di Viterbo: sua l’impostazione pedagogica che
vide sempre al centro l’utilizzo di quel formidabile strumento
educativo che è la squadriglia. Fu tra l’altro uno scrupoloso Capo
Campo in svariati campi scuola, dove riuscì a fondere, in un solo
omogeneo messaggio la tecnica, il metodo, la liturgia e la
spiritualità.
La nostra assidua frequentazione per le numerosissime riunioni
romane, ci portò a salutarci, anche quando ci si trovava a Treviso,
alla “romana”: “A Cià!” “A Clà!”.
Attento ed affettuoso in famiglia, nonno tenerissimo, Ciano godette
solo ultimamente l’apprezzamento del grande pubblico per le qualità
artistiche. Ricordo una Via Crucis dove si fusero la poesia in
acrostici di Luigi Pianca, le musiche inedite del maestro Antonello
e gli acquerelli di Ciano che, proiettati sul grande schermo come
accompagnamento visivo del racconto evangelico, suscitarono intense
emozioni nel vasto pubblico presente.
Nello scorso mese di dicembre fu allestita nel Battistero del Duomo
di Treviso una mostra intitolata “Vedere il Vangelo di Luca”,
composta da 290 splendidi acquerelli di Ciano, così coinvolgenti che
il presentatore si rammaricò che il vivere appartato e schivo di
Ciano avesse privato la cittadinanza della sua creatività pittorica.
A Cià, uomo buono e leale, amico sincero e fedele, che la tua
sensibilità artistica ed educativa gioiscano negli spazi infiniti,
sotto lo sguardo amorevole di Dio!
↑▲↑
Da DISEGNO SCOUT Forma, Stile e Metodo
Il valore educativo del disegno
nello scautismo
Claudio Favaretto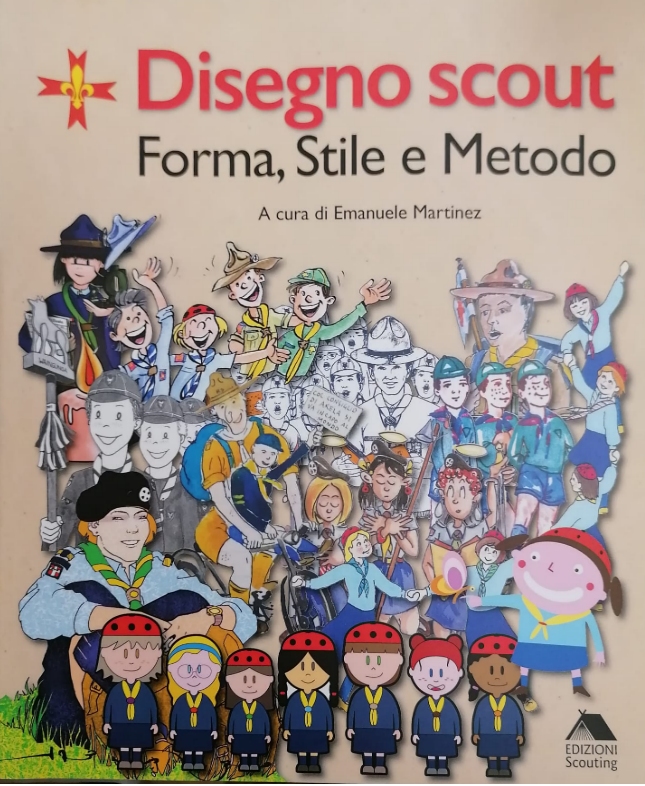
O
Signore, nostro Dio,…
se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi?
Eppure l’hai fatto poco meno che gli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato..
[Salmo 8]
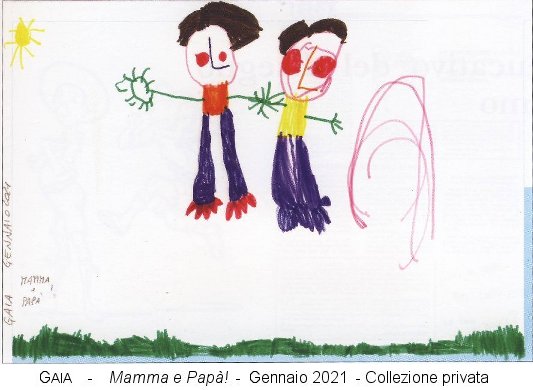 Solo l'uomo, infatti, è in grado di apprezzare l'opera di Dio, solo
l'uomo è capace di esprimere ed esternare i suoi sentimenti perché
sa usare delle forme di comunicazione che nessun altro essere
vivente è in grado di utilizzare: la parola, la musica, il canto, il
disegno... Solo l'uomo, infatti, è in grado di apprezzare l'opera di Dio, solo
l'uomo è capace di esprimere ed esternare i suoi sentimenti perché
sa usare delle forme di comunicazione che nessun altro essere
vivente è in grado di utilizzare: la parola, la musica, il canto, il
disegno...
È talmente grande il bisogno di esprimersi nell'uomo che lo si nota
fin dai primi giorni di vita: il balbettio, così come i gridolini,
lo stesso pianto sono mezzi di comunicazione.
Lentamente i bambini si impadroniscono del linguaggio orale, ma
sentono un impellente bisogno di comunicare anche in altro modo per
cui cominciano a fare degli scarabocchi con qualsiasi cosa lasci un
segno: matita, pennarelli, gesso, tizzoni spenti, e su qualsiasi
superficie: tavoli, pavimenti, piastrelle, muri, con grande
disappunto dei genitori che non sempre apprezzano questo aspetto
artistico dei propri figli! Ma a ben osservare ci si accorge che il
bambino cerca di rappresentare quella finestrella di mondo che via
via conosce: un fiore, un animale, la bicicletta, il sole,
l'arcobaleno. E se tu non capisci i suoi disegni, lui te li spiega.
Guai a ridicolizzare questi tentativi, perché significherebbe
interrompere il suo sistema di comunicazione.
Oltre al mondo esteriore, il bambino di tre-quattro anni sente il
bisogno di esprimere i suoi sentimenti, di comunicare gli affetti.
Ecco, quello che si allega è un disegno importantissimo: la piccola
Gaia, di quattro anni appena compiuti, ha rappresentato la sua mamma
e il suo papà. È una bambina felice, che vive il suo rapporto
familiare con grande serenità. Non ci sono grandi differenze tra le
due figurine, anche la loro altezza è uguale: sono entrambi preziosi
per lei.
Tra poco si sforzerà di disegnare anche i due fratelli più grandi e
poi tutto il suo mondo affettivo: i nonni, le maestre, le
amichette... Non sono importanti a quest'età le proporzioni né è
importante la somiglianza: l'importante è trovare lo strumento utile
a manifestare l'amore.
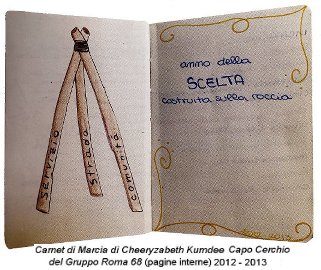 Questa
necessità di disegnare viene coltivata anche a scuola, alla materna,
alle elementari e alle medie. Poi si affievolisce fin quasi a
spegnersi, salvo in quei ragazzi che scelgono una scuola artistica o
professionale. Negli altri ordini di studio si predilige
l'educazione linguistica, per cui per moltissimi adulti la capacità
pittorica è ferma al tempo della terza media! Questa
necessità di disegnare viene coltivata anche a scuola, alla materna,
alle elementari e alle medie. Poi si affievolisce fin quasi a
spegnersi, salvo in quei ragazzi che scelgono una scuola artistica o
professionale. Negli altri ordini di studio si predilige
l'educazione linguistica, per cui per moltissimi adulti la capacità
pittorica è ferma al tempo della terza media!
Se gli insegnanti che la nostra Gaia incontrerà saranno bravi,
utilizzeranno il disegno non solo per far crescere le sue capacità
artistiche, ma anche come strumento educativo formidabile. Lo
scautismo è ben consapevole di ciò e vi pone la massima attenzione
fin dall'età Lupetto e Coccinella. A quest'età il disegno è
strumento prezioso per lo sviluppo delle capacità grafiche e
dell'abilità manuale, per l'auto-espressione, per l'acquisizione di
conoscenze, per l'educazione estetica, ma soprattutto per la
formazione del carattere.
Spesso i bambini sono disordinati, frettolosi, indisciplinati,
incostanti. Il disegno li aiuta alla precisione, li stimola a
portare a termine il lavoro iniziato, li sprona a curare il
risultato, li spinge a superare il divario tra l'idea e la
realizzazione.
L'età successiva quella degli Esploratori e delle Guide, ha come
fulcro educativo centrale la Squadriglia. E la vita di Squadriglia
stimola la creatività!
Come fissare il fascino dell'avventura vissuta, non letta né
ascoltata, ma partecipata? Come raccontare ai propri compagni di
classe le imprese realizzate?
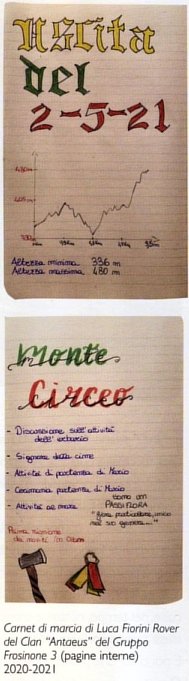 Certo
con le foto, ma soprattutto con il disegno: quello di un paesaggio,
della torretta di segnalazione costruita con le proprie mani, di un
particolare di un incastro difficile. La memoria storica diventa il
Libro di marcia di Squadriglia, il particolare volume all'interno
del quale vengono raccolte, nel tempo, notizie e cronache su
attività, uscite e campi; generalmente confezionato dagli stessi
ragazzi con una rilegatura in stile scout, è arricchito da disegni e
fotografie. Certo
con le foto, ma soprattutto con il disegno: quello di un paesaggio,
della torretta di segnalazione costruita con le proprie mani, di un
particolare di un incastro difficile. La memoria storica diventa il
Libro di marcia di Squadriglia, il particolare volume all'interno
del quale vengono raccolte, nel tempo, notizie e cronache su
attività, uscite e campi; generalmente confezionato dagli stessi
ragazzi con una rilegatura in stile scout, è arricchito da disegni e
fotografie.
E poi ci sono le prove di classe, le specialità, il Viaggio di Prima
classe.
Quante occasioni per utilizzare la propria capacità artistica e
fissarla nel Quaderno di Caccia personale! È questo un oggetto di
grandissima importanza perché spinge l'adolescente a migliorarsi
continuamente.
Per arrivare a questo punto, infatti, bisogna vincere alcune
caratteristiche tipiche dell'età come l'insicurezza, il timore del
giudizio altrui, la tentazione del non-finito, la frettolosità che
porta alla trascuratezza del proprio compito.
Il bravo Capo Riparto conosce questi aspetti del carattere degli
adolescenti e cerca di correggerli assegnando ad ogni squadriglia
delle missioni in cui, grazie alla collaborazione dei
capisquadriglia, ogni ragazzo sarà coinvolto per raggiungere la méta
comune.
Il disegno diventa ancora prezioso strumento educativo nel
superamento delle prove di classe e nella conquista delle
specialità.
Nella prova di conoscenza della natura, ad esempio, la riproduzione
delle nervature di una foglia, lo schizzo di un nido, la
rappresentazione di un seme portato dal vento, o di un fiore svelano
all'adolescente la bellezza del creato che ad un esame superficiale
inevitabilmente sfuggirebbe. E la bellezza suscita stupore nella
giovane anima che viene così sollecitata a riflettere su Colui che è
stato e continua ad essere l'Autore di una bellezza preparata
proprio per ciascuno di noi, purché siamo capaci di vederla!
In età Rover e Scolta il disegno diventa una delle chiavi più
importanti per conoscere quel mondo in cui il giovane si inserirà
con tutto il suo bagaglio di conoscenze, con la sua ricchezza di
idealità, con la sua forza morale. Così l'Inchiesta di Clan e di
Fuoco, la particolare attività di indagine e conoscenza
socio-culturale finalizzata ad approfondire un determinato
argomento, arricchita dai suoi schizzi, avrà il sapore di una
scoperta viva: la scoperta di un giovane uomo e di una giovane donna
capaci di interpretare e capire un paesaggio geografico, ma anche
antropico. Così certamente si stupiranno di fronte all'insolito
dipanarsi delle strade di un villaggio di montagna, agli edifici
civili e rustici, agli affreschi di una cappella solitaria in aperta
campagna o elevata sopra un colle dominante il paese, quasi a
proteggerlo. Cercheranno di capire le usanze di quel villaggio, la
sua cultura, le sue tradizioni. E le difficoltà del vivere e gli
strumenti per renderle sopportabili, come, ad esempio, la
condivisione del lavoro, del sostegno collettivo di fronte alle
disgrazie inevitabili. Ma anche la gioiosa partecipazione alle feste
patronali, con i canti, le danze, la cucina tradizionale.
Un giorno, in caso di necessità, anche i nostri Scout, Rover e
Scolte, saranno in grado di portare, il loro aiuto a quella gente
che hanno conosciuto nel loro andare, curiosi e intelligenti
pellegrini lungo la Strada.
In definitiva al momento della Partenza avranno interiorizzato la
fantasia creatrice del Lupetto e della Coccinella, lo slancio
avventuroso dello Scout e della Guida e l'esperienza di servizio del
Rover e della Scolta. E saranno in grado di distinguere tra la
faccia, cioè l'esteriorità, e il volto, cioè l'interiorità, di chi
incontrano nel cammino della loro vita.
Oggi il primo termine ha quasi totalmente sostituito il secondo. Ma
per il teologo e vescovo S. Isidoro di Siviglia, è il volto che
esprime lo svolgersi dei tempo con le fatiche e le gioie che la vita
riserva a ciascuno di noi.
↑▲↑
Genitori - figli: la fatica di crescere, la fatica di educare.
Il contributo dello Scautismo
Presentazione personale :
Mi sento un po' imbarazzato, perchè non ho particolari
titoli per parlare a voi sul problema educativo che, sicuramente, avrete
affrontato, chissà quante volte, nella quotidianità del vivere.
Ma non potevo dire di no a Marcello Cristofani, a cui mi legano amicizia
e stima da lunga data. Comunque, spero di non dire banalità in questa
conversazione, che avrei piacere si concludesse con uno scambio di idee,
perchè tutti noi viviamo la fatica di educare.
Io non sono nè uno psicologo, nè un sociologo. I miei titoli, e non sono
titoli accademici, sono i seguenti:
- sono un genitore di quattro figli : di 24, 22, 19 e 10 anni,
alternativamente femmina‑maschio, femmina-maschio, secondo una personale
ricetta segreta.
Ho, perciò, una certa esperienza in proposito
- sono insegnante da quando avevo 19 anni, cioè da subito dopo la
maturità. Sono stato e sono, quindi, sempre in mezzo ai giovani
adolescenti.
- sono un capo scout da quando avevo 20 anni. Pertanto, ho avuto modo di
vivere da adulto educatore in un ambiente profondamente coinvolgente,
insieme agli adolescenti.
Non ho, ovviamente, alcuna pretesa di insegnare qualcosa, ma desidero
solo fare con voi delle riflessioni ad alta voce, per ribadire, insieme,
una comune preoccupazione ed un comune sentire educativo.
Ed ora entriamo nel vivo del nostro argomento.
La difficoltà del rapporto tra genitori e figli non è una novità del
nostro periodo storico: c'è sempre stata, perchè è nell'ordine delle
cose naturali: una generazione cresce e vuole trovare lo spazio per sé,
la generazione precedente fa resistenza, perchè ritiene che essa non sia
ancora pronta ad occupare un posto nella società.
E' sempre stato così, e sempre lo sarà.
Io ricordo di essere stato impressionato quando, studiando letteratura
latina, mi sono imbattuto nella commedia di Terenzio "Il punitore di
se stesso" in cui si trattava proprio del rapporto tra padre e
figlio. Tenuto conto che Terenzio si era ispirato ad una commedia greca,
se ne può dedurre che, per lo meno dall'antichità classica, il problema
è sempre esistito.
Ma in che cosa consiste la difficoltà del rapporto tra genitori e figli
adolescenti?
Proviamo a precisarla.
1) Intanto sembra strana una cosa: un rapporto tranquillo e sereno,
quasi all'improvviso si guasta, lasciando sorpresi ed amareggiati i
genitori.
I genitori, che fino a poco prima sono stati quasi divinizzati dai
propri figli, ora si sentono trascurati, presi in giro, disobbediti.
Nascono, in noi genitori, le prime crìsi di coscienza, le prime domande
"Dove abbiamo sbagliato?" e, forse, le prime accuse : "Ti avevo detto
che non era giusto fare così, ma tu...!"
La crisi del rapporto con i figli attraversa anche i rapporti di coppia.
2) E' difficile il rapporto di coppia:
ciascuno arriva al matrimonio con la propria cultura, con i propri
pensieri, con la propria sensibilità, con la propria idealità. Il
periodo del fidanzamento dovrebbe servire a verificare se le due persone
sono spiritualmente "compatibili".
Ma quasi sempre si presenta la parte migliore di sé; si è portati a
sorvolare sui difetti del partner, per sottolinearne i pregi; quasi mai
si crea un confronto sulle cose fondamentali, quelle che dureranno il
resto della vita.
Queste diversità si manifestano, in modo particolare, quando si tratta
di educazione dei figli: se la coppia non è omogenea, si creano
facilmente contrasti, perchè ciascuno è portato ad agire, nei confronti
dei figli, come ha visto fare a casa sua, dai suoi genitori. E se le
educazioni ricevute differiscono profondamente, ciò si manifesterà
apertamente, dando vita al peggiore dei modi, quello divergente: cioè il
padre dirà una cosa e la madre lo contraddirà, il padre sottolineerà un
comportamento, a suo dire non corretto, e la madre affermerà che tale
non è, ecc., creando, nei figli, dapprima sconcerto, e poi la
possibilità di evitare confronti seri ed educativi.
3) il, rapporto tra genitori e figli è difficile per la natura stessa
delle cose:
• i genitori tendono ad essere conservatori, direi giustamente,
perchè desiderano conservare i valori in cui hanno creduto e credono.
Ma, alle volte, non distinguono bene i valori fondamentali da ciò che
può essere considerata una consuetudine, un modo esteriore di vita, una
moda legata al tempo. Faccio un esempio:
- il rispetto della persona, se stessa o altra, è un valore
fondamentale, che va strenuamente conservato
- la lunghezza della capigliatura è un fattore secondario, che magari
può dar fastidio, ma che non è fondamentale.
Eppure, tante volte succede che si mettano sullo stesso piano!
• i figli tendono ad essere innovatori, per cui sono portati a
criticare le consuetudini precedenti, perchè loro si sentono,
giustamente, moderni.
Ma, siccome a loro manca l'esperienza e la capacità di discernere,
bisognerà aiutarli a distinguere quello che vale da quello che non vale.
• i figli vogliono essere protagonisti,
• i genitori credono che non ne siano ancora capaci, li ritengono
ancora piccoli
• i figli si sentono audaci, sentono di possedere il mondo
• i genitori sono protettivi, vogliono difenderli dal mondo
• i figli vogliono fare la loro strada da soli, amano l'avventura
ed il nuovo, amano il rischio
• i genitori, per amore, desiderano spianare loro la strada dalle
difficoltà,
• i figli adolescenti aspirano ad essere considerati adulti, degni
di fiducia, aspirano ad essere trattati alla pari, dai genitori.
• i genitori credono che non sia giusto far partecipi i loro figli
dei pensieri e delle difficoltà familiari, sempre per amore, verrà anche
per loro - dicono- il tempo delle responsabilità: per il momento che si
godano la vita!
Io penso che se noi ci ricordassimo di come eravamo da adolescenti, in
gran parte troveremmo il modo giusto di comportarci con i nostri figli.
In questo rapporto così dialettico, lo scoutismo può aiutare molto, se è
fatto bene, da capi preparati.
Ho provato ad analizzare certe caratteristiche dei giovani, a ricercare
le cause di certi comportamenti, a proporre delle soluzioni familiari, a
definire il contributo che può dare lo scoutismo.
Naturalmente tale schema non pretende di essere esaustivo, ma spero che
possa avere una qualche piccola utilità.
| Caratteristiche
dei giovani |
Cause di certi comportamenti |
Soluzioni familiari |
Le proposte dello scautismo |
1) A
La cialtroneria, iI disordine, (poca cura delle, cose: libri,
motorino, bici, zainetti di scuola, scarpe, sci, vestiario). |
1.1)
E' tutto ricevuto gratuitamente, senza alcuno sforzo personale.
Una volta si diceva: "Se sarai promosso, ti regaleremo la bici."
Ed era una volta per tutte.
Oggi, con quattro asterischi, viene regalato il motorino.
I ragazzi non hanno più il senso del danaro, del sacrificio:
credono che sia loro tutto dovuto. Ed i genitori fanno di tutto
per farglielo credere. Il premio Nobel per la fisica,
Rubbia, ha dichiarato che "una sana povertà è alla base di una
crescita equilibrata ed attiva." |
1.2)
Dobbiamo far loro capire il senso della fatica, del valore del
denaro, che viene guadagnato con il lavoro dei genitori.
Dobbiamo far loro capire che tanta gente vivrebbe con il nostro
spreco. Dobbiamo far loro vedere la differenza tra ciò che è
utile e ciò che è superfluo. Dobbiamo far loro capire che sono
disoneste sia l'avarizia che la prodigalità.
Dobbiamo far capire cosa sono la giustizia e la carità: mille
lire date ad un povero valgono molto di più di una pizzetta,
magari sbocconcellata e dopo buttata via, perchè l'origano era
troppo! Ma noi genitori ne siamo convinti?
Non siamo noi, forse, per primi, quelli che accettano di
organizzare dispendiose feste di compleanno?
Non siamo forse noi che accettiamo che le scuole organizzino
gite scolastiche esageratamente costose, a cui inviamo i nostri
figli senza batter ciglio?
Anni fa mia figlia maggiore doveva andare in Grecia (prima liceo
classico).
Questa è prodigalità, è smarrimento del senso delle proporzioni.
Ma noi siamo capaci di dire di no, di spiegare tutto questo ai
nostri figli ed agli insegnanti, senza il timore di essere
giudicati dei pidocchiosi? Mia figlia fu l'unica della sua
classe a non andare in Grecia. Ma lo fece con maturità, dopo che
le spiegammo che per la nostra famiglia non sarebbe stato
giusto: sarebbe stato uno spreco di risorse. Ma gli altri
genitori, alcuni dei quali erano poveri quanto noi? |
1.3)
Il nono articolo della Legge scout afferma che "Lo scout è
laborioso ed economo".
La vita di squadriglia in sede, ma soprattutto all'aperto, al
campo, richiede cura del materiale: le tende, se non sono state
ben asciugate dopo l'ultimo acquazzone, si ammuffiscono,
diventando inservibili o almeno insicure. Il marteriale di
pionieristica non servirà a nulla se le accette non saranno
state affilate, le corde riposte con cura. La cassa di
squadriglia, formata con i piccoli risparmi settimanali, dovrà
far fronte alle nuove spese di cancelleria, a nuovi acquisti di
teloni impermeabili, per migliorare la vita al campo. Il
magazziniere starà ben attento a che qualche squadrigliere non
sciupi, per negligenza o imperizia, il materiale.
Ma anche il quaderno delle prove di classe richiede ordine,
altrimenti le prove non verranno superate e lo scout non
conquisterà le nuove mete: la seconda classe e la prima, o le
specialità. Ma anche il Libro d'oro, in cui si narrano tutte le
imprese compiute dalla Sq. dovrà sempre essere aggiornato e
tenuto con cura. |
1) B
La pigrizia |
1) B
E' tipica dell'età adolescenziale. ma è aumentata con il tipo di
società contemporanea in cui molti adulti non sanno più come
comportarsi con gli adolescenti ai quali sono disposti a far
tutto, pur di riceverne in cambio un riconoscimento affettivo. |
|
1) B
Tutta la vita scout è attiva: campi, uscite, attività varie
nelle quali sempre si richiede sveltezza di mente e di corpo,
perchè è una vita da vivere, da costruire, non da subire.
Bisogna far in modo che siano i ragazzi i protagonisti della
loro avventura scout: basta con le mamme che fanno lo zaino ai
loro figli, basta con i genitori che portano le tende in uscita,
basta con i genitori che accompagnano i figli al campo! |
2)
I nostri figli sono abulici, senza grinta, si scoraggiano
facilmente, non lottano, non hanno un progetto per il futuro,
non dimostrano interessi duraturi |
2.1)
Abbiamo tolto loro il gusto della conquista, dietro la
preoccupazione di alleviare la fatica di vivere che forse
abbiamo sostenuto noi. Quanti genitori dicono apertamente che
non vogliono che i loro figli facciano la loro stessa fatica? Ma
questo significa togliere a loro il gusto della conquista, la
bellezza di un traguardo raggiunto da soli. Significa privarli
anche del senso delle difficoltà, significa creare dei
velleitari, incapaci di valutare il concreto.
Significa farne delle persone fragili, indifese, che alla prima
difficoltà si smarriscono completamente. Tutta la società si sta
prodigando per far crescere i nostri figli deresponsabilizzati:
a scuola ci sono gli organi collegiali, a cui partecipano anche
gli studenti, con sostanziale apparenza piuttosto che sostanza,
c'è il ricorso al TAR in caso di insuccesso scolastico, c'è il
servizio civile, tante volte un alibi per evitare quello
militare, c'è la giornata per madri e fidanzate in caserma.
Ma quando cresceranno i nostri figli?
Non voglio dire che bisogna difendere certe forme
autoritaristiche del passato, ma voglio dire che i giovani
devono essere abituati a trovare dentro di sé le risorse morali
per accettare anche le prove che comunque la vita riserverà
loro. |
2.2)
Dobbiamo star loro vicino, con l'affetto e la comprensione, ma
dobbiamo lasciare che si prendano le loro responsabilità
progressivamente, secondo l'età.
Dobbiamo parlare con loro, ma per ascoltarli, perché loro hanno
già,' probabilmente,delle idee: dobbiamo solo aiutarli a dar
loro una forma più concreta.
La scelta della scuola, per esempio.
Quanti insuccessi scolastici sono dovuti ad una scuola scelta
dai genitori, per eccesso di affetto (così troverà una
professione più remunerativa), o peggio, per ambizione (mio
figlio frequenta il Liceo)?
Dov'è il rispetto per il figlio? Chi deve costruire la propria
vita?
Citerò solo due episodi che mi hanno colpito:
1) un mio compagno delle medie, figlio di medici affermati,
costretto a frequentare medicina, finito suicida dopo la laurea.
2) un genitore al quale il figlio scrisse, prima di suicidarsi,
di non aver mai saputo chi fosse, perché aveva fatto solo quello
che piaceva al padre, senza trovare la sua identità.
Ma ricordiamo anche l'episodio nel film "L'attimo fuggente". |
2.3)
Lo scoutismo abitua alla responsabilità progressivamente, senza
salti e senza forzature; ma anche senza indulgere a pigrizie,
fisiche o mentali.
Per ogni fascia d'età, esiste un percorso a tappe: la pista per
il lupetto, il sentiero per l'esploratore, la strada per il
rover.
Come vedete, sono tutti e tre termini che racchiudono in sé il
concetto di viaggio, di movimento.
Si è tanto ironizzato sulle piccole cose dello scoutismo, eppure
chi è educatore sa che le grandi cose si preparano pian piano. E
cosa c'è di più grande dell'aiutare un bambino a crescere fino a
diventare uomo?
Allora si può capire l'importanza di imparare i nodi (padronanza
delle proprie mani, memoria, sveltezza,) o apprendere l'alfabeto
semaforico o Morse(ormai abolito, quest'ultimo, perché superato,
nelle comunicazioni). Ma quanto allenamento mnemonico avrà
compiuto quel bambino o quel ragazzino, quanta padronanza di sé
avrà acquisito, trasmettendo da lontano, con le bandierine
bianche e rosse, controllando la posizione delle braccia,
affinché gli altri capiscano con chiarezza il messaggio?
In quale altro ambiente avrà potuto sentirsi utile così,
mediante il suo sforzo personale?
Io sono convinto che quando gli adolescenti si sentono utili ed
hanno delle responsabilità effettive, non tradiscono mai, perchè
ci metteranno l'anima per raggiungere la meta.
Ma si può continuare con gli incarichi di squadriglia, ogni
ragazzo ne deve svolgere uno, per il buon funzionamento di
questa piccola cellula sociale. Ecco, allora, il segretario, il
cassiere, il magazziniere, la cicala, ecc.; o i posti d'azione:
segnalatore, cuciniere, topografo, pioniere, ecc.
Ma naturalmente le responsabilità più grandi sono quelle di
caposquadriglia, a cui si giunge quando un ragazzo ha dimostrato
maturità e capacità per guidare un gruppetto di quasi coetanei.
In quale altro ambiente succede che un ragazzo di quattordici,
quindici anni abbia e senta la responsabilità di guidare
ragazzini di poco più giovani, in uscite di squadriglia, di
missioni, di servizi al prossimo?
E' questa la splendida risposta dello scoutismo! |
3)
I nostri figli sono poco comunicativi, poco affettuosi, poco
espansivi |
3.1)
E noi com'eravamo?
Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza comporta un
cambiamento profondo nel mondo affettivo.
I nostri figli non vogliono più essere trattati da bambini, non
vogliono più il bacino della buona notte: vogliono essere
trattati da grandi, vogliono una stretta di mano, una pacca
sulle spalle, un pugno affettuoso, come ci vedono fare con i
nostri amici.
Hanno pudore di mostrare quei sentimenti che precedentemente
esternavano in modo assolutamente spontaneo. E poi non
sopportano di sentirsi chiedere ogni giorno: "Com'è andata a
scuola?".
Ma nello stesso tempo aspettano che ci s'interessi a loro, alle
loro difficoltà, ma senza smancerie, da grandi, appunto. |
3.2)
Noi dobbiamo cercare di comunicare con loro, attraverso magari
formule nuove, fresche: messaggi lasciati sopra la loro
scrivania, lettere pensose su questioni importanti se il dialogo
si presenta difficile per loro e per noi.
Penso che apprezzeranno molto ricevere posta dai loro genitori!
Per avere le loro confidenze, bisogna sapersi conquistare la
loro fiducia fin da piccoli.
Quante volte, invece, li abbiamo snobbati, per un nostro
impegno, o li abbiamo costretti a noiose visite a parenti, senza
accondiscendere, almeno qualche volta, alle loro legittime
richieste.
E quante volte siamo andati con loro, soli, in bicicletta, o in
macchina, in luoghi affascinanti, a vedere la natura ed
ascoltarne i silenzi?
Magari li abbiamo forzati a venire con noi ad assistere ad una
partita di calcio, tra bestemmie ed insulti, o li abbiamo
costretti a visitare una mostra d'arte, o assistere ad un
concerto contro voglia, "perché fa cultura".
Ma è nell'intimità della passeggiata o dell'esplorazione che
nascono le confidenze, e quasi le complicità affettive, che
saranno preziose più avanti, quando i discorsi si faranno più
difficili, quando ci saranno le prime cotte, quando ci saranno
le prime crisi esistenziali.
Questo non significa che si debba diventare amici dei propri
figli, come, purtroppo, tanti genitori fanno.
Infatti, ci sarà il momento in cui i figli avranno bisogno non
di un amico, ma di un adulto, di una guida, cioè di un padre e
di una madre.
In tal caso, dove potrebbero andare se i propri genitori hanno
giocato a fare gli adolescenti? |
3.3)
Nel rapporto educativo tra il capo ed il ragazzo, si apre un
nuovo capitolo della vita dell'adolescente.
Spesso è proprio il capo a venir a conoscere i problemi che il
ragazzo non confida più ai propri genitori, per quel senso di
pudore di cui si parlava.
Il ragazzo si apre volentiri con chi gli dà fiducia, al di fuori
della famiglia, perché un po' si vergogna di essere stato
bambino. Ora vuole essere trattato con serietà. Teme di essere
trattato dai genitori ancora come un piccolo, mentre lui si
sente già grande, anche se talvolta teme il futuro. E' un fatto
molto importante il legame che si crea tra ragazzo e capo, anche
perché salvaguardia un rapporto verticale, quando i ragazzi
tendono,invece, a costruire rapporti orizzontali, tra coetanei,
perché così non si sentono giudicati. Ma tale rapporto non crea
crescita, che nasce solo dal confronto con l'esperienza di un
adulto che può testimoniare che gli ostacoli di quell'età
possono essere superati serenamente.
Quando il ragazzo sarà cresciutoallora ritornerà ad aprirsi con
i genitori, ma da pai a pari, adulto tra adulti.
Ai genitori è richiesta questa prova di pazienza, se non
vogliono guastare tutto. |
4)
I nostri figli hanno smarrito il senso religioso |
4.1)
E' un processo complesso, attraverso il quale siamo passati
tutti, più o meno.
Anche in questo campo bisogna avere la saggezza di saper
aspettare, anche se può far male vedere il proprio figlio
allontanarsi dalla pratica religiosa, in particolare dalla
frequenza ai sacramenti e alla messa.
Ma anche questo fenomeno è ascrivibile alle mutate condizioni
psicologiche dei nostri ragazzi che stanno crescendo.
Hanno bisogno, infatti, di buttare all'aria tutto quello che
ricorda loro l'infanzia, per ricostruirlo e riscoprirlo da
adulti.Come dire:"prima andavo a messa perché mi ci mandavano,
ora ci vado perché lo voglio io!".
Ma bisogna saper aspettare con fiducia, senza forzare i tempi di
una maturazione che deve essere solamente personale. |
4.2 )
A noi genitori non resta che continuare a testimoniare la nostra
fede con naturalezza e spontaneità.
Si può invitare esplicitamente il proprio figlio a partecipare
alla messa insieme a tutta la famiglia in occasione di feste
particolarmente importanti, o in occasione di qualche
ricorrenza, lieta o triste. Questo può far capire che esiste un
legame tra i membri della famiglia che è anche di ordine
spirituale: la fede non è solo una dimensione fanciullesca, ma è
una scelta da grandi, è un valore adulto e perenne. Ciascuno di
noi crede, perchè qualcuno gliel'ha insegnato e testimoniato, su
su fino ai primi evangelizzatori agli apostoli.
Allora, in questo modo, la fede assume un respiro più grande,
più eroico, com'è giusto che sia per gli adolescenti, |
4.3)
La fede testimoniata dai genitori sa troppo da asilo, quando si
appresero da loro le prime preghiere. E in questa fase di
rifiuto dei genitori, naturalmente vengono malviste anche la
fede e la conseguente pratica religiosa.
La vita scout può aiutare molto a superare il problema di questo
rigetto.
Prima di tutto c'è la testimonianza del Capo per cui
l'adolescente comincia a credere che la Fede non sia più, come
pensava, una cosa da bambini, perchè evidentemente, se la
pratica il capo, ammirato per tante altre cose (sa inventare i
giochi, sa organizzare le uscite ed i campi, sa richiamare e
lodare, ecc.), dev'essere una cosa seria, roba da grandi.
Poi ci sono i coetanei scout, tra i quali il caposquadriglia,
sicuramente in gamba, che partecipano alla messa senza problemi,
e senza storie.
Poi ci sono le messe al campo, in cui è perfino bello sentirle
parte della propria avventura: l'altare è quello preparato da
noi, i fiori li abbiamo raccolti noi, il servizio liturgico è
svolto a turno tra le squadriglie, i canti sono i nostri.
Insomma, anche la messa è nostra!
La vita all'aperto, inoltre, offre al ragazzo, innumerevoli
occasioni di riflessione.
B.P. diceva che lo stupore che un ragazzo prova di fronte alle
meraviglie del creato è già l'intuizione dell'esistenza di Dio.
E dalle veglie alle stelle, dalle preghiere attorno al fuoco che
si spegne, nascono, pian piano nei ragazzi le domande sulla
propria vocazione. |
5)
I nostri figli hanno smarrito il senso morale |
5.1)
Da molto tempo ormai è in atto un'erosíone continua e subdola
dei valori morali.
A sentire certi mass media, sembrano segni di progresso la
libertà sessuale, le esperienze prematrimoniali, la libertà di
coppia, le convivenze, ecc.
Sembra che sia tutto accettabile, perchè presentato dalla TV.
Nessuno si scandalizza più, perchè ha paura di essere tacciato
di retrogrado, o perchè non sa come reagire a questa continua
corruzione. |
5.2)
Dobbiamo essere in grado di parlare ai nostri figli, non
attraverso i divieti, ma attraverso quello che ancora e sempre
sarà una caratteristica dei giovani: il sentimento. Dovremo
essere in grado di far capire la bellezza del rispetto di sé e
degli altri, perchè siamo fatti a immagine di Dio, il che
significa che anche noi profumiamo di infinito, di immortale,
sìa nell'animo che nel corpo, anche lui eterno, attraverso la
resurrezione della carne. Dobbiamo cercare di far loro capire
che i nostri gesti non sono mai insignificanti, ma devono essere
rivolti al bene, perchè è quella la nostra vocazioine. Dobbiamo
far capire che l'unione fisica o è un atto che si riverbera
nelle stelle perchè è cosmico, perchè può dar vita ad un essere
immortale, oppure diventa un gesto volgare, vergognoso,
animalesco, corrotto e corruttore. Forse i nostri figli hanno
più bisogno, dei giovani del passato, di ragionamenti, di
riflessioni per dare a loro stessi delle risposte che forse per
noi erano più scontate, perchè più condivise dal mondo che ci
circondava.
Certo che i genitori devono essere loro, per primi, convinti dei
valori che vogliono difendere nei propri figli. E invece,
purtroppo, succede che alcuni vogliono farsi vedere moderni e
comprensivi dai propri figli, per cui dicono loro che, piuttosto
che vadano clandestinamente in un albergo con la ragazza, basta
avvisare: saranno i genitori ad andarsene opportunamente, per
lasciare la casa a loro disposizione!
Su questo argomento ci sarebbero molte cose da dire, come ad
esempio, la moda di trascorrere le vacanze insieme, ragazzo e
ragazza. Bisogna saper cosa argomentare, perchè saremo sempre
più assediati. |
5.3)
Si può recuperare il senso morale nei giovani solo all'interno
di una formazione integrale della persona.
Solo un metodo educativo che proponga forti idealità potrà far
resistenza alla continua erosione morale in atto. Ecco perché il
nostro metodo punta tutto sulla formazione del carattere, sulla
padronanza di sè, sulla generosità, sul rispetto degli altri,
sul senso di cavalleria, che altro non è che una forma di
rispetto e generosità.
Inoltre il nostro scoutismo, forse l'unica associazione
educativa giovanile in Italia, propugna l'educazione parallela,
ma separata fra ragazzi e ragazze, quella che noi chiamiamo
"Intereducazione".
I motivi che hanno portato la nostra Associazione ad una scelta
così caratterizzante sono:
1. il desiderio di rafforzare, per gli uni e per le altre,
l'alterità specifica, prima di quella complementare, cioè le
proprie caratteristiche di virilità e di femminilità, senza che
queste siano disturbate da una confusa promiscuità, che
nuocerebbe allo sviluppo armonioso di entrambi i sessi.
2. il desiderio di facilitare il dipanarsi sereno della
personalità, seguendo attentamente la psicologia degli
adolescenti, particolarmente complessa e delicata, senza
affrettate e premature sollecitazioni di ordine affettivo, senza
sprechi di energie psichiche, lasciando, invece, il tempo
necessario affinché ciascun ragazzo e ciascuna ragazza si
interroghi e trovi dentro di sé le occasioni propizie per
riflettere su una scelta vocazionale sia essa di ordine
religioso che matrimoniale, all'interno di un ambiente educativo
omogeneo.
3. il desiderio di promuovere il più ampio sviluppo educativo,
per costruire un uomo ed una donna di carattere, utilizzando il
metodo scout nella sua totalità, impedendo che questa ricchezza
venga dissipata dalla presenza polarizzante dell'altro sesso.
4. il desiderio di educare all'altra persona, di sesso diverso,
in un contesto di forte carica educativa ed adatto alle varie
età. Tali contesti saranno vissuti attorno a ben motivate
attività di servizio, di testimonianza, di preghiera, di
espressione, di presenza nel quartiere, creando un'amicizia
generosa e laboriosa, moralmente sana. Data l'enorme carica
emotiva suscitata dalla vita all'aperto, questa sarà sempre
vissuta separatamente dalle due sezioni, all'interno delle
proprie unità. |
6)
I nostri figli non sopportano le regole, gli orari, ecc. |
6.1)
La nostra società è diventata giovanilistica, nel senso che
protegge in tutti i modi i giovani, apparentemente, facendo
credere loro che si diventa grandi con la trasgressione
all'autorità, in primis a quella dei genitori, ma anche degli
insegnanti, dei sacerdoti, degli adulti in genere.
Ora c'è sempre stata una specie di contrasto tra i genitori ed i
figli, come ho già detto, perchè i figli aspirano alla libertà
dei comportamenti e del tempo. E questo è giusto, nel senso che
devono fare le prove di autonomia per il futuro.
Ma cessa di essere giusto, quando l'autonomia diventa anarchia. |
6.2)
E' necessario che i genitori usino il discernimento tra le
richieste legittime e quelle inaccettabili dei figli.
La famiglia ha delle regole che sono anteriori alla loro
nascita: sono delle regole necessarie per la convivenza, per
l'esistenza stessa della famiglia. Sono regole a cui sottostanno
anche i genitori: come quella della puntualità, della
collaborazione, degli sforzi individuali e comuni, per il
benessere della famiglia intera. Allora un figlio non può andare
dove, quando e con chi gli piace, pena lo sfaldamento della
compagine familiare.
Così, è inaccettabile che non ci sia un limite per il ritorno
del dopo cena; è inaccettabile che i genitori restino in
pensiero fino alle ore piccole, perchè i figli sono usciti in
discoteca o per partecipare ad una delle numerosissime feste che
vengono di continuo organizzate.
E' una battaglia difficile da condurre da soli, ma se ci si
mette d'accordo tra genitori, se si riesce a cambiare un po' il
clima che respirano i nostri ragazzi, ci si riuscirà.
Comunque, si riesce anche da soli, se si ragiona con i propri
figli: ma bisogna esserne convinti!
Io penso, però, che la migliore ricetta sia aiutare i nostri
figli ad assumersi degli impegni in associazioni giovanili, che
forniscano ideali di generosità, di altruismo e di eroismo, di
cui i giovani sono sempre assetati.
I giovani sono capaci di fare grandi e bellissime cose se solo
gliene offriamo l'opportunità: servi nelle zone terremotate,
aiuto ai più poveri ecc.
Ma noi genitori non dobbiamo aver paura che si facciano male,
che prendano freddo, ecc, perchè altrimenti non ci resta che
subire le loro iniziative stupíde: il tornare a casa alle
quattro di mattina è per loro un'azione eroica, se non trovano
niente dì più grande da fare! |
6.3)
Lo scoutismo può aiutare molto le famiglie in questo ambito,
perché pretende la puntualità ed abitua alla corresponsabilità.
La vita sociale all'interno delle unità scout può funzionare
solo se tutti portano il loro piccolo, ma necessario,
contributo.
Porto un piccolo esempio: la cucina al campo. C'è bisogno di uno
scout che accenda il fuoco, di due che vadano a legna, di uno
che la spacchi, di due che preparino le pietanze e le cuociano.
Al campo si impara senza tante prediche che la collaborazione è
indispensabile! Ma così anche per i grandi giochi, le
costruzioni, la segnalazione, la topografia.
Noi pensiamo che questo tipo di collaborazione torni poi anche
in famiglia, come il senso della puntualità e l'intraprendenza.
Non può esistere uno scout fannullone , come non può esistere
uno scout che non sia puntuale. C'è da dire anche, che i giovani
apprendono il senso della responsabilità.
Davanti a casa mia, il sabato sera si incontrano dei rovers e
delle scolte o giovani capi per recarsi poi in qualche meta,
spesso a casa di uno della combriccola. Ma a mezzanotte i miei
figli sono a casa, perché il giorno dopo hanno attività, per cui
non possono dare il cattivo esempio, arrivando in ritardo,
proprio loro, a messa. Che figura ci farebbero con i loro
lupetti o scout? |
7)
I nostri figli sono spesso egoisti.
|
7.1)
E' tutta l'atmosfera che si respira
attorno a noi intrisa di egoismo.
In modo particolare le sollecitazioni alle feste, alla moda,
alle discoteche, agli spettacoli, tutti impegni per far fronte
ai quali si spendono parecchi quattrini senza discutere, mentre
per partecipare ad una sottoscrizione a favore di qualche
infelice, i soldi non ci sono mai.
Ma non c'è neppure il tempo per
aiutare chi ha bisogno. Si preferisce organizzare un'assemblea
di Istituto per parlare dei problemi dell'immigrazione, ma
nessuno si preoccupa poi concretamente di aiutare la famiglia
accanto. |
7.2)
L'educazione e la sensibilità che si respirano in famiglia sono
fondamentali per superare l'egoismo che è una caratteristica
dell'età giovanile, specialmente attorno ai 15-18 anni.
Se la famiglia è attenta ed aperta, se i genitori sono impegnati
in qualcosa a favore di altri, parrocchia, catechismo,
associazioni di volontariato, allora anche i figli assorbono
questa dimensione.
Altrimenti passeranno il loro tempo in modo egoistico e quasi
narcisistico. |
7.3)
Lo scoutismo abitua fin da piccoli all'attenzione all'altro: i
Lupetti sono sollecitati a compiere il "tiro birbone", gli scout
a compiere la B.A. (la buona azione quotidiana) a favore di
qualcuno, i rover hanno come motto "Servire".
Se i capi sono attenti, progressivamente si instilla nei giovani
questo senso di altruismo.
Del resto B.P., il fondatore, scrisse che "La felicità nasce dal
far felici gli altri".
Così si scoprirà che non è vero che i giovani sono egoisti: essi
hanno bisogno di fare il bene in modo attivo, devono scorgere un
pizzico almeno di avventura in quello che fanno.
Ecco perché rispondono in modo entusiasta quando si tratta di
affrontare disagi, freddo, difficoltà per portare soccorso alle
popolazioni colpite da calamità naturali.
Ma sono altrettanto generosi nel servizio nei treni per Lourdes,
o per le feste degli anziani.
Questospalanca il loro cuore, perché risponde al loro bisogno di
eroismo.
Se non lo trovano qui, crederanno che tornare a casa alle cinque
di mattina dalla discoteca sia un'azione eroica! |
Conclusione
Per concludere, vorrei dire delle cose belle, per spalancare le finestre
dell'ottimismo, della fiducia nel futuro nostro e dei nostri figli.
Desidero citare tre autori, a nostra speranza.
Il primo è Quintiliano, educatore del tempo degli imperatori Flavi.
Egli dice che il successo del figlio dipende molto dalla fiducia che il
genitore nutre su di lui. Come dire che, quando nasce mio figlio, sarò
io il primo a credere che avrà una buona riuscita. Ed il bambino
crescerà in un ambiente che gli darà sempre una spinta morale perchè
egli si sentirà circondato da stima e fiducia.
Il secondo è Angelini che ha scritto un libro molto bello intitolato "Il
figlio"
L'autore contesta il termine educazione che, etimologicamente, significa
"tirar fuori".
Egli afferma, invece, che i genitori dovranno garantirgli il senso
promettente della vita, per cui sarà per lui una gioia cercare dentro di
sé il meglio, perchè vede che i genitori gli stanno testimoniando che la
vita è bella e degna di essere vissuta alla grande.
(Mi vengono in mente certi genitori che non vogliono battezzare il loro
figlio da piccolo, per non violentare la sua coscienza: quale senso
promettente della vita stanno trasmettendo?"
Terzo autore Hillman, uno psicologo di cui è recentemente apparso un
libro affascinante intitolato "Il codice dell'anima".
Egli afferma che la psicologia ha schematizzato il mondo umano, per cui
chi non è dentro ai suoi schemi è un anomalo, un soggetto da curare,
mentre egli afferma che la creatività è anormale, che i geni tutti sono
anormali e che tutti noi, in qualche modo siamo anormali, perchè
semplicemente non esiste norma, in quanto siamo tutti diversi.
Ma l'aspetto che più mi ha affascinato è stata l'esposizione della
teoria della ghianda, che si rifà al mito di Er , esposto da Platone
alla fine della sua opera "La Repubblica".
Secondo questo mito, l'anima si sceglie, prima di venire al mondo, un
destino, cioè una vita dentro un corpo particolare, in un dato ambiente,
con dei precisi genitori, ecc.
L'anima è accompagnata da un daimon, una specie di angelo custode. Al
momento della discesa dell'anima nel corpo, ella dimentica tutto, ma non
il suo daimon, che continuerà tutta la vita a ricordare qual è il
destino che lei aveva scelto.
Ecco, perciò, l'idea splendida della nostra vocazione: ciascuno di noi
ha una vocazione, la ghianda, e noi saremo felici ed in pace con noi
stessi solo quando l'avremo scoperta e seguita, fino a farla diventare
quercia.
Uno degli errori più gravi commessi dagli adulti è quello di non seguire
più il proprio daimon, perchè lo si è tradito o non lo si è ascoltato,
ma ci si immedesima in quello che si crede sia il daimon del proprio
figlio: e così si tradisce due volte, sé stessi ed il figlio.
Quando mio figlio diventa la mia ragione di vita, significa che ho
abbandonato la ragione invisibile della mia vita.
Dobbiamo, invece, amare la nostra vocazione e convivere con il suo
esigente amore per noi.
Ci sono tante altre splendide intuizioni, ma mi fermo qui per dire che
dobbiamo sentirci anche un po' meno preoccupati se crediamo che
effettivamente esiste un disegno provvidenziale per i nostri figli, ma
anche per noi. Ed allora noi genitori avremo il compito di aiutare a che
tale destino si compia, senza credere di essere noi, alla fin fine
coloro che creano il destino, fortunato od infelice, dei nostri figli,
che è una delle cose che più angosciano i genitori.
Sono i figli che hanno nelle loro mani il loro destino.
Claudio Favaretto
↑▲↑
In occasioine del San Giorgio 1999, a quarant'anni
dalla scomparsa di don Ugo de Lucchi
UN RICORDO ED UN INSEGNAMENTO INDELEBILI
Ho avuto la fortuna di trascorrere i miei anni in Riparto mentre don Ugo
era Assistente, ed ho avuto l'amaro privilegio di vederlo morire.
Era il 23 Aprile 1959, nel pomeriggio.
o, allora novizio rover, mi trovavo in sede ad aiutare una Sq. in vista
del S.Giorgio ormai prossimo. Venne un ragazzino, uno di coloro che
studiavano il piano con lui, pallido e spaventato, a chiamarmi dicendo
che don Ugo stava male. Mi recai subito nella sua cameretta, ma ormai
egli stava rantolando e il dottore, sopreggiunto poco dopo, non potè che
constatarne il decesso.
Allora l'emozionie e il dolore mi vinsero e, presa la bicicletta, fuggii
piangendo; è stato quello il mio passaggio dalla giovinezza alla
maturità, il primo contatto doloroso con la morte.
Don Ugo fu un adulto sensibile e attento alle necessità di noi ragazzi;
sapeva parlare con noi, conosceva le nostre ansie, i nostri turbamenti,
le nostre pigrizie e i nostri slanci. Ci sosteneva nelle difficoltà che
un caposquadriglia incontrava; davanti alla delusione provocata da un
ragazzo che lasciava la squadriglia, affermava che Gesù aveva scelto i
dodici Apostoli, eppure uno lo tradì: anche noi dovevamo accettare la
durezza dell'abbandono.
Fu veramente per noi un maestro di educazione ed un modello cui
continuammo e continuiamo ad ispirarci: tutto lo scautismo trevigiano
attualmente della FSE è nato dalla sua profonda conoscenza, dalla sua
intuizione e, soprattutto, dal suo modo di essere disponibile.
La sua disponobilità, poi, per noi scouts era totale.
Ricorderò solo un episodio: rientrati tutti bagnati da un'uscita di
Riparto, ci ospitò nella sua stanza, ci asciugò i vestiti e ci rifocillò
affinchè tornassimo a casa vispi e asciutti.
Veniva al campo in Lambretta, con la quale doveva rientrare in
Parrocchia a celebrare le messe nei giorni festivi; non potendo vivere
in tenda perchè portava un pesante e fastidioso busto di gesso da quando
aveva subito una grave malattia, si adattava a dormire in ambienti di
fortuna, come la famosa casera di S.Lucano.
Fu modello anche di semplicità di vita. La sua stanza era proprio il
segno della "garrula povertà" e dell'ingegnosità: da un vecchio
pianoforte aveva ricavato un mobile, da un sedile di corriera un
poltrona. Ci si sentiva ospiti attesi ed amati.
Per suo merito sono cresciute generazioni di giovani con il gusto del
bello, con il piacere del servizio, con un profondo senso del divino.
Claudio Favaretto
↑▲↑
Presentazione della proposta di
formazione di una associazione di genitori del Gruppo TV2° (anno 1991)
I Vescovi del Triveneto in un messaggio indirizzato al mondo della
scuola, in apertura dell'anno scolastico, affermano che, in mezzo alle
mille voci e ai cambiamenti del nostro tempo, una domanda si fa sempre
più distinta ed è una domanda di educazione.
"Questa domanda di educazione passa attraverso fenomeni preoccupanti
come il disagio giovanile, i fallimenti della vita personale e
familiare, dentro a tante banalizzazioini dello stile di vita, dei
consumi, del linguaggio.
Questa domanda di educazione è soprattutto domanda di figure adulte
significative che possano diventare autorevoli e rasserenanti compagni
di viaggio dei giovani verso la libertà e la responsabilità". Perciò,
aggiungo io, pare che non sia giusto attribuire alle giovani generazioni
colpe che non sono loro, ma, piuttosto degli adulti che sono mancati al
loro fianco, specialmente in quei momenti cruciali della propria vita e
in quegli ambienti previlegiati per la valenza educativa che possiedono
o che dovrebbero possedere. Dobbiamo, insieme, avere il coraggio di
esaminarci nella nostra testimonianza educativa e dobbiamo anche avere
la lucidità per vedere se gli ambienti educativi tradizionali sono
ancora validi. A mio parere, pur nelle complessità della vita
contemporanea, le agenzie educative più importanti sono ancora quelle
della notra esperienza giovanile e cioè:
1) la parrocchia
2) la scuola
3) la famiglia
4) lo scautismo
Cerchiamo di esaminarne gli aspetti ancora positivi ed, eventualmnete,
le zone d'ombra.
LA PARROCCHIA
E' molto cambiata negli ultimi 30 anni, sotto la spinta di una "cultura"
certamente diversa rispetto a una volta.
Quando parlo di cultura intendo un modo diverso di sentire, di
comportamento, di costume.
Bisogna anche pensare che l'ambiente parrocchiale era allora uno dei
pochi offerti ai ragazzi, mentre oggi essi essi possono scegliere tra
infginite possibilità. Oggi siamo tutti diventati più "nomadi" o più
"mobili", percui anche la presenza fisica è diminuita specie il sabato e
la domenica. Inoltre la disponibilità dei sacerdoti è sicuramente minore
ed il cappelllano, dove esiste, è preso da mille impegni ed il suo tempo
è frazionato in mille attività.
Questo, certamente, porta ad una minore incisività nei rapporti con gli
adolescenti e con i giovani: oggi il cappellano lo si trova solo su
appuntamento, non spontaneamente come un tempo.
Infine le molteplici attività parrocchiali sono difficilmente
armonizzabili, anche a livello semplicemente giovanile. Infatti le méte
che le varie attività si propongono non sono omogenee e ancor meno i
mezzi per raggiungerle. I tentativi di fare qualcosa insieme risultano
difficili, propprio per questi motivi e, a volte, si risolvono in
evidenti forzature.
A me pare che una delle differenze più importanti - e parlo sempre e
solo sul piano educativo - sia la seguente: che lo scautismo attira i
ragazzi con il fascino della sua proposta, ma in cambio richiede fedeltà
di presenza ed inpegno di coerenza, mentre per lo più, in altri ambienti
si offre qualcosa ma si pretende molto poco per cui i ragazzi vengono
molto gratificati e molto poco impegnati.
Lo scautismo è educazione del fare , è educazione dell'imparare facendo,
è concretezza di impegno, è la gioia che nasce dall'averlo superato
insieme ad altri.
Non è l'educazione del parlare senza sporcarsi le mani, del giudicare
senza provare in concreto la fatica di costruire qualcosa di tangibile.
LA SCUOLA
Tutti noi qui presenti abbiamo esperienza di scuola per mezzo dei nostri
figli e, per diversi, anche per la professione svolta. Conosciamo quindi
la complesità di questo ambiente e la conseguente difficile analisi,
sempre dal punto di vista educativo.
Non è possibile perciò generalizzare ma cercherò di evidenziare gli
aspetti più notevoli del problema.
Molto dell'incidenza dell'ambiente scolastico sui nostri figli dipende
dai singoli insegnanti perchè manca una comune preoccupazione educativa;
ognuno va in ordine sparso.
Per alcuni insegnanti sembra che la preoccupazione più grande sia il far
assimilare il più possibile in modo acritico i più svariati contenuti. A
volte si richiede moltissimo, senza tener conto della preparazione
precedente, senza lasciar tempo di innamorarsi di un argomento; a volte
si giudica senza speranza di un recupero, senza le dovute attese di
maturazione che varia da alunno ad alunno, il tutto in modo
assolutamente impersonale.
E di questo i nostri figli soffrono specialmente nei primi anni delle
superiori. A volte, specie alle medie , si gratifica invece in modo
spropositato, senza educare alla serietà dell'impegno e alla fatica
dell'apprendere.
Anche se ogni insegnante deve presentare ogni anno, con il programma, le
méte educative e didattiche , nessuno controlla, nessuno le armonizza in
un piano di intervento comune.
Rari sono anche i mezzi pedagogici messi in atto per raggiungere le méte
educative e, con la giustificazione della libertà di insegnamento, ogni
insegnante si ritaglia il proprio spazio dentro il quale nessuno può
mettere il naso.
E' evidente che la scuola riflette la società complessa odierna molto
più individualista di un tempo. La stessa mancanza di riforme, specie
per la scuola superiore, nasce da una visione politica, da un modo di
credere e di vivere molto variegati e difficilmente riconducibile a una
sintesi culturale. Ma si fa sempre più viva la richiesta di una cultura
che sia per la persona e per la sua crescita, prima che per la
produzione o per l'accumulo astratto del sapere.
Noi vorremmo una cultura che offrisse la possibilità di libertà di
condizionamenti esterni, rivolta al singolo e non uniformamente a tutti
allo stesso modo.
In una società così soggetta all'influenza dei mass-media, c'è un enorme
bisogno di educare le singole coscienze, altrimenti manovrabili e, di
fatto manovrate, come possiamo aver notato in questi giorni di tensione
internazionale.
FAMIGLIA E SCAUTISMO
Mancano gli ultimi due poli educativi: la famiglia e lo scautismo. Ma
preferisco affrontarli in modo diverso, visto che diverso è il rapporto
che intercorre tra essi.
Parliamo sempre di aspetto educativo, per cui la domanda da porci è
"Cosa può offrire lo scautismo ai ragazzi e ai giovani d'oggi?"
Il fine dello scautismo è la formazione del buon cristiano e del buon
cittadino attraverso i famosi quattro punti:
1) formazionie del carattere
2) Salute e forza fisica
3) Abilità manuale
4) Servizio del prossimo
A questi si aggiunge la Religiosità che deve permeare tutta la vita di
uno scout.
Mi soffermo brevemente su ciascuno.
1) Formazione del carattere: mai come in questo periodo storico è
indispensabile la formazioine di un carattere forte che significa
educare una persona che sia capace di prendere le grandi decisioni della
vita con saggeza ed equilibrio; una persona capace di avere e di
difendere le proprie idealità senza diventare "uno del gregge" ma in
grado di "guidare da solo la propria canoa".
B.P. afferma che la scuola privilegia l'intelligenza, ma per una vita
felice è più importante il carattere.
I mezzi per raggiungere questa e le altre mète educative sono precisi e
molteplici e vi verranno spiegate nell'incontro con i vari capi-unità
nel pomeriggio.
2) Salute e forza fisica: lo scautismo ha sempre pensato che l'uomo è
formato da una parte fisica e una spirituale o intellettuale: non si può
curarne solo una a scapito dell'altra. Molto prima della nascita delle
palestre, lo scautismo a capito l'importanza di curare il proprio corpo
come dono di Dio e come mezzo per raggiungere la felicità che consiste
nel godere la vita con un corpo sano per porsi al servizio della propria
famiglia e del prosssimo.
Pensate al valore di questo aspetto oggi, con i giovani che si drogano,
che si sfiatano nelle discoteche, che si ubriacano, ecc..; oggi il corpo
o è esaltato, come dal culturista o è disprezzato come dal drogato. Lo
scautismo gli dà il giusto valore.
3) Abilità manuale: nel mondo automatizzato odierno, la gioia che nasce
da un proprio sforzo per costruire qualcosa di bello e di utile è quasi
sconosciuta. Lo scautismo continua a proporla e a farla gustare a
piccoli e grandi.
4) Servizio: di fronte all'egoismo individualista del mondo
consumistico, lo scautismo ricorda che la gioia più grande è quella di
far felici gli altri. Vale la pena di sacrificare un po' del proprio
tempo, della propria intelligenza e delle proprie capacità per portare
la gioia a chi ancorano la conosce; e più numerosi saremo, più saremo
felici, come recita la nostra canzone.
E' facile comprendere come dietro a questo punto fondamentale viva e
prosperi la proposta cristiana dell'amore per il prossimo in tutti i
suoi aspetti più profondi.
Faccio una piccola citazione perchè mi è piaciuta in sintonia com'è con
il nostro modo di pensare: "La futura esistenza del genere umano ssu
questa terra sta, oggi più che mai, nella mani di quelli che sanno
pensare non solo a se stessi, ma che, nel loro operare, pensano a tutti
i loro prossimi, senza eccezzioni." Con queste parole il presidente
della repubblica cecoslovacca Vaclav Havel, il 33 aprile 1990, ha
salutato Giovanni Paolo II, in visita a Praga.
- L'aspetto religioso verrà trattato dal successivo relatore per cui
nonmi soffermo.
Ma per raggiungere queste mète lo scautismo ha bisogno delle famiglie.
"Cosa chiede lo scautismo alle famiglie d'oggi?"
- una condivisione di fondo delle proposte educative senza la quale si
può correre il rischio di alimentare quel mimetismo comportamentale così
diffuso oggi.
Se noi ad esempio, insegnamo la lealtà, e la famiglia, invece insegna
che in certi casi, (vedi copiare il compito in classe, mentire per
interesse, ecc.) si può esser sleali, il ragazzo si adeguerà a seconda
degli ambienti e non assumerà mai un comportamento coerente; la sua
personalità sarà disturbata e instabile. Noi chiediamo alla famiglia di
condividere il desiderio e lo sforzo di farne uomini di carattere.
Stiamo allevando in Italia una generazione di giovani smidollati e
fanulloni, a cui nulla è più negato per paura che si stacchino dalla
famiglia; e proprio così si perdono:
_ si perdono alla famiglia, per la quale non fanno nulla e non pagano
nulla, ma dalla quale prendono sicurezza e denaro
_ si perdono alla società, perchè il loro orizzonte civile è limitato al
proprio interesse e tornaconto.
_ si perdono alla chiesa, diventata per loro solo fornitrice di servizi
(sacramenti, matrimoni, battesinmi, funerali)
Noi chiediamo alle fomiglie di sostenere il loro figli scouts e rovers,
soprattutto nei momenti di crisi, inevitabili nel processo evolutivo.
Alle volte sembra che esse temano che un ragazzo si impegni troppo ed
oltre una certa età, come quando una famiglia ha paura di un figlio che
intende andar prete.
Ma una vita ha bisogno di ideali per cui battersi! Guai a noi se
riduciamo la nostra e la vita dei nostri figli al solo aspetto
materiale! Che significato e che sapore avrebbe una simile esistenza?
Certo che è importante la scuola, la professione, ecc.: ma non è tutta
qui la vita! E se un ragazzo è responsabile troverà sempre lo spazio e
il tempo per dedicarsi un po' agli altri.
Ma anche le famiglie devono chiedere qualcosa allo scautismo:
_ Che sia fedele a se stesso, che resti un movimento educativo e che non
tenti di diventare movimento politico o sociale. Lo scautismo deve
formare dellee coscienze, non siindacalisti, politici, contestatori
perenni.
Lo scautismo non deve diventare unu gruppo giovanile senza mète precise,
nè un centro tyristico giovanile.
Deve continuare ad essere una splendida avventura di vita per i nostri
figlioli; e anche il servizio è un'avventura, come del resto sanno
coloro che si dedicano ai loro figli.
Le famiglie devono chiedere conto ai capi, però, anche dell'evoluzione
della personalità dei loro figli e delle scelte che via via vanno
facendo. E' un loro diritto e i capi devono essere preparati a questo.
Lo scopo è sempre quello educativo, non ludico, cioè di passatemppo. Si
dice che nello scautismo "nulla è fatto per gioco, ma tutto attraverso
il gioco".
Per concludere un invito:
_ Se condividiamo la necessità di essere adulti significativi, capi e
genitori, per i nostri scouts, penso che sia opportuno un piano di
collaborazione più stretta di quello avuto finora.
Per cui, avendo già sentito il Consiglio di Gruppo, propongo la
formazione di una associazione di genitori che affianchi lo sforzo
educativo dei capi secondo modalità da decidere, pur nel rispetto della
reciproca sfera d'influenza.
Il capo Gruppo illustrerà poi la proposta. E' tempo che lavoriamo di più
insieme!
Grazie a tutti!
Claudio Favaretto
↑▲↑
Presentazione del ventennale di scautismo a
S.Pio X del Gruppo TV 2°
1961 - 1981
Chi ci è vissuto vicino e con noi ha seguito passo passo le, nostre
vicende, resterà forse sorpreso nel constatare - in un certo senso così
è capitato anche a noi - che quello che stiamo trascorrendo è il
ventesimo anno di attività scout a S.Pio X. Una vita!
Si era nel lontano novembre del 1961 quando, su sollecitazione di don
Cesare, parroco da pochi anni, si iniziò con pochi ragazzi l'attività.
Ormai quei primi ragazzini sono diventati uomini con famiglia, inseriti
nel mondo a pieno titolo; e, dopo di loro, tanti altri, della
Parrocchia, e di quelle vicine, fino ai nostri giorni.
Talvolta si è sgomenti osservando come veloce passi il tempo, ma abbiamo
anche la fortuna, che non a tutti è data nella vita, di poter affermare
che sono stati anni spesi bene! E questo noi ci sentiamo di dire perché,
senza falsa modestia e schivi pudori, abbiamo cercato di fare del nostro
meglio con coerenza, anche attraverso le inevitabili asperità della,
vita personale e comunitaria.
Dopo quella squadriglia libera che effettuò il suo primo campo nel 1962
in Val d'Oten, sostenuta dal Riparto di Santa Maria del Rovere, si formò
il Riparto.
I problemi furono molti: dalla sede (le opere parrocchiali erano allora
formate da poche stanze e per di più date in affitto alla autorità,
scolastica), all'inserimento nel tessuto parrocchiale di questa nuova
attività che presentava, peculiarità diverse dalla tradizione dei gruppí
giovanili. Ma un po' alla volta, anche atttraverso difficoltà e qualche
screzio, però - e ci teniamo qui a sottolinearlo - sempre con il pieno e
leale appoggio di fondo del parroco, siamo riusciti a farci conoscere e,
riteniamo, apprezzare.
Così, dopo il riparto potè nascere l'unità femminile che ebbe una vita
un po' travagliata ma che, da qualche tempo, è ritornata ad essere
presente in modo felice e, ci auguriamo, duraturo.
In seguito il Branco, il secondo Riparto, in tempi più recenti il Clan
e, da qualche anno il Gruppo hanno confermato e confermano la validità
della seria impostazione metodologica ed educativa del nostro scoutismo.
Mentre scriviamo queste parole le quali, se ci danno la soddisfazione di
un lavoro positivamente svolto ci impegnano a continuarlo, ci passano
davanti agli occhi i tanti bambini, ragazzi e giovani che, alcuni per
qualche anno, altri per molti sono passati o sono ancora nelle nostre
fila, magari con il peso della responsabilità di capi. Allo stesso modo
ricordiamo tante figure di genitori e di amici, fino al momento attuale,
che ci hanno appoggiato e ci aiutano tuttora. A tutti loro va il nostro
ringraziamento come va ai sacerdoti, nostri compagni di avventura. Per
festeggiare come si conviene questa ricorrenza, il Gruppo, comprende
oggi, oltre le unità di S. Pio X, anche Roncade, Fossalta di Piave e
S.Maria del Sile, ha deciso di dare alle stampe (finanze permettendo),
un volumetto con le testimonianze documentarie degli anni trascorsi.
Sarà organizzata poi, presso le opere parrocchiali, una mostra scout per
la Domenica 17 magggio: sarà un momento di rievocazione per coloro che
hanno lavorato con noi e di conoscenza per la Comunità parrocchiale.
La domenica successiva, 24 maggio, si svolgerà la Festa dei Genitori
alla quale invitiamo fin d'ora tutta la Parrocchia e tutti gli amici
secondo modalità che faremo conoscere in seguito. In questo modo ci
auguriamo di trascorrere insiene delle ore liete, di quelle ore che
hanno il sapore della fraterna amicizia e della reciproca stima, così
rara, ormai, in un mondo tanto ostile.
Così, con voi tutti, amici ed estimatori, cerchiamo di seguire l'invito
del nostro fondatore di "lasciare il mondo un po' migliore di come
l'abbiamo trovato".
A nome del Consiglio di Gruppo
Claudio Favaretto (Capo Gruppo)
↑▲↑
Intervento per la festa dei 40 anni del TV2° al
Teatro S.Anna
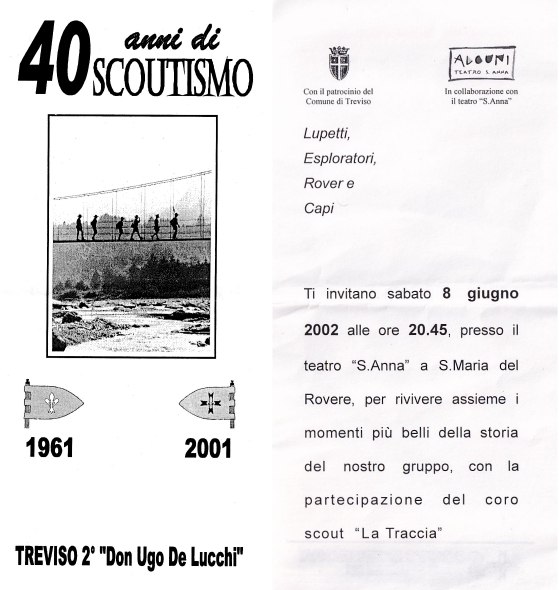 Mi
è stato chiesto di fare un piccolo intervento e vi garantisco che sarà
proprio piccolo, perchè questa è una festa e non un convegno. Mi
è stato chiesto di fare un piccolo intervento e vi garantisco che sarà
proprio piccolo, perchè questa è una festa e non un convegno.
Abbiamo ascoltato poco fa il canto del campo del 1973, eseguito in mmodo
impeccabile dal coro. Se avete seguito le parole, si parla di "fiaccola
accesa": é quella della testimonianza della bontà dello scautismo
tradizionale del fondatore che noi capi del TV 2° di allora volevamo
conservare e far conoscere a chi "temendo dubita" come dicono le parole
del canto.
Lo scautismo cattolico italiano attraversò un periodo di crisi di
identità sotto la pressione delle contestazioni studentesche del '68.
Molti si improvvisarono pedagogisti, fu criticata:
a) la figura del capo
b) la fisionomia della squadriglia, ridotta a mutabile centro di
interesse
c) l'educazione separata tre ragazzi e ragazze
d) l'apoliticità
e) il rapporto con la Chiesa
Noi del Treviso 2° non accettammo questo snaturamento dello scautismo:
non accettammmo la nuova associazione nata dalla fusione delle due
precedenti (Asci per i ragazzi e Agi per le ragazze).
Su queste basi fu creata nel 1974 un'Associazione locale, chiamata
"Gruppi e Ceppi scout Cattolici, Treviso" che finalmente confluì nel
1976 nella neonata Associazione Guide e Scouts Cattolici d'Europa.
Il tempo ci ha dato ragione: da poche centinaia del '76 oggi siamo
20.000, segno che i principi educativi e pedagogici dello scoutismo
tradizionale sono ancora validi, perchè ancorati alla psicologia degli
adolescenti.
Non mi resta perciò, per concludere, che augurare lunga vita agli Scouts
d'Europa e lunga vita al TV 2°!!
↑▲↑
Da "Vita del popolo" del 5 ottobre 1986
Campo mobile sulle Alpi Giulie del Clan "La nuova strada" di S.Pio X -
Estate 1986
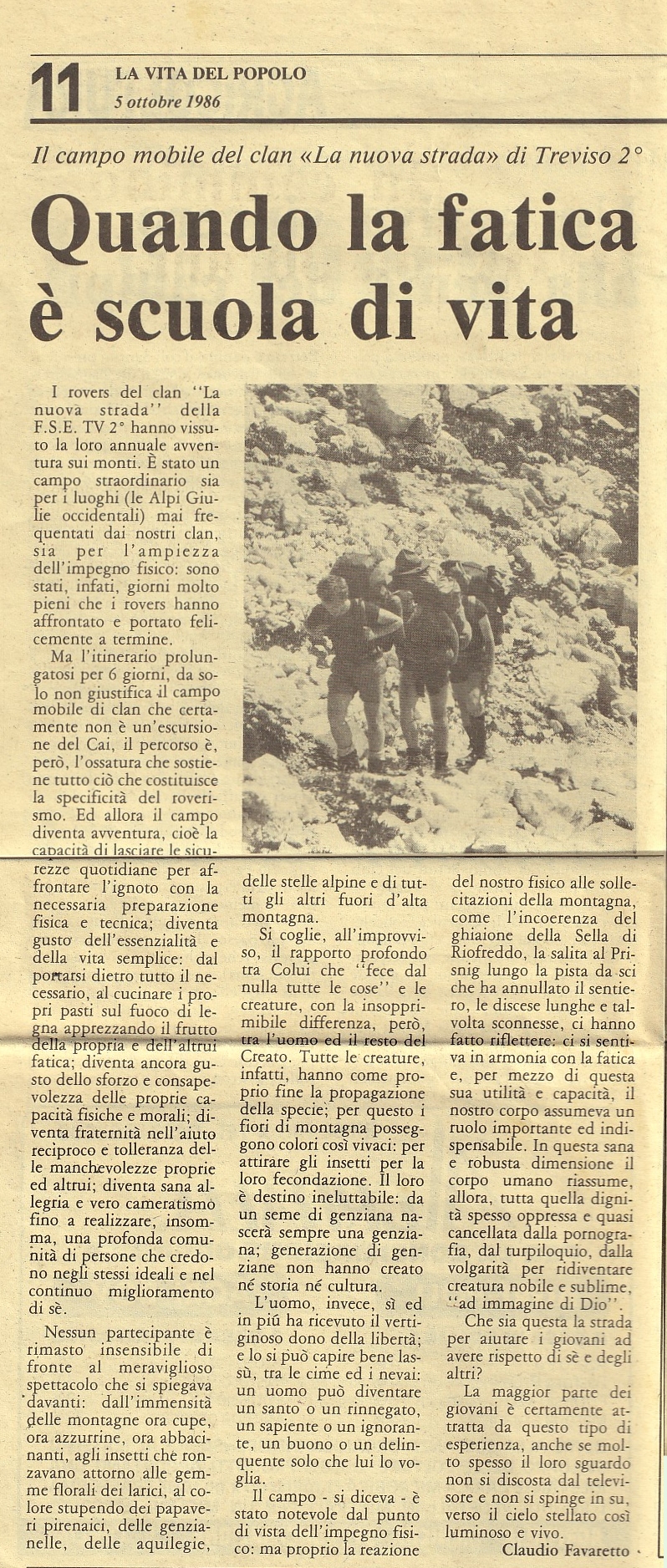
↑▲↑
dal carnet
del campo scuola di 2° tempo di Claudio -
-
Colico 15/8/1962
Sessione natura
Natura, ambiente logico per lo scautismo.
Vivere la natura è fonte di gioia, di serenità, di insegnamenti.
La natura è vera: è l'immagine di Dio.
La natura è leale: non imbroglia.
La Natura è armonia e attraverso di essa arriviamo a Dio.
Non occorre avere una conoscenza scientifica ma il gusto per la
conoscenza.
La natura serve prima a noi e poi ai ragazzi.
Non dobbiamo puntare sulla specializzazione ma fare in modo che tutti
siano in grado di apprezzare e conoscere.
Bisogna dare l'idea e poi lasciar fare.
Incominciare dall'alta squadriglia, poi introdurlo in riparto.
Invitare il ragazzo a fare delle osservazioni particolari.
Indirizzare i ragazzi verso le specialità riguardanti la Natura. Deve
essere una cosa continua non ogni tanti e saltuariamente.
Avere pazienza e non aspettarsi subito risultati.
Il materiale deve recare vantaggio a tutta la comunità, quindi tenere in
Riparto un quaderno Natura.
OSSERVAZIONE NATURA - ORE 15:30 - Lago delle ninfee
Il posto da osservare è magnifico e molto vario: ogni volta devo
descrivere uno spettacolo naturale mi sento incapace perché ci sono
delle sensazioni che sono inesprimibili. Inoltre l'attività natura mi ha
sempre affascinato e la considero il migliore regalo che gli scouts mi
hanno fatto.
Il tempo è incerto e ogni tanto una raffica di vento fa ondeggiare
rumorosamente le cannucce che crescono sul fondo basso e fangoso del
laghetto.
Anche le eleganti betulle si lasciano cullare dal vento e danno
l'impressione di qualcosa di delicato e morbido con quel meraviglioso
tronco bianco che si staglia nitido sul fondo più scuro.
Più robusto invece il pino dal tronco rossastro.
Un gruppo di felci che crescono presso la riva si specchiano nel
laghetto dando un tono di colore a quella superficie scura.
Sento avvicinarsi il vento attraverso il bosco con un fruscio più forte
fra le conifere, più morbido fra le latifoglie.
Ai miei piedi sorridono le ninfee ed osservandole non posso trattenere
un sorriso di risposta e di saluto.
Sono molto belle e tanto più belle in quanto escono dal fondo scuro e
fangoso e salgono a fiorire sulla superficie dell'acqua.
Le foglie hanno un lungo gambo e appoggiano sulla superficie dell'acqua
formando come un tappeto. Sono di forma circolare di diametro massimo
circa 20-30cm. Il gambo si innesta al centro della foglia e da questo
bottone si dipartono tutte le infinite nervature. La foglia è divisa
lungo un raggio sulla parte opposta all'apice.
La pagina inferiore è rossastra con nervature molto più marcate e
verdastre.
I fiori non posso osservarli tanto bene perché sono relativamente
lontani, comunque escono da una guaina verde formata da cinque petali
che si aprono lasciando uscire il fiore che dapprima bianco e rosato ed
assume via via un colore più acceso.
Non sono riuscito a vedere una ninfea fiorita: forse una volta fecondato
il fiore, si immerge portando i semi sul fondo affinché possano
nutrirsi.
Il gambo, come quasi tutte le erbe acquatiche è cavo però non
completamente: esistono quattro condotti principali e due un po' minori
oltre naturalmente a tutti gli infiniti minori.
↑▲↑
Appunti per la presentazione della storia
dello scautismo trevigiano al Clan del TV2° - 2013 circa
CENNI DI STORIA DELLO SCOUTISMO TREVIGIANO
Come ben si sa, lo scoutismo nacque nel 1907 nel campo sperimentale
tenuto da B.P. nell'isola di Brownsea.
Arrivò presto a Treviso, nel 1914, se non erro, con una unità del GEI,
l'associazione laica, esistente ancor oggi a livello nazionale.
Ma dopo la nascita dell'ASCl, nel 1916, lo scautismo cattolico fece la
sua comparsa anche nella nostra città. Non conosco l'anno esatto.
Era uno scoutismo molto diverso dall'odierno, con un'impronta un po'
para-militare, ma pur sempre un movimento per i ragazzi, con Ia legge e
la promessa molto simili, anche nell'enunciazione, alle nostre.
Purtroppo, nel 1928, la dittatura del regime fascista decretò la
chiusura di tutte le associazioni giovanili, anche quelle cattoliche,
perché l'unica doveva restare l'Opera Nazionale Balilla, naturalmente
impregnata dello spirito fascista.
Con la stipula dei Patti Lateranensi, del 1929, l'unica associazione
tollerata non fascista fu l'Azione Cattolica.
Lo scoutismo fu sciolto in tutta Italia in due date successive, nelle
piccole e grandi città. Alcune coraggiose unità, a Roma e a Milano,
sopravvissero.
A Milano, in particolare, continuarono la loro attività clandestina le
Aquile randagie, il cui ultimo rappresentante è ancora vivo: si tratta
di mons. Barbareschi. Qualcuno di voi l'avrà visto nella recente
trasmissione su Rai storia, proprio sulle Aquile randagie. Furono
guidate da capi ed Assistenti audaci e coraggiosi: il leggendario
Uccellini, detto Kelli e don Andrea Ghetti detto Baden.
(autore, tra l'altro, di vari canti scout, come "Madonna degli scouts")
il loro motto fu "per un giorno in più" cioè durare un giorno più della
dittatura.
Dopo le tragiche vicende della storia nazionale, nel 1943, a Roma,
liberata dai Tedeschi che risalivano lentamente la penisola, recando
morte e distruzione, rinacque I'ASCI, almeno nella parte dell'Italia
libera. Capo straordinario in quel periodo fu Salvatore Salvatori, che
fu anche il mio capo campo al campo scuola di secondo tempo a Colico nel
1962.
Qui a Treviso si dovette attendere il 1946-47 per assistere alla
rinascita.
Quello che so è frammentario. Ho chiesto più volte a chi era più grande
di me di scrivere la storia, ma finora non ho avuto riscontro, ed è un
peccato.
So che un giovane ufficiale polacco, non so per quali motivi a Treviso,
incontrò alcuni giovani della parrocchia di San Martino Urbano, e parlò
loro dello scoutismo.
Fra questi c'era Enzo Dematté, deceduto pochi mesi fa, che divenne
l'artefice del rilancio dello scoutismo cattolico a Treviso.
Nel 1954, infatti, a Treviso fu organizzata una "Mostra scout" nel
salone dei Trecento, con angoli di squadriglia, tende, ecc. che attirò
molta gente che ne rimase entusiasta. lo c'ero!
ALCUNE DATE SIGNIFICATIVE
1954= mostra scout al Palazzo dei 300
io facevo parte del riparto di santa Maria del Rovere che si chiamava
Treviso 7". A quel tempo non c'erano i gruppi, ma solo riparti. Ricordo
il TV 8° al Turazza; Tv 3° al Duomo; Tv 9° a sant'Andrea.
1955 = nasce il Gruppo TV 1° detto gruppo forte perché riuniva tutte le
unità esistenti;
ricordo il branco del Fiore Rosso di santa Maria del Rovere e quello del
Duomo, di cui non ricordo il nome.(forse delle "Terre arate")
Con i rover provenienti dai vari riparti, nacque il clan cittadino che
aveva sede sopra il Battistero del Duomo, con il nome di “Nostra Signora
della Strada" Anch'io ne feci parte, fino alla nascita del TV 2° nel
1961.
1956= La sq. Castori del riparto di santa Maria del Rovere, di cui ero
caposquadriglia, svolge un campo di sq. nei pressi di Croce d'Aune,
della durata di una settimana. Il caporiparto non poteva fare campo
perché impegnato in esami di stato. Così la fiamma della vita all'aperto
fu tenuta accesa dal Castori.
1958 = ultimo mio campo scout in valle di san Lucano, a Taibon agordino.
"Campo del sentiero che si divide". ll posto da campo era stato trovato
durante la missione per la specialità di ciclista mia e di un altro csq.
1959 = il 23 aprile, giorno di san Giorgio, muore don Ugo de Lucchi, un
grande prete, innamorato dello scautismo che non so dove l'abbia
appreso. Fu l'assistente dei lupetti, degli scout e dei rover, e
l'ispiratore della nascita del nostro gruppo.
1961= il gruppo cittadino del TV 1° si sdoppia dando vita al TV 2" che
comprende solo due riparti (S. Maria del Rovere e santa Bona, due
branchi nelle stesse parrocchie ed un clan con sede a santa Maria del
Rovere. Il 4 novembre nasce, sotto la mia responsabilità, anche la sq.
libera Gheppio a san Pio X. Paolo Poli ne è il primo csq. Negli anni
successivi sorgono altre unità di lupetti e di scout a san Liberale, a
Fontane, a santa Maria Maddalena. Nasce anche un clan a santa Bona.
Quello di san Pio X nascerà nel 1974.
1963 = in ottobre ha luogo la tragedia del Vajont. Rovers e novizi
rovers partecipano all'opera di soccorso.
1965 = campo in Francia della zona ASCI di Treviso alla Couteranderie,
ospiti degli Eclaireurs de France
1972= ancora campo in Francia, ma questa volta solo con il TV 2°e con il
Ceppo TV 1° femminile, una felice intuizione che verrà confermata in
seguito, anche con la FSE.
1974 = dopo anni di turbamenti, discussioni, scontri, dalla fusione
delI'ASCI (scout cattolici) ed AGI (guide cattoliche} nasce l'Agesci con
un colpo di mano a livello direttivo, senza nemmeno un'assemblea
nazionale di capi brevettati (io mi ero brevettato nel 1964).
1974 = il TV 2° ed il Ceppo TV 1° non aderiscono all'Agesci,
contrastando la fusione sia sotto il profilo pedagogico (es. lupette,
conduzione femminile dei branchi, sq. miste, ecc.), che educativo
(nessun rispetto per le peculiarità psicologiche del ragazzo e della
ragazza).
Nasce l'Associazione "Gruppi e Ceppi scouts cattolici Treviso", con
strutture, assicurazione, stampa, distintivi, campi scuola autonomi. Lo
stesso fenomeno di rifiuto dell'Agesci si verifica anche in altre città
come Roma, Jesi, Palermo, ecc.
Ma un'associazione così piccola non sarebbe sopravvissuta, per cui il
capogruppo di allora, l'indimenticabile Francesco Piazza, detto Checco,
cercò contatti con altre associazioni, comprese il GEI e l'Assoraider.
Ma nessuna delle due ci convinsero, sia sotto il profilo metodologico,
(Assoraider 4 branche!) che della religiosità (GEI, nessuna
caratterizzazione religiosa).
1976 = Maggio: Violento terremoto in Friuli. Il nostro clan "La Nuova
strada" partecipa ai soccorsi nella seconda metà di giugno. Servizi alle
persone che ce li richiedevano. Fuochi di bivacco alla sera per la gente
e i soldati.
incontriamo capi romani già della FSE nata in aprile di quello stesso
anno
1976= nasce l'Associazione Italiana Guide e Scout Cattolici aderente
alla Federazione dello Scoutismo Europeo (FSE). Il Gruppo Tv 2° ed il
Ceppo TV 1° vi aderiscono con slancio in quanto rispondevano alle nostre
richieste educative e pedagogiche. Associazione cattolica, con due
sezioni ben distinte, con pedagogia separata tra ragazzi e ragazzi.
1976 =il TV 2°, che contava ben 14 unità (4 branchi, 7 riparti, 3 clan),
si divide dando vita a tre gruppi:
1) - san Pio X e santa Maria Maddalena = TV 2°
2) - santa Maria del Rovere e Fontane = TV 7°
3) - santa Bona, s. Liberale, s. Cuore = Tv 3°
ln seguito il TV 2° aprirà nuove unità a Paderno, Selva del Montello,
Carbonera, Fossalta di Piave. Riceverà Silea che era rimasta senza capi,
e per alcuni anni avrà anche la responsabilità di Roncade, in crisi per
mancanza di capi. Purtroppo santa Maria Maddalena non durerà a lungo.
1991= si svolse a Viterbo l'assemblea nazionale.
Ogni tre anni i capi brevettati si riuniscono per esaminare il cammino
percorso e per tracciare il nuovo programma, oltre che per eleggere il
consiglio nazionale che elegge poi il consiglio direttivo: presidente, i
due commissari generali, il segretario ed il tesoriere nazionali.
Da quell'assemblea uscirono presidente Nico Pezzato, commissaria
generale guide Francesca del Giudice, commissario generale scout il
sottoscritto.
Dopo molti anni di governo romano, l'associazione cambiava direzione.
1994 = si-svolse a Viterbo l'EJ organizzato dalla nostra associazione
con la presenza di circa 8.000 tra ragazzi e ragazze.
Importantissimo l'incontro con il Papa a san Pietro perché nel suo
discorso del 3 agosto riconobbe la validità e l'originalità del nostro
impegno educativo che era stato sempre osteggiato dall'Agesci che ci
vedeva come antagonisti.
2003 = EJ a Zelasko, in Polonia
2007 = Euromoot sui Monti Tatra, tra Slovacchia a Polonia. 1° grande
raduno della branca Rover della FSE
|

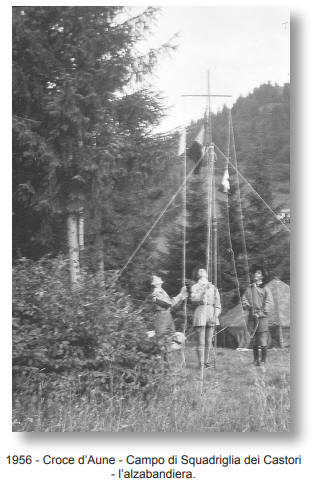 Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell
proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto
fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e
sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da
ragazzino.
Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell
proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto
fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e
sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da
ragazzino. 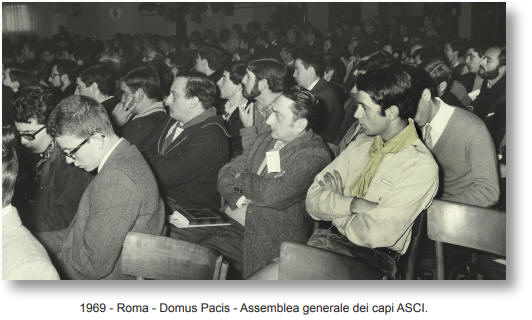
 Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel
1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo
Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da
ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non
riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che
aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con
tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di
quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,
Commissariato Regionale), sia a livello nazionale.
Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel
1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo
Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da
ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non
riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che
aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con
tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di
quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,
Commissariato Regionale), sia a livello nazionale. 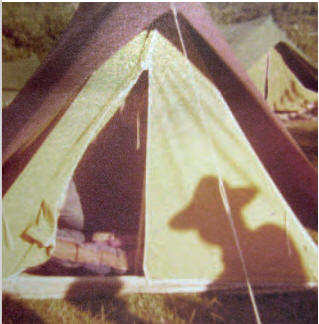 Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi
del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti:
Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi
del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti:  Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di
un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i
capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione
presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci
arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben
consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,
350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di
concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione
di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974.
Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di
un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i
capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione
presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci
arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben
consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,
350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di
concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione
di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974.

 Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del
Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don
Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I
campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave
perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse
inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in
parte.
Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del
Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don
Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I
campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave
perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse
inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in
parte.  andavano a trovarlo per un
consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni
importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva
esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della
nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale
nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena
formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e
Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che
investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi
presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali
nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,
imponeva.
andavano a trovarlo per un
consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni
importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva
esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della
nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale
nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena
formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e
Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che
investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi
presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali
nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,
imponeva.  Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche
involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al
campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima
di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste
piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel
1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia
macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo
dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a
vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la
macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca
di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.
Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane
pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente
dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna
il cane proseguì il
Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche
involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al
campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima
di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste
piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel
1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia
macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo
dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a
vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la
macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca
di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.
Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane
pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente
dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna
il cane proseguì il
 suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente
una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.
Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,
utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella
messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni
preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi
chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio
di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce!
suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente
una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.
Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,
utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella
messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni
preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi
chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio
di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce! di
me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la
mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far
comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,
come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare
pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando
mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.
Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,
dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II
a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle
idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che
anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una
certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano
il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero
diventati da lì a poco pontefici.
di
me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la
mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far
comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,
come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare
pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando
mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.
Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,
dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II
a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle
idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che
anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una
certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano
il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero
diventati da lì a poco pontefici. uno di Roma.
uno di Roma. 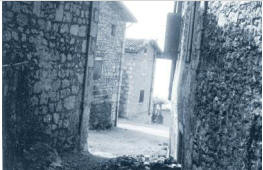 Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca
dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le
loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di
servizio.
Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca
dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le
loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di
servizio.  La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di
noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle
preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della
tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine
per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben
maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il
fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei
saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni
di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare
insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia.
La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di
noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle
preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della
tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine
per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben
maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il
fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei
saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni
di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare
insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia.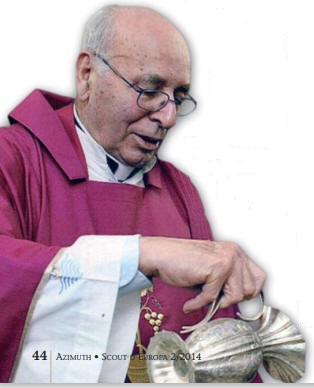 Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed
imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del
Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda
collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22
gennaio scorso, con la sua dipartita.
Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed
imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del
Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda
collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22
gennaio scorso, con la sua dipartita. 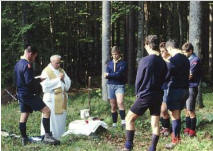 Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo
affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,
in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.
Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu
anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di
corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di
montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste
per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il
riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di
conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza.
Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo
affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,
in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.
Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu
anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di
corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di
montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste
per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il
riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di
conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza.  con noi la gioia del fuoco da cucina e la
fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco.
con noi la gioia del fuoco da cucina e la
fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco.  l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare
con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati
di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro
ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.
Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo
scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati
aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma
fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere
insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare
a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di
anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra
mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di
risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano
drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano
provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi
nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,
città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà
e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente
raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che
non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo
processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché
l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia
e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace
tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla
loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’
perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che
pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente
merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in
esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il
Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare
che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE
(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno
successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri
con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti
umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato
a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e
del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di
razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il
carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime
indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,
motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di
condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni
di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la
Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono
sempre contese.
l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare
con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati
di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro
ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.
Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo
scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati
aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma
fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere
insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare
a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di
anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra
mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di
risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano
drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano
provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi
nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,
città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà
e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente
raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che
non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo
processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché
l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia
e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace
tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla
loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’
perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che
pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente
merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in
esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il
Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare
che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE
(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno
successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri
con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti
umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato
a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e
del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di
razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il
carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime
indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,
motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di
condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni
di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la
Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono
sempre contese.  L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da
spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986
aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990
venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della
vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa
comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione
Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si
realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri
adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno
Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e
senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.
Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia,
L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da
spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986
aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,
Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990
venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della
vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa
comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione
Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si
realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri
adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno
Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e
senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.
Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia,

 Salvo
qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni
familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla
casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:
un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a
casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno
lasciato.
Salvo
qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni
familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla
casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:
un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a
casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno
lasciato. Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,
un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua
esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo
consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo
nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta
parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo
squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,
non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori
non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello
Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento
educativo.
Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,
un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua
esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo
consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo
nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta
parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo
squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,
non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori
non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello
Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento
educativo. 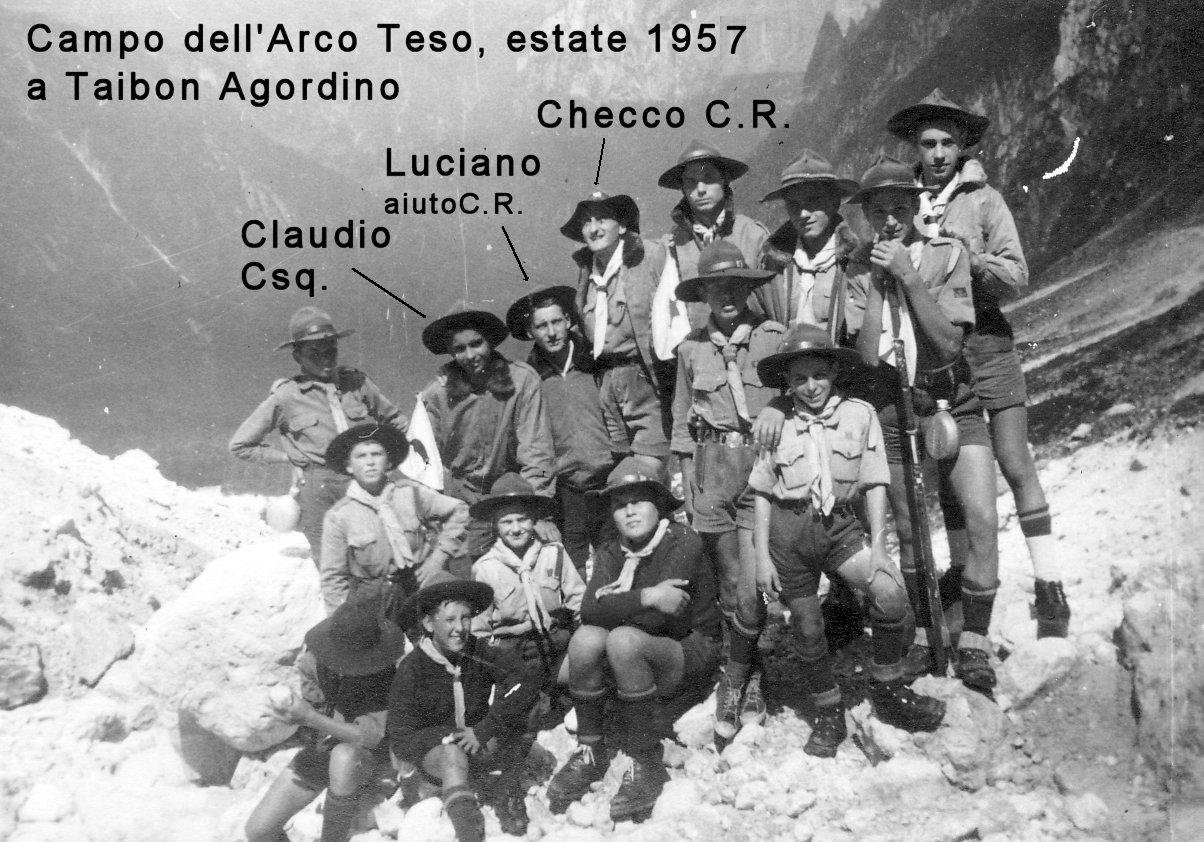 Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri
non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano
al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire
nella stessa camera. Ma prima di infilarci sotto le coperte ci
dicevamo: “Vinca il migliore!” e dopo poco cominciava la
battaglia.
Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri
non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano
al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire
nella stessa camera. Ma prima di infilarci sotto le coperte ci
dicevamo: “Vinca il migliore!” e dopo poco cominciava la
battaglia. 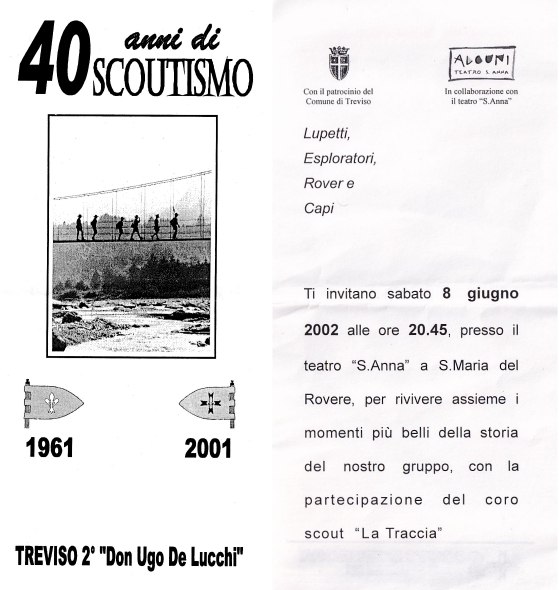 Mi
è stato chiesto di fare un piccolo intervento e vi garantisco che sarà
proprio piccolo, perchè questa è una festa e non un convegno.
Mi
è stato chiesto di fare un piccolo intervento e vi garantisco che sarà
proprio piccolo, perchè questa è una festa e non un convegno.