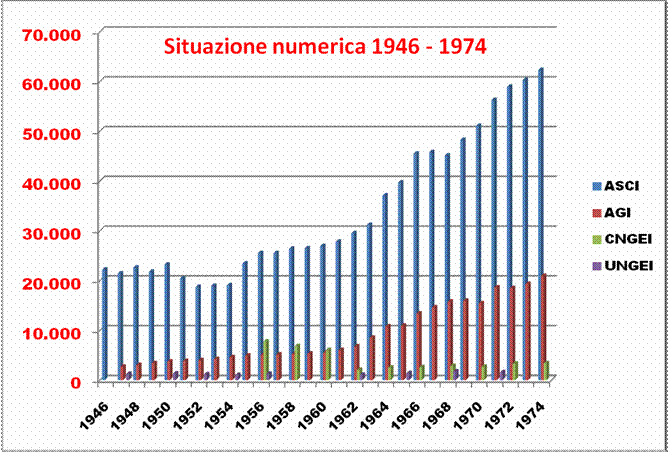|
[torna]
LO SCAUTISMO IN ITALIA NEGLI ANNI ’40 -
‘60
 di Attilio Grieco
di Attilio Grieco
Negli anni ’40, ’50, ‘60 in Italia lo Scautismo
cattolico per la parte maschile si chiama A.S.C.I., Associazione
Scautistica Cattolica Italiana, e per la parte femminile A.G.I.,
Associazione Guide Italiane, mentre lo scautismo aconfessionale per
la parte maschile è C.N.G.E.I., Corpo Nazionale Giovani Esploratori
Italiani, e per quella femminile U.N.G.E.I., Unione Nazionale
Giovani Esploratrici Italiane.
L’A.S.C.I. e l’A.G.I.
L’A.S.C.I., nasce nel 1916, fondata dal Conte
Mario di Carpegna. Viene sciolta dal fascismo nel 1927-28 e riprende
ufficialmente le attività nel 1944-45, al termine della Seconda
Guerra Mondiale. La ripresa nel 1944-45 è sorprendente perché
moltissimi vecchi Capi e vecchi Scouts si rimettono in servizio e
nascono così in pochissimo tempo una quantità di nuove Unità scout.
Al censimento del 1946 l’A.S.C.I. conta già 22.000 iscritti.
L’A.G.I. nasce clandestinamente, nel 1943, durante l’occupazione
tedesca di Roma, per l’impegno di Giuliana di Carpegna, nipote del
fondatore dell’A.S.C.I., e di padre Ruggi D’Aragona, domenicano, che
era stato Scout, Capo e Commissario dell’A.S.C.I. prima dello
scioglimento. Il 28 Dicembre 1943, in una Roma dove vigeva il
coprifuoco, nelle Catacombe di Priscilla vengono pronunciate le
prime otto Promesse delle prime future Capo delle Guide Cattoliche
Italiane.
Negli anni ’40 e ’50, come tutte le altre realtà italiane,
l’A.S.C.I. e l’A.G.I. vivono le difficoltà del dopoguerra e si
impegnano a fondo per la ricostruzione morale e religiosa della
gioventù in una Italia che si sta riprendendo faticosamente dalla
pesanti distruzioni morali e materiali della guerra.
L’A.S.C.I. e l’A.G.I. sentono che il compito della ricostruzione
morale dell’Italia è primario e i loro Capi vi si impegnano con
serietà.
Rapporti con la Chiesa
I rapporti dell’A.S.C.I. e dell’A.G.I. con la
Chiesa sono generalmente buoni. Il Sommo Pontefice, Pio XII, conosce
e apprezza lo Scautismo. La Santa Sede sostiene lo Scautismo e, in
particolare, ne sostiene l’indipendenza nei confronti dell’Azione
Cattolica che voleva assorbire l’A.S.C.I. e farne un suo ramo
particolare. Problemi nascono talvolta a livello locale con qualche
parroco che non ama lo Scautismo, o che vorrebbe gli Scouts solo
come coreografia per le processioni e per le altre funzioni.
Un problema è però costituito dal fatto che l’A.S.C.I., e ancora di
più l’A.G.I., sono numericamente molto piccole rispetto ad altri
movimenti, come l’Azione Cattolica, e questo ha il suo peso non
positivo perché in molte situazioni non sempre è facile far
comprendere l’utilità degli Scouts o delle Guide di fronte
all’obiezione che non vi è bisogno di loro perché vi sono già altre
associazioni cattoliche numerose e ben funzionanti.
Rapporti con le autorità civili e con la
politica
I rapporti con le autorità civili sono scarsi. I
rapporti con la politica sono inesistenti. Sia l’A.S.C.I. che
l’A.G.I. si dichiarano “apolitiche e apartitiche” e si attengono ad
una stretta interpretazione di queste due definizioni. Chi oggi
sfoglia le riviste associative e non conosce la storia di quel
periodo, può essere portato a pensare che in quegli anni in Italia
non sia accaduto nulla di particolare. Infatti avvenimenti come il
referendum fra monarchia e repubblica, o elezioni importanti come
furono quelle del 18 aprile 1948, non hanno lasciato traccia sulle
riviste dell’A.S.C.I. e dell’A.G.I.. Fa in parte eccezione la
rivista lombarda per i Rovers, “Servire”, che però non è una rivista
ufficiale associativa.
Rapporti con la società
I rapporti con la società civile non sempre sono
facili. Il pubblico vede gli Scouts con curiosità mista a
scetticismo. Dopo 20 anni di dittatura li aveva ormai dimenticati ed
ora questi ragazzi con uniformi un po’ esotiche non sono sempre
particolarmente apprezzati. Capita che gli Scouts siano beffeggiati
e scherniti e a volte, con qualche gruppo di ragazzi di strada, si
arrivi anche a vie di fatto. Andare per strada in uniforme, che
allora prevedeva solo l’uso dei calzoni corti, in estate e in
inverno, significa spesso ascoltare commenti poco lusinghieri e
insulti poco piacevoli.
Il Metodo Scout
L’A.S.C.I. si trova ad affrontare un’altra grande
sfida, quella del Metodo Scout. Infatti, far ripartire un movimento
giovanile, sciolto quasi 20 anni prima, non è così semplice come
potrebbe sembrare. Quando, nel 1944-45 l’A.S.C.I. riprende il suo
cammino, riparte esattamente dal punto dove si era fermata 20 anni
prima. Ma 20 anni prima tante cose dello Scautismo ancora non
esistevano o erano differenti.
L’evento che costituisce lo “spartiacque” fra queste due visioni di
Scautismo è il Jamboree Mondiale che si tiene nel 1947 a Moisson, in
Francia. I Capi dell’A.S.C.I. vi scoprono realtà nuove che, negli
anni successivi, influenzano profondamente tutta l’associazione.
Una di queste realtà nuove è il Gruppo Scout, cioè l’unione di un
Branco di Lupetti, di un Riparto di Esploratori e di un Clan di
Rovers. Nel 1927-28, al momento dello scioglimento, il Gruppo Scout
non esisteva per il semplice motivo che non era ancora stato ideato.
Infatti solo nel 1927, ad un congresso di Capi e Commissari in Gran
Bretagna, fu proposto e poi adottato il sistema del Gruppo, con le
Unità delle tre Branche coordinate dal cosiddetto “fourth man”, il
“quarto uomo”, il Capo Gruppo.
Nell’A.S.C.I. del 1927 e quindi anche in quella del 1945 tutto ruota
attorno ad un unico Riparto dove coesistono squadriglie di Lupetti,
squadriglie di Esploratori, squadriglie di Pionieri, con attività,
uscite, campi che spesso sono comuni. L’associazione raccomanda una
separazione delle tre Branche, ma in certe piccole realtà questo è
solo un pio desiderio.
La Branca Lupetti
Un altro grosso impegno di quegli anni è la
definizione metodologica della Branca Lupetti. Infatti,
nell’A.S.C.I. prima dello scioglimento, la Branca Lupetti è poco più
di una succursale “junior” della Branca Esploratori e non si conosce
ancora quello che è stato certamente una delle intuizioni più
geniali di Baden-Powell, il Lupettismo.
Chi porta in Italia il Lupettismo è un Capo di nome Fausto Catani,
Lupo Rosso Solitario. Fausto Catani integra il Lupettismo definito
da Baden-Powell con elementi ripresi dal Lupettismo cattolico
francese e belga ed introduce anche diversi elementi specifici che
sono poi entrati nel patrimonio del Lupettismo italiano.
Uno dei meriti di Catani è poi il far ammettere nella mentalità
comune dei Capi che il Lupettismo è una Branca alla pari con le
altre, perché fino ad allora la Branca Lupetti veniva considerata da
molti capi delle altre Branche quasi un asilo di infanzia.
La Branca Esploratori
La Branca Esploratori in quegli anni è affidata a
Salvatore Salvatori, Orso Montano, un altro dei capi storici dell’A.S.C.I..
La Branca Esploratori non subisce particolari rinnovamenti, tuttavia
Salvatore Salvatori insiste su un’applicazione più fedele del Metodo
e definisce meglio ed affina tutta una serie di elementi quali la
vita e l’autonomia della Squadriglia, poco presente nell’A.S.C.I.
prima dello scioglimento, o il ruolo dell’Alta Squadriglia, un’idea
non presente in Baden-Powell ma introdotta proprio in quegli anni,
riprendendola dallo Scautismo franco-belga.
Salvatore Salvatori lancia diverse iniziative, quali delle gare
nazionali per vivacizzare e stimolare le Squadriglie e i Riparti, e
realizza dei Campi Nazionali, nel 1946 a Villa Molinario presso
Roma, nel 1951 a Vallonina, nel 1954 a Val Fondillo nel Parco
Nazionale d’Abruzzo.
Oltre a ciò è poi importante la partecipazione ai Jamborees Mondiali
del 1947 in Francia, del 1951 in Austria, del 1955 in Canada, del
1957 in Gran Bretagna, del 1963 in Grecia.
La Branca Rover
Anche per la terza Branca l’A.S.C.I. degli anni
’40 e ‘50 deve intraprendere un importante lavoro di costruzione
metodologica, perché Baden-Powell aveva indicato delle linee molto
generali per i Rovers ma pochi strumenti pratici.
Nell’A.S.C.I. prima dello scioglimento per i giovani oltre i 16 anni
vi erano i “Seniori”, per i quali si erano adattate in qualche modo
le attività degli Esploratori, infatti erano riuniti in apposite
Squadriglie, avevano un guidone bordato di rosso e per loro erano
previste specifiche Prove di Classe e anche specifiche Specialità1.
Nel 1945 l’A.S.C.I. riparte sulle stesse basi, cambiando il nome da
“Seniori” a “Pionieri”. Qualche anno dopo, in seguito ai contatti
con le esperienze straniere e, più in particolare, con il Roverismo
cattolico francese e belga, la terza Branca dell’A.S.C.I. subisce
profonde innovazioni.
Artefice della nuova impostazione è Osvaldo Monass. Sono eliminate
le prove di Classe, le Specialità, il guidone bordato di rosso.
Viene adottato il termine “Rover”, le Squadriglie divengono
Pattuglie e sono riunite in un Clan.
Monass adotta elementi che costituiscono ancora oggi punti fondanti
del Roverismo italiano, quali la visione antropologica dell’uomo
cristiano e quindi la formazione personale di ciascuno in rapporto
con la comunità che lo circonda, la spiritualità della strada, le
tappe della vita Rover (quindi il periodo di Noviziato, l'Impegno,
la Partenza) e, oltre a ciò, la Carta di Clan, l’Inchiesta, il
Capitolo e così via.
L’impegno di Monass viene continuato dai suoi successori e le linee
della Branca trovano una loro compiuta definizione in due convegni
di Capi Clan, il primo nel 1955 a San Miniato presso Firenze, dove
sono definiti l’impostazione e i contenuti del periodo del
Noviziato, e il secondo a Bologna nel 1956, dove è definito il
periodo Rover.
L’A.G.I.
L’A.G.I. si trova nell’immediato dopoguerra ad
affrontare una strada certamente più difficile di quella dell’A.S.C.I..
Infatti deve costruire tutto ex-novo perché, al contrario dell’A.S.C.I.,
le dirigenti non hanno avuto nessuna precedente esperienza scout e
manca totalmente una storia associativa passata dalla quale
riprendere e sulla quale ricostruire.
Inoltre ci si trova in un periodo di grandi cambiamenti, in cui
anche il ruolo della donna italiana è in via di profonda
trasformazione. Occorre quindi sapersi mantenere fedeli agli
obiettivi e ai principi del Guidismo cattolico, ma non riprendere
modelli femminili che ormai la mentalità corrente considera
sorpassati.
Nel 1918 Baden-Powell aveva scritto per le ragazze: “Girl Guiding”,
dove aveva delineato i principi generali, lo schema organizzativo e
le attività delle “Brownies”, delle “Girl Guides”, delle “Rangers”,
oggi diremmo “Coccinelle”, “Guide”, “Scolte”. Le dirigenti dell’A.G.I.,
d’accordo con le dirigenti del G.E.I., decidono però che “Girl
Guiding” non è adatto alla situazione italiana, tanto che decidono
di non tradurlo, preferendo utilizzare i testi che Baden-Powell
aveva scritto per i ragazzi, e destinare un finanziamento, avuto
dalle “Girl Scouts” americane, per tradurre invece un manuale
tecnico delle guide inglesi2. Alcuni libri poi vengono scritto
direttamente da dirigenti A.G.I.3.
Per le Guide l’A.G.I. tende inizialmente a copiare quanto faceva
l’analoga Branca degli Esploratori, ma poi le Capo si rendono conto
che è necessario evitare una “mascolinizzazione” delle ragazze e
quindi decidono che occorre differenziare maggiormente la
specificità delle ragazze. Diversi aspetti e strumenti utilizzati
vengono allora rivisti in questa ottica.
L’A.G.I. inizia nei primi anni essenzialmente con la Branca Guide e,
solo dopo qualche tempo, dà inizio e definisce meglio gli strumenti
e i mezzi per le altre due Branche.
Per le più piccine l’A.G.I. scarta il tema proposto da Baden-Powell,
delle “Brownies”, perché ritenuto troppo distante dalla mentalità
delle bambine italiane. Vengono studiate esperienze straniere, in
particolare quelle delle Guide cattoliche francesi e belghe, e viene
adottato il tema delle “Coccinelle”, ispirandosi molto alle
“Jeannettes” francesi, riprendendo anche le tappe personali delle
“Jeannettes” basate su un “Sentiero” lungo il quale la bambina
coglie dei fiori, blu, bianco e d’oro, che per la “Coccinella”
italiana diventano invece il “Prato”, il “Mughetto” e la “Genziana”.
Per le Scolte Baden-Powell aveva indicato in “Girl Guiding”
l’obiettivo di formare delle personalità femminili armoniose,
preparate ai loro compiti di spose e di madri, pronte a compiere i
loro doveri di cittadine. Però aveva lasciato molto sfumati i mezzi
pratici attraverso i quali ottenere tutto questo. L’A.G.I. ricerca e
costruisce una strada specifica per la Branca Scolte, che ha il suo
lancio al primo Incontro Nazionale Scolte nel 1947 ad Assisi e
l’inno medievale di questa città diviene l’inno della Branca. Anche
in questo caso si fa sentire forte l’influenza delle esperienze
delle Scolte cattoliche francesi e belghe.
Il G.E.I.
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani,
nato nel 1912 e sciolto durante il fascismo, rinasce nel 1944. Molto
di quello che abbiamo visto per l’A.S.C.I. e per l’A.G.I., quanto a
definizione concreta di tanti elementi pratici del Metodo Scout, è
valido anche per il G.E.I. che in questi anni definisce la sua
strada.
Il G.E.I., fin dalla sua fondazione, è un organismo composto dal
Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani (C.N.G.E.I.), maschile,
e dall’Unione Nazionale Giovani Esploratrici Italiane (U.N.G.E.I.),
femminile. Sono due organismi separati, maschile e femminile, sotto
un’unica direzione nazionale..
Il G.E.I. risente della mancanza di un chiaro organismo di
riferimento, come invece è la Chiesa per l’A.S.C.I. e l’A.G.I..
L’organismo potrebbe essere lo Stato ma lo Stato italiano non è mai
stato molto attivo verso la gioventù e quindi per il G.E.I. anche
ottenere una sede per una nuova Unità diviene spesso un problema.
Un’altro grande problema del G.E.I. in questi anni è di avere uno
Statuto che risale al 1916 e che ormai è divenuto totalmente
inadeguato alla situazione. Ma per modificarlo, oltre che trovare un
accordo al suo interno, deve mettere d’accordo i 5 Ministeri che lo
patrocinano (Interno, Esteri, Difesa, Pubblica Istruzione, Marina).
Il G.E.I. riesce a modificare lo Statuto solo nel 1976, dopo un
percorso difficile e anche con lacerazioni interne, con il quale
riunisce in un’unica entità il C.N.G.E.I. maschile e l’U.N.G.E.I.
femminile.
Il vecchio Statuto ha pesato molto sulla dinamicità del G.E.I.
perché prevedeva una doppia direzione: una direzione generale e una
direzione tecnica. Gli incarichi della direzione generale,
Presidente Generale e Consiglio Direttivo, venivano affidati a
personaggi dai nomi altisonanti e rappresentativi, ma che molto
spesso non avevano una esperienza diretta di Scautismo. L’organismo
tecnico, Capo Scout e Commissari, era invece composto da persone che
venivano dallo Scautismo attivo. Fra i due organismi la
collaborazione era spesso problematica e negli anni si sono
succedute una serie di crisi, dimissioni, ecc, delle quali ha fatto
le spese la dinamicità e lo sviluppo del Corpo Nazionale.
Comunque, nonostante queste difficoltà, dopo la ripresa i dirigenti
del G.E.I. fanno del loro meglio per lanciare, sviluppare e
consolidare metodologicamente la loro istituzione. Ricordiamo una
serie di iniziative quali i Campi Nazionali, nel 1948, a Salice d’Ulzio
in Piemonte, nel 1952 a Manziana, presso Roma, nel 1956 a Rasiglia
in Umbria e nel 1962 a Cervarezza sull’Appennino bolognese.
Il G.E.I. sperimenta la coeducazione fin dal 1963 con Branchi misti
di Lupetti e Lupette per passare, anni dopo, alla coeducazione nelle
altre Branche.
Un ruolo molto importante nella vita del Corpo Nazionale è svolto
dalla “Scuola Capi” di Opicina, presso Trieste, diretta per lunghi
anni da Antonio Viezzoli e che ha formato generazioni di Capi del
G.E.I..
Due parole sullo sviluppo numerico dello
Scautismo in Italia
L’A.S.C.I. nel 1946 conta già 22.000 iscritti,
però poi, negli anni successivi, non vi è una crescita numerica ma
una lunga fase di stasi che dura quasi 15 anni. Anzi, gli iscritti
diminuiscono e, negli anni 1952 e 1953, l’A.S.C.I. tocca il minimo
con 18.000 iscritti. L’impegno di tanti capi, che nei primi anni
della ripresa avevano fondato nuove Unità, si è andato esaurendo.
Lavoro, famiglia e altri impegni li assorbono e quindi sono
costretti a lasciare il loro incarico, ma non tutti hanno formato
una nuova generazione di Capi in grado di sostituirli. Ed ecco
quindi la dolorosa chiusura di numerose Unità e Gruppi e la
conseguente diminuzione numerica.
È una fase di stasi che però è anche una fase di consolidamento. La
crescita arriverà all’inizio degli anni ‘60 quando il Metodo delle
tre Branche è ormai ben definito, il Roverismo ha ormai trovato la
sua strada e iniziano a sorgere Clans solidi e numerosi e dai quali
poi trarre i futuri Capi, la Formazione Capi ha meglio strutturato i
campi scuola e anche l’ambiente esterno, la società civile, è ormai
più favorevole agli Scouts.
L’associazione inizierà allora una crescita molto vivace, arrivando
dai 26.000 del 1960 ai 62.000 del 1974. Una crescita anche troppo
vivace perché poi arriveranno ben altri problemi dovuti in parte
anche a questa crescita fin troppo veloce.
L’A.G.I. progredisce numericamente molto lentamente e conosce anche
delle battute di arresto. Nel 1947 le iscritte sono 2.600. Nel 1956
sono raddoppiate e sono 5.000. Lo sviluppo inizia deciso solo negli
anni ’60 per arrivare, con una crescita molto rapida, alle 20.000
iscritte nel 1974.
Il G.E.I. si mantiene entro numeri molto più piccoli di quelli
dell’A.S.C.I. e dell’A.G.I.. Il numero degli iscritti al C.N.G.E.I.
fino al 1956 non è noto. Per il 1956-60 alcune cifre stimate
indicano 6-7.000 iscritti, ma non saprei quanto siano esatte. Mi
sono rivolto anche al Centro Studi Olivo del C.N.G.E.I. per avere le
cifre degli iscritti di quegli anni, ma la risposta è stata che non
dispongono di questi dati. Le cifre più certe iniziano dal 1962 con
2.000 iscritti per arrivare a 3.300 nel 1974.
Per l’U.N.G.E.I., negli anni considerati, la cifra oscilla intorno
alle 1.200 - 1.500 iscritte. Globalmente, a metà degli anni ’70,
sommando maschi e femmine, il G.E.I. aveva 4.500-5.000 iscritti.
Altre associazioni scout
Concludo questo quadro schematico della situazione dello Scautismo
italiano negli anni ’40, 50’, ’60 con una piccola curiosità: in
quegli anni in Italia lo Scautismo italiano si chiama solo ASCI, AGI
e GEI. L’unica esperienza condotta al di fuori di esse e che ha
lasciato qualche traccia è l’A.B.S.I., “Associazione Boy Scouts
d’Italia”, nata in Piemonte negli anni ’50 ma chiusa dopo poco
tempo. Al contrario di quanto accade oggi, dove vediamo in Italia la
presenza di oltre 40 associazioni scout, fra grandi, piccole e
piccolissime.
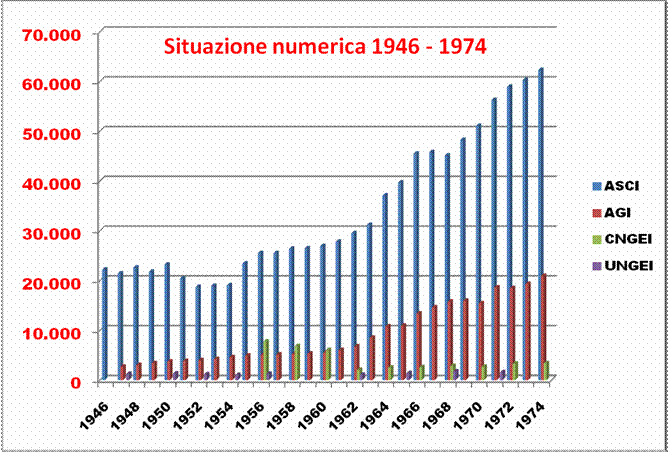
Fonte: Mario Sica, Storia dello Scautismo in Italia, Fiordaliso,
2006
1 Direttive A.S.C.I. – 1925 - artt. 36 e seguenti
2 A. M. Maynard, Sii Preparata, Edizione della Federazione Italiana
Guide Esploratrici, Roma 1946
3 Uno dei testi di base di questi anni è: Ruggi d'Aragona o.p., “Le
guide di oggi le donne di domani”, Roma, 1945
[torna] |
 di Attilio Grieco
di Attilio Grieco