|
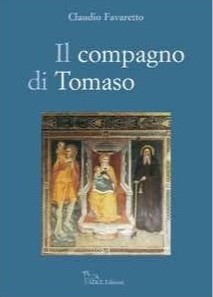 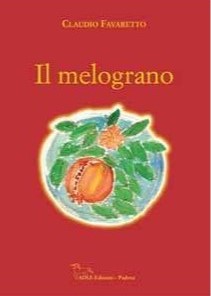 Claudio Favaretto
è nato nel 1941 a Treviso, città da cui si è
allontanato raramente. Claudio Favaretto
è nato nel 1941 a Treviso, città da cui si è
allontanato raramente.
Compiuti forzatamente studi tecnici per
necessità familiari, dopo essersi diplomato perito chimico, trovato
lavoro come insegnante di disegno in una scuola professionale, l'anno
successivo, con laborioso salto acrobatico, ottenne la licenza
magistrale che gli consentì di frequentare a Padova la facoltà di
Magistero, seguendo finalmente la sua vocazione.
Laureatosi con il massimo dei voti e la lode
in Materie Letterarie con la tesi in Storia dell'Arte sui Riccati, una
famiglia di matematici e studiosi di architettura fioriti nella seconda
metà del Settecento a Treviso, ha trascorso molti anni insegnando
animosamente lettere nei Licei scientifici.
Ma non ha mai tralasciato la sua passione per
l'arte, utilizzando ogni occasione per far conoscere ai propri ed altrui
alunni quanto di bello la nostra città e tutto il contado potevano
offrire.
Sposato, padre di quattro figli e nonno
felice di quattro nipotini [per il momento], ha dato alle stampe due
libri, editi da ADLE Edizioni di Padova.
Il primo, 'IL Melograno", edito nel 1998,
raccoglie una serie di vicende e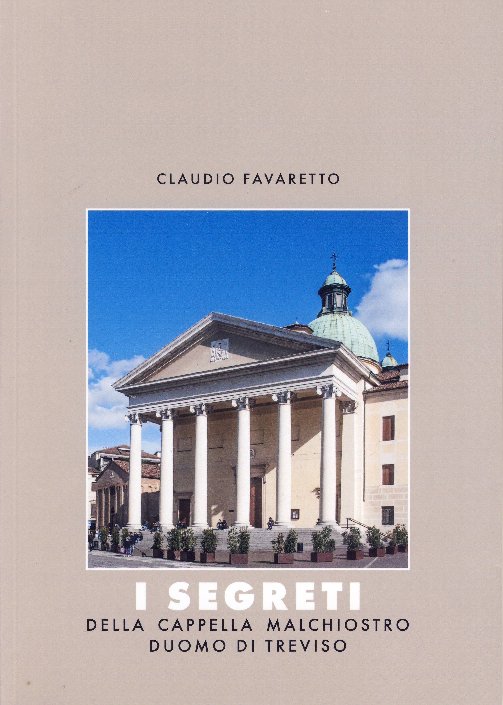
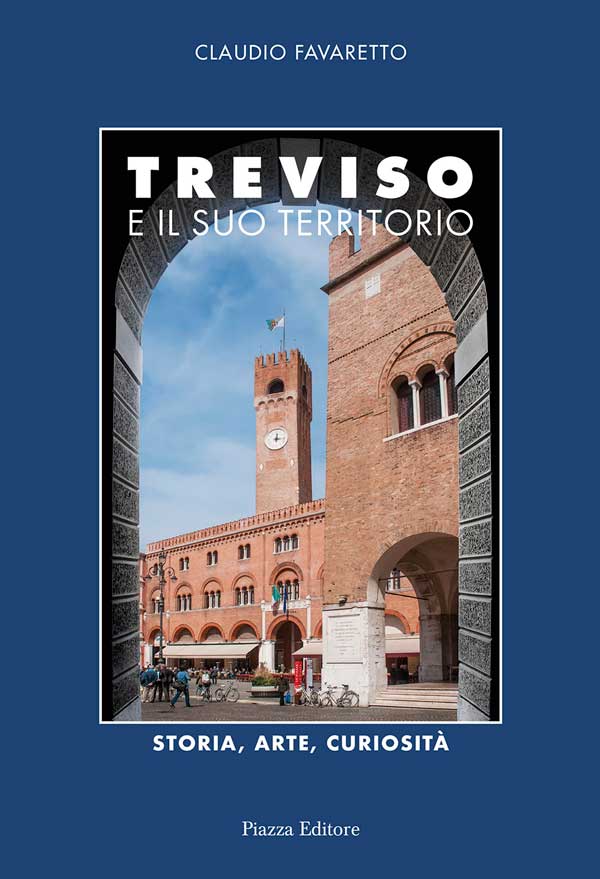 ricordi autobiografici, il secondo, 'Il
compagno di Tomaso" del 2006, è un racconto lungo, ambientato nella
Treviso medievale al tempo di Tomaso da Modena. ricordi autobiografici, il secondo, 'Il
compagno di Tomaso" del 2006, è un racconto lungo, ambientato nella
Treviso medievale al tempo di Tomaso da Modena.
Nel 2017, ha dato alla stampa il libro
"TREVISO e il suo territorio" Piazza editore.
Da ultimo nel aprile del 2023 ha pubblicato
con l'Arte Grafica Casale sul Sile il libretto "I SEGRETI della Cappella
Malchiostro - Duomo di Treviso"
Ha collaborato a lungo con la rivista "Taste
Vin" con articoli tesi a far conoscere l'arte, la storia e le tradizioni
della Marca trevigiana.
Da diversi anni è direttore della biblioteca
del capitolo del duomo di Treviso.
da "Taste Vin" n.6/2018
Sant’Augusta di Serravalle
di Claudio Favaretto
 Capita,
scorrendo un elenco di santi, di imbattersi in un nome pressoché
sconosciuto, al di là di una località ben precisa. Li sentiamo, questi
santi, molto domestici, come se appartenessero alle nostre famiglie. Capita,
scorrendo un elenco di santi, di imbattersi in un nome pressoché
sconosciuto, al di là di una località ben precisa. Li sentiamo, questi
santi, molto domestici, come se appartenessero alle nostre famiglie.
E’ questo il caso di sant’Augusta che viene sempre accompagnata dal
luogo dove fu martirizzata: Serravalle di Vittorio Veneto.
Le vicende della sua vita sono leggendarie ma è ben viva la profonda
venerazione di cui gode da secoli, specialmente fra i Vittoriesi.
Le notizie che la riguardano ci sono state tramandate nel 1581 da un
certo Minuccio Minucci, conterraneo della santa e segretario del papa
Clemente VIII. Sono quindi molto lontane dall’epoca in cui visse
Augusta. E’ vero che ogni leggenda conserva in sé un nucleo di verità,
in questo caso resa più concreta da alcuni dati storici.
I più antichi (1234) risalgono al Medio Evo e citano il “monte di
sant’Augusta”. Ciò significa che a quell’epoca la santa era sicuramente
venerata. Anche gli Statuti di Serravalle parlano di lei.
Ben poco si conosce anche del santuario che sorge sul monte Marcantone
che ancor oggi viene popolarmente indicato come il monte di
sant’Augusta.
Con ogni probabilità su quel luogo sorgeva una postazione militare che
dominava lo stretto passaggio dell’unica via percorribile dalla montagna
verso la pianura. Il nome stesso di “Serravalle” ribadisce la morfologia
del luogo.
Sicuramente i Romani fortificarono quella strozzatura viaria costruendo
il “castrum”, cioè un accampamento militare difeso da poderose mura. Era
così importante quel luogo che fu utilizzato in seguito da tutti i
vincitori delle contese, sicuramente dai Longobardi e poi dai Franchi.
Ma niente ci impedisce di pensare che alla caduta dell’Impero romano, i
primi popoli barbari provenienti da est, i Visigoti, si siano
impadroniti di tutte le fortezze già appartenute ai Romani.
Testimonianze di quel tempo sono visibili ancor oggi come la torre di
segnalazione all’inizio della val Lapisina e i resti di…
da "Taste Vin" n.5/2018
San Martino di Tours
di Claudio Favaretto
 L’autunno
ormai avanzato ci fa desiderare ancora un po’ di tepore, quel tepore che
arriva con la cosiddetta “estate di san Martino”. L’autunno
ormai avanzato ci fa desiderare ancora un po’ di tepore, quel tepore che
arriva con la cosiddetta “estate di san Martino”.
E’ questo uno dei santi più popolari il cui culto è diffuso in tutta
l’Europa e in modo estremamente significativo in Italia. Basta scorrere
l’elenco alla fine di un atlante geografico o stradale per vedere quante
località grandi e piccole portino il suo nome. E quante chiese,
basiliche, monasteri siano a lui dedicati.
Quali sono i motivi che lo hanno reso così celebre e venerato? Io penso
che la genuina sensibilità popolare sia stata colpita soprattutto dal
gesto famoso compiuto da Martino dividendo il suo mantello per darne
metà al povero intirizzito dal freddo.
E’ un gesto che commuove per l’immediatezza: Martino non ci pensa su un
attimo e con un colpo di spada compie un gesto di gratuita generosità,
di vera carità cristiana.
Eppure anche questo santo viene da lontano.
Era nato in una città della Pannonia, l’odierna Ungheria, nel 316 cioè
pochi anni dopo l’Editto di Costantino che concedeva la libertà di culto
ai cristiani. Dico questo perché Martino è uno dei primi santi non
martiri della storia del Cristianesimo.
Il padre era un ufficiale dell’esercito romano di stanza in quella
lontana regione dell’impero. Per questo il bambino viene chiamato
Martino, cioè piccolo Marte, il dio della guerra.
Ma il padre fu presto trasferito a Pavia per ragioni di servizio. Come
ogni figlio di veterani, anche il piccolo era destinato alla carriera
militare che abbracciò, sotto la spinta del padre, a 15 anni con
giuramento. In breve tempo il ragazzo si fece benvolere ed apprezzare al
punto da essere promosso “circitor”, incarico che prevedeva l’ispezione
notturna dei posti di guardia.
Durante una di queste ispezioni, mentre era di guarnigione ad Amiens, in
Gallia, vide un povero seminudo intirizzito dal gelo della notte
invernale a cui di slancio diede la metà del suo caldo mantello che
aveva diviso con la spada.
Questo…
da "Taste Vin" n.6/2017
La religiosità popolare: i
Santi Ausiliatori
di
Claudio Favaretto
 Sono
chiamati santi ausiliatori un gruppo di 14 santi che venivano invocati
ciascuno per un particolare aspetto della vita quotidiana. L’elenco non
fu identico dovunque per cui si possono trovare differenze da luogo a
luogo. Così san Biagio era invocato contro il mal di gola, santa Barbara
contro i fulmini e la morte improvvisa, san Cristoforo contro gli
uragani, e così via. Sono
chiamati santi ausiliatori un gruppo di 14 santi che venivano invocati
ciascuno per un particolare aspetto della vita quotidiana. L’elenco non
fu identico dovunque per cui si possono trovare differenze da luogo a
luogo. Così san Biagio era invocato contro il mal di gola, santa Barbara
contro i fulmini e la morte improvvisa, san Cristoforo contro gli
uragani, e così via.
In Italia il loro culto collettivo non è molto attestato, mentre in
Germania è diffuso, soprattutto nella Baviera dove probabilmente nacque
e si diffuse, specialmente negli anni delle grandi epidemie a metà del
1300.
A metà del 1700 nel comune di Bad Staffelstein,nella diocesi di
Bamberga, fu costruita, in onore degli ausiliatori, una splendida
basilica in stile barocco, méta di migliaia di pellegrini ogni anno.
Invece non appartiene all’elenco ufficiale, pur essendo stato uno dei
santi più venerati, sant’Antonio abate.
Fino a qualche anno fa, infatti, chi entrava in una stalla delle nostre
contrade notava subito, attaccata ad un palo di sostegno o all’interno
della porta, un’immagine sacra: un vecchio dalla lunga barba attorniato
dagli animali tipici di una fattoria.
Quel santo era sant’Antonio abate, da non confondersi con l’omonimo
sant’Antonio da Padova. Il santo abate era celebrato il 17 gennaio con
una grande festa che culminava nella benedizione degli animali che un
tempo erano addirittura portati nel sagrato della chiesa.
Credo che attualmente il santo non sia più di moda, almeno nell’Italia
del nord, perché la modernità ha sostituito la religiosità con
l’efficienza tecnologica e poi perché la cosiddetta civiltà contadina é
scomparsa. Sono ormai ben poche le imprese agricole a conduzione
famigliare: oggi si tende alla creazione di vasti possedimenti agricoli
gestiti con macchinari sempre più sofisticati mentre le stalle accolgono
numerosi capi di bestiame, allevati con i più moderni mezzi, dalla
somministrazione del foraggio alla mungitura.
Ma vale la pena di…
da "Taste Vin" n.
di febbraio 2007
La chiesetta dei
Santi Gervasio e Protasio
di
Claudio Favaretto
Il nostro territorio ospita numerose chiesette campestri, segno di
un’antica e fedele religiosità tramandata nei secoli. Spesso sono
costruzioni modeste dal punto di vista artistico, perché erette dalla
pietà popolare che voleva manifestare con la sua operosità
l’attaccamento alla fede dei padri, alla quale si rivolgeva in
particolar modo per chiedere aiuto contro le avversità metereologiche o
per ringraziare dopo un raccolto fruttuoso.
E così, anche la più mediocre conserva il fascino di un mondo ancorato
ai ritmi millenari delle stagioni, a un tempo in cui la massima parte
della popolazione traeva sostentamento dal lavoro dei campi. In tante di
queste chiesette si concludeva il giro, attraverso i campi, delle
”rogazioni”, parola che deriva dal latino “rogare”, cioè chiedere
l’aiuto divino, naturalmente, contro i temporali estivi o contro la
siccità, cose che potevano rovinare interi raccolti e ridurre le
famiglie contadine alla miseria e alla fame. Erano pratiche risalenti
ancora agli antichi Romani sotto il nome di “ambarvali”, cioè di “feste
attorno ai campi” guidate da sacerdoti con lo stesso nome, che con il
passare del tempo erano state
 cristianizzate,
pur mantenendone l’aspetto esteriore. cristianizzate,
pur mantenendone l’aspetto esteriore.
Queste pratiche religiose si svolgevano di buon mattino a partire dal
mese di giugno. Il parroco, indossate la cotta e la stola, accompagnato
da uno o più chierichetti, sostava presso un altarino improvvisato in
mezzo ai campi o presso un “albero sacro” come se ne incontra ancora
qualcuno: di solito si trattava di un carpino scapitozzato i cui giovani
rami venivano piegati a formare quasi una nicchia in cui si poneva
un’immagine sacra. Recitate alcune preghiere, il sacerdote benediva i
campi circostanti.
Di tali funzioni liturgiche esiste ormai, purtroppo, solo il ricordo
delle persone più anziane. In qualcuna delle chiesette sopra ricordate
alle volte sono racchiusi dei veri capolavori artistici, spesso
malauguratamente rovinati dal tempo e dall’incuria degli uomini.
E’ questo il caso proprio della chiesetta dei Santi Gervasio e Protasio
che appare improvvisa in mezzo alla campagna di S. Pelagio, nella
periferia nord-ovest del comune di Treviso, in una località chiamata
“Roncole”.
Il nome merita una piccola spiegazione. Esistono diverse località,
alcune diventate paesi importanti come Roncadelle o più ancora Roncade,
che derivano dallo stesso termine, cioè “roncare”, vale a dire tagliare
con la roncola, disboscare.
E’ evidente che gli antichi abitanti di S. Pelagio dovettero sottrarre
al bosco planiziale che ricopriva la zona i campi da coltivare, con un
lavoro ciclopico di dissodamento e di successiva sistemazione.
Questo accresce fascino ed attesa alla nostra chiesetta, anche per i
Santi a cui è dedicata, poco comuni nel nostro territorio, ma ben
presenti a Milano, in Lombardia e in Francia.
La leggenda che avvolge la loro storia ne fece due gemelli, giustiziati
nel terzo secolo e i cui corpi furono rinvenuti da S. Ambrogio vescovo
di Milano e da lui deposti sotto l’altare della basilica che porta il
suo nome.
Ci si chiede come mai sia sorta in un punto così isolato, lontano da
ogni importante via di comunicazione. L’impossibilità di fornire una
risposta rende ancora più misteriosa la costruzione che sembra risalire
addirittura al Mille, anche se per alcuni studiosi la data è da
spostarsi più avanti di uno-due secoli, cioè al XII-XIII° secolo. Resta,
comunque, una preziosa reliquia del passato.
L’edificio si staglia per il suo colore chiaro contro il verde dei prati
o il bruno dei campi da poco arati. La si raggiunge percorrendo una
breve carrareccia che lambisce un ampio vigneto a merlot e a cabernet
sauvignon, a sinistra, e delle costruzioni agricole a destra. Sorge su
un leggerissimo rialzo del terreno, forse una volta più marcato.
Si presenta come una semplice aula rettangolare, forse ampliata rispetto
all’impianto originale, conclusa, però, da un’abside cilindrica,
tipicamente romanica. Si resta subito colpiti dal suo orientamento,
secondo l’antica usanza di orientare l’altare a est e l’ingresso
principale a ovest. Tutta l’arte medievale è simbolica, per cui tale
orientamento aveva lo scopo di ricordare che l’altare dove si celebra il
mistero eucaristico, rappresenta la Luce del mondo, Cristo, quella
stessa luce che, nell’armonia del Creato, viene portata dal sole che
sorge.
Quando si esce dalla chiesa si va incontro all’occaso, al tramonto del
sole, che ricorda l’effimero della nostra vita terrena. La facciata è
mossa da un accenno di protiro, cioè di portico, mentre sulla parte a
mezzogiorno si apre la porta secondaria.
Oggi la parete meridionale presenta quattro fori: due
 mezze
lune, di evidente recente esecuzione e due monofore molto antiche, che
sono coronate dall’armilla, un giro di mattoni posti longitudinalmente,
elemento usuale dell’architettura romanica. L’intradosso dell’arco, cioè
lo spessore del muro, porta tracce evidenti di decorazione, forse a
fresco. La cornice che sostiene il tetto è a “dentelli di sega”, altro
indizio di architettura medievale, come si può riscontrare in numerose
case coeve di Treviso. Probabilmente i muri erano intonacati, come si
può notare dalla facciata e da qualche frammento ancora esistente nella
parete sud. Ma dove l’intonaco è caduto si può scorgere l’estrema
povertà del materiale usato: ciottoli di fiume, intervallati, di tanto
in tanto, da un rigo di mattoni. Il tetto è stato recentemente
restaurato, ripristinando la consueta copertura a coppi alla veneta. mezze
lune, di evidente recente esecuzione e due monofore molto antiche, che
sono coronate dall’armilla, un giro di mattoni posti longitudinalmente,
elemento usuale dell’architettura romanica. L’intradosso dell’arco, cioè
lo spessore del muro, porta tracce evidenti di decorazione, forse a
fresco. La cornice che sostiene il tetto è a “dentelli di sega”, altro
indizio di architettura medievale, come si può riscontrare in numerose
case coeve di Treviso. Probabilmente i muri erano intonacati, come si
può notare dalla facciata e da qualche frammento ancora esistente nella
parete sud. Ma dove l’intonaco è caduto si può scorgere l’estrema
povertà del materiale usato: ciottoli di fiume, intervallati, di tanto
in tanto, da un rigo di mattoni. Il tetto è stato recentemente
restaurato, ripristinando la consueta copertura a coppi alla veneta.
Sovrasta la costruzione un campaniletto cosiddetto “a vela”, molto
comune nelle nostre chiesette campestri, con due fori che ospitano
ciascuno una campanella. Si tratta di un’aggiunta molto recente,
probabilmente ottocentesca, ma che non stona affatto nell’insieme.
Entrando dalla porta principale, quella ad ovest, lo sguardo abbraccia
subito tutto il volume: l’aula rettangolare e la piccola abside. Ci si
accorge subito che l’arco trionfale, quello che conduce all’abside, ha
l’imposta molto ribassata, come se il piano del pavimento fosse stato
rialzato. Ma ciò non può essere, perché si trova a livello del piano di
campagna ed è difficile pensare che un tempo si dovesse scendere uno
scalino per entrare nella chiesa. Il pavimento, da poco sistemato, è a
tavelle di cotto, il soffitto, di recente restaurato, a capriate (e un
po’ stona il nuovo del legno con la vetusta costruzione!), i muri sono
per lo più spogli. Ma nell’abside si nota l’esistenza di tracce di un
antichissimo affresco, a sinistra della piccola feritoia aperta
esattamente al centro del semicatino, di una Madonna con il Bambino e
Santa, di fattura due-trecentesca, su una tonalità fredda di
verdi-azzurri.
Purtroppo questi lacerti sono tutto quello che resta di un affresco che
Mario Botter, nel 1953, in un articolo pubblicato sul Gazzettino,
definiva “un magnifico affresco del XIII° secolo” il cui stato di
conservazione, allora, era “buono”! Secondo lo studioso, tale affresco
servì da modello a “quello prodigiosamente conservatosi nella parete
meridionale della chiesa”. In effetti, nei pressi della porta laterale,
si può ammirare, malgrado lo stato di degrado, una splendida opera. Si
tratta di una “Sacra conversazione”, cioè di un gruppo di Santi che
attorniano la figura centrale, che è quella della Madonna che allatta il
Bambino. La Vergine è assisa in un trono modesto dallo schienale arcuato
che si collega a due montanti rotondi terminanti in due sfere di legno,
quasi il lavoro di un falegname del tempo. Alla sua destra, in piedi,
sta la figura aureolata di san Gervasio che reca nelle mani forse dei
rami, il segno del suo martirio (fu, infatti, flagellato a morte),
mentre alla sua sinistra si staglia la figura di una santa, identificata
come S. Maria Maddalena, con la mano destra alzata e la sinistra forse
reggente un vaso di unguenti, ma l’affresco è abraso e non consente una
precisa lettura. Ancora più a sinistra conclude l’opera un santo stante,
Protasio, con un particolare copricapo, per indicare la sua professione
di medico, e con le mani molto discoste, quasi a reggere quella spada
che lo giustiziò. I manti di tutti i personaggi sono di colore caldo,
rosso-bruno, con le pieghe sottolineate da profonde ombreggiature, salvo
la veste dell’ultimo santo, che è di colore verde.Bisogna ricordare,
infine, una figura di Santo, forse di esecuzione secentesca, a destra
dell’arco trionfale, rovinata in più punti.
E’ veramente un peccato che questo gioiello di fede e di arte sia stato
trascurato al punto da mettere a rischio la stessa sopravvivenza degli
affreschi, come purtroppo è già successo con quello dell’abside.
Affreschi di quell’epoca ne esistono ben pochi anche in città, per cui
sarebbe necessario che gli uffici competenti intervenissero subito, per
evitare una perdita ulteriore del nostro patrimonio artistico.
dalla stampa locale ("Vita del popolo" o "Gazzettino"?)
Dante Alighieri, Treviso e la Biblioteca Capitolare
di
Claudio Favaretto
Settecento anni fa, nel settembre del 1321, moriva a Ravenna, Dante
Alighieri.
Come sì sa, mentre era a Roma per un'ambasceria presso il papa,
Bonifacio VIII, la fazione dei Neri s'impadronì con la violenza di
Firenze, scatenando l'odio contro la fazione avversa, quella dei Bianchi
cui Dante apparteneva. E il poeta, accusato falsamente di baratteria,
oggi si direbbe di tangenti e di guadagni illeciti, fu condannato
all'esilio e alla confisca dei suoi beni, una tristissima usanza molto
comune in quegli anni turbolenti.
Da allora il poeta, dopo un tentativo di rientrare a Firenze con la
forza con i Bianchi esuli come lui, deluso e infastidito dalla compagnia
"malvagia ed empia", se ne staccò e iniziò a peregrinare per l'Italia,
in cerca di accoglienza. I biografi ci informano che si recò in
Lunigiana, a Verona, ad Arezzo, ancora a Verona, finendo a Ravenna dove
morì per una febbre malarica presa a Venezia. Ma, per noi, la curiosità
più viva è se Dante sia stato anche a Treviso. Ormai la critica è
convinta di sì. Anche se non ci sono documenti precisi, nelle sue opere
alcuni richiami parlano della nostra città in modo esplicito così da
stabilire perfino gli anni del suo soggiorno, tra il 1305 e il 1306,
periodo in cui Treviso era governata dalla signoria dei Caminesi o da
Camino.
Quali sono gli indizi? Il più noto è quello che si
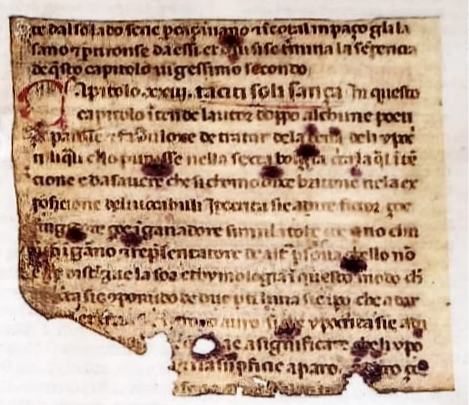 incontro
nel canto IX del Paradiso, là dove si individua la città con il famoso
verso “Ià dove Sile e Cagnan s'accompagna". incontro
nel canto IX del Paradiso, là dove si individua la città con il famoso
verso “Ià dove Sile e Cagnan s'accompagna".
Si dice, giustamente, che questo verso poteva scriverlo solo chi aveva
visto con i propri occhi che le due correnti, quella limpida del Sile e
quella torbida del Cagnan Grande o della Pescheria, non si fondono
subito, ma restano distinte per un bel po', si accompagnano, appunto,
scendendo verso valle.
Il secondo indizio ci viene offerto dal canto XVI del Purgatorio dove
un'anima dice a Dante che la corruzione si era diffusa nel mondo e che
poche erano rimaste le persone oneste, tra cui, appunto "il buon
Gherardo", cioè Gherardo da Camino, signore di Treviso, morto nel 1307.
Il terzo indizio riporta ancora il nome del Caminese e proviene da
un'altra opera di Dante, Il Convivio: "[Poniamo] che Gherardo da Cammino
fosse stato nepote del più vile villano che mai bevesse del Sile o del
Cagnano, [e che il ricordo del suo antenato non si fosse ancora spento,
chi oserebbe definire Gherardo un uomo rozzo?]". Le lodi fanno pensare a
un debito di riconoscenza di Dante nei confronti del Signore di Treviso.
La Biblioteca Capitolare conserva alcuni frammenti pergamenacei di
eccezionale valore storico perché appartengono al primo commento
completo alla Divina Commedia composto da Iacomo Della Lana prima del
1328, pochissimi anni dopo la morte del poeta. L’autore, nato a Bologna,
seguì la famiglia che si trasferì a Venezia, forse per interessi
commerciali. Secondo la più recente critica storica, fu qui che lacomo
compose il suo commento, come testimonia la presenza di parecchie parole
in lingua veneta. Ecco uno dei frammenti, che presenta il canto XXIII
dell'Inferno:
"Taciti, soli, sança”.
In questo capitolo itende l’autore doppo alchune poetiche parole et
fabulose de tratar dela pena deli ypocriti liquali ello punisse nella
sexta bolgia circa la qual intericione è da savere che si chomo dixe
bacone ne la ex posicione deli uocabuli jpocrita siè a dire fictor è
çoè". In questo capitolo l'autore, dopo alcune parole poetiche e
fantastiche, intende trattare della pena degli ipocriti che egli punisce
nella sesta bolgia nei riguardi della quale bisogna sapere che, come
dice Bacone nella spiegazione dei vocaboli, ipocrita vuol dire falso,
cioè...".
dalla stampa locale ("Vita del popolo" o "Gazzettino"?)
Nuove scoperte alla Biblioteca Capitolare
Eccezionali Capolavori in campo musicale
di
Claudio Favaretto
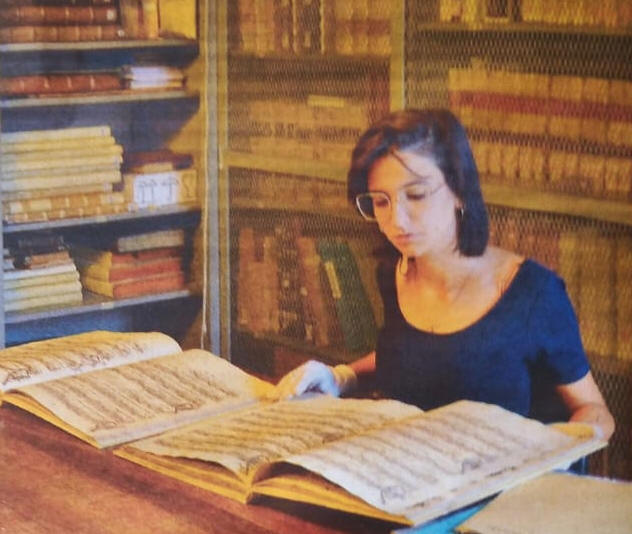 Sempre
più studiosi svolgono le loro ricerche nella Capitolare, prezioso
scrigno in parte ancora da scoprire. Sempre
più studiosi svolgono le loro ricerche nella Capitolare, prezioso
scrigno in parte ancora da scoprire.
Il patrimonio musicale, grazie alla prudenza di mons. D’Alessi durante i
bombardamenti e la distruzione della Seconda guerra mondiale, è vasto e
prezioso.
Il tesoro custodito nella Capitolare è stato ancora una volta al centro
di studi accurati.Dopo il recente lavoro di don Alessandro Bellezza che
ha studiato il messale Vetus, un messale di inizio secolo XIV, che mette
nuova luce sul legame tra la città di Treviso e il rito patriarchino
(Alessandro Bellezza, Un messale votivo veneziano. Treviso,
Biblioteca Capitolare della Cattedrale l.99(4)ff.1-65. Marcianum Press,
2022), nel mese di luglio si è laureata con il massimo del punteggio e
la lode al Dipartimento di Musicologia e dei Beni Culturali
dell’Università di Pavia (sede Cremona) Anna Martini, giovane musicologa
trevigiana che ha esaminato due codici musicali presenti in biblioteca.
Si tratta dei codici I-TVc24a/b che testimoniano numerosi brani bicorali
- e dunque con due cori spazialmente distanti tra loro e che creavano un
grandioso e spettacolare effetto stereofonico, in uso presso la cappella
trevigiana nel corso del XVI secolo. Più nel dettaglio, la studiosa ha
curato l'edizione critica dei brani anonimi presti nei codici,
proponendo la paternitá di alcuni di essi a grandi compositori del
Cinquecento. Inoltre, ha ipotizzato la datazione di questi codici agli
anni '30 del XVI secolo, aggiungendo dunque un tassello di conoscenza
non solo sulla storia musicale, ma anche sulla storia della città di
Treviso e sull'attività della Cappella musicale del Duomo.
Per molti trevigiani la- biblioteca Capitolare è un'illustre sconosciuta
mentre, invece, custodisce capolavori eccezionali, specialmente nel
campo musicale. Malgrado lo scempio subito dal terribile e mai
abbastanza esecrato bombardamento del 7 aprile 1944 compiuto dagli aerei
anglo-americani,. il patrimonio musicologico è ancora vasto e prezioso.
Il salvataggio di una buona parte del tesoro musicale si deve alla
prudenza di mons. D'Alessi, allora responsabile della biblioteca, che
trasferì fuori città quanto poté, proteggendo così dalla distruzione
certa testi di fondamentale importanza. Ne è un esempio l'Odehcaton
(1501), la prima stampa musicale a caratteri mobili al mondo.
Nel Rinascimento la Cappella musicale del Duomo godette, infatti, di
fama internazionale, annoverando tra i suoi direttori famosi musicisti
come Francesco Santacroce, Niccolò Olivetto, e Giovanni Nasco.
Grazie agli studiosi che continuano a svolgere un appassionato lavoro di
ricerca, le scoperte continuano anche ai giorni nostri . La già citata
Anna Martini ha scovato l'importante Antifonario stampato da Petrus
Liechtenstein a Venezia nel 1558, unico esemplare al mondo. Mentre il
prof. Paolo Cagnin, assiduo frequentatore della Capitolare, ha trovato,
nel fondo documentario, antiche carte musicali con notazione quadrata,
che necessitano di uno studio approfondito per una migliore
catalogazione. Per questo, la biblioteca Capitolare continua a rivelarsi
come un prezioso scrigno, in parte ancora da scoprire.
|