Lo
scautismo femminile italiano: impostazioni e problematiche.
I problemi dello scautismo
femminile italiano alla ripresa, dopo la soppressione fascista, erano
la individuazione dei fini, dei mezzi e dei contenuti del metodo.
Il richiamo ai testi del fondatore Baden-Powell offriva la possibilità
di identificazione dei fini: la formazione di una personalità armonica,
la preparazione a diventare spose e madri e buone cittadine, tutti scopi
che le associazioni femminili risorte non avevano difficoltà ad
avallare.
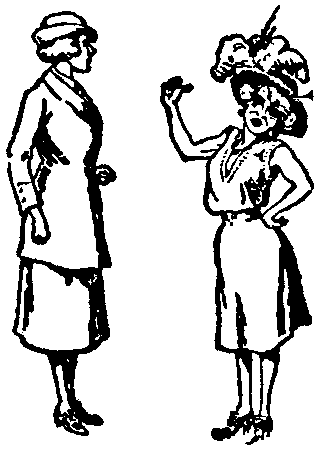 L'individuazione dei mezzi
e dei contenuti non poteva essere similare a quella maschile, come veniva
proposta, in qualche modo, da BP in Girl Guiding. Furono adottati, invece,
due testi particolari Sii Preparata della Maynard e Le guide di oggi,
le donne di domani di padre Ruggi D'Aragona.
L'individuazione dei mezzi
e dei contenuti non poteva essere similare a quella maschile, come veniva
proposta, in qualche modo, da BP in Girl Guiding. Furono adottati, invece,
due testi particolari Sii Preparata della Maynard e Le guide di oggi,
le donne di domani di padre Ruggi D'Aragona.
L'UNGEI seguì di pari passo l'evoluzione del corrispondente CNGEI
nelle due tappe fondamentali dei regolamenti del 1946 e del 1976.
L'AGI, pur nascendo dall'esperienza dell'ASCI, marcò gradualmente
la sua differenza per evitare una facile critica di "mascolinizzazione"
puntando alla rottura dell'educazione tradizionale impartita alle donne
e a differenziare il metodo e le ambientazioni da quelle dei maschi.
Padre Agostino Ruggi D'Aragona (Roma 1900-1986), scout fin dalla fondazione
dell'ASCI nel 1916, Commissario di zona per i Castelli Romani, attivo
nello scautismo clandestino del Roma 5°, è Assistente Ecclesiastico
centrale dell'AGI dal 1944 al 1967, fu colui che suggerì l'ambientazione
della "coccinella".
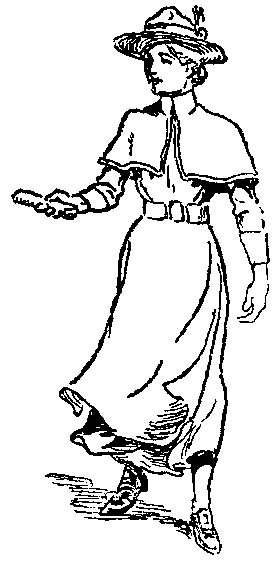 La Branca Coccinelle
(8-11 anni) propone il percorso di un sentiero in tre stadi: del prato,
del mughetto, della genziana fino alla conoscenza dei segreti della "grande
quercia".
La Branca Coccinelle
(8-11 anni) propone il percorso di un sentiero in tre stadi: del prato,
del mughetto, della genziana fino alla conoscenza dei segreti della "grande
quercia".
Il mondo dello "spirito del bosco" fa vivere la bambina nella
libertà di espressione, di ricerca di strumenti adatti alla sua
crescita in una comunità gioiosa detta del "cerchio"
che la rende indispensabile all'esistenza di questo, infatti, "se
manca qualcuno il cerchio non è completo".
La Branca Guide si sviluppa in parallelo a quella maschile, mitigando
gli eccessi della tecnica, dello spirito di avventura e ricercando e vivendo
la femminilità anche in ambienti tipicamente ostili come l'avventura
del campo.
La Branca Scolte trova la sua concretizzazione sui testi di Folliet, La
spiritualità della strada, e di Pignedoli, Strade aperte. Nel 1947
svolge il suo primo incontro nazionale ad Assisi ed in quell'occasione
adotta l'inno della città umbra come suo inno.
La "strada" per le scolte diventa "via", simboleggia
il percorso da compiere e dà senso alla vita come progressione,
come lotta alle difficoltà. La "via" porta ad uscire
dalle proprie sicurezze, porta all'incontro con gli altri e con se stesse,
ad immergerti nella realtà e nella natura in modo da esser autonome
ed essenziali. La dimensione comunitaria, vissuta nel "fuoco"
con la condivisione delle esperienze e con l'adesione ad uno spirito di
semplicità e povertà, è coordinata dalla "carta
di fuoco" e dal "consiglio di fuoco" che conducono al traguardo
della "partenza" e all'acquisizione del titolo di "Scolte
di S. Giorgio".
La scelta definitiva è quella del servizio per donare la propria
generosità nel superamento dell'egoismo, servizio che si svolgerà
principalmente all'interno dell'associazione.
Dal 1946, con Lella Berardi, iniziano i campi scuola dell'AGI che, a diversità
dell'ASCI, non portano ad acquisire un brevetto di capo differenziato
per branca.