Nello scautismo di BP è presente la dimensione politica, espressa con concetti di apartiticità, di civismo, e con l'inserimento di uomini maturi nella società per migliorarla ("lascia il mondo un po' migliore di come l'hai trovato"). BP non propose agli scouts di prendere coscienza delle ingiustizie e di agire per cambiare le strutture sociali che le generavano, egli impostò il suo metodo sull'individuo, sulla persona, e su quel lato positivo che in ciascuno è presente (5%), per svilupparlo in senso vantaggioso per se stesso e per la società.
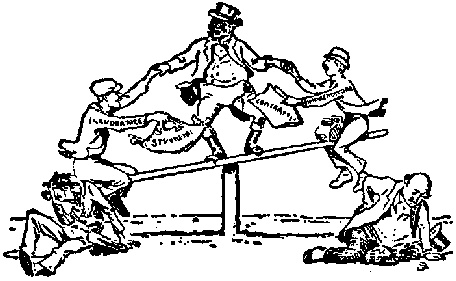
Nasce, in quegli anni, la presa di coscienza che le associazioni devono essere inserite nella realtà e non devono essere momenti di evasione da questa. Già nel 1967 l'AGI emana un documento all'incontro del solstizio intitolato "Presenza dell'AGI nel mondo", è l'atto di nascita della richiesta di educazione alla politica. Emergono anche nella stampa scout i problemi politici più d'attualità: Vietnam - fame nel mondo - sottosviluppo - invasione della Cecoslovacchia. Si arriva ad elaborare il concetto che educare è fare politica, è avere un progetto politico, chi non l'ha vuol affermare che educa all'accettazione passiva del sistema. La strada intrapresa porterà al fatto che le branche maggiori, Clan e Fuochi, e anche alcune Comunità Capi si esporranno con firme di accettazione di manifesti politici e/o sindacali coinvolgendo, di fatto, tutto il movimento.
La dimensione del gruppo prende il sopravvento sulla figura del Capo, figura che va demitizzata, anche se nello scautismo il mito del Capo è esistito solo nelle cattive applicazioni del metodo. Il Capo, nel convegno a Caserta dei Capi Riparto subisce un piccolo ridimensionamento, vi è il passaggio della figura da Capo - eroe a Capo animatore, suggeritore, fallibile e criticabile anche da parte dei ragazzi. La branca Coccinelle (1970) elabora il concetto della "non direttività", in altre parole le Capo non sono tenute a proporre valori, essendo il loro lavoro destinato alla crescita, anche di se stesse, in mezzo alle bambine.
La vivacità dell'AGI, nella ricerca di cambiamento, porta la riflessione anche sulla scelta tra un metodo strutturato o un metodo non strutturato. Su quest'ultima definizione cade la scelta, quindi con una rinuncia al metodo per privilegiare le esigenze delle ragazze; anche la legge non deve essere imposta, ma costruita dal "gruppo" che in essa si riconoscerà; i campi scuola diventeranno luoghi di scambio di opinioni e di esperienze e si sviluppano nella gestione comune tra allieve e capo. Nella destrutturazione l'AGI, negli anni fra il 1970-73, arriva all'annullamento dei commissariati, delle regioni, dell'istituto della Capo Guida. Questa riforma resta in vigore solo un anno, nel '74 vi è la fusione con l'ASCI.
La coeducazione.
Nel CNGEI, fin dal 1949, era permessa la guida femminile dei branchi, nel 1963 i branchi stessi potevano essere misti e con la riforma statutaria del 1976 si sancì la fusione, che era già in atto, tra la branca scolte e rover. Anche l'Azione Cattolica, nel 1969 con la promulgazione dei nuovi statuti, accettò il concetto della pari opportunità della donna, del superamento dei ruoli precostituiti fra maschio e femmina e della complementarietà tra uomo e donna.
Negli stessi anni anche l'ASCI decise di porre allo studio la coeducazione sia per l'attrazione che il termine produceva sia perché l'AGI non si sottrasse ad uno studio in comune. La spinta della base e il superamento delle norme, formò anzitempo autoctone unità miste quali Comunità Capi, Lupetti/Coccinelle, Rovers/Scolte e generò ulteriore impulso a proseguire il cammino verso la fusione tra le due associazioni.
Il nuovo rapporto con la Chiesa.
Il rinnovamento del dopo concilio portò una coscienza diversa nel rapporto con la Chiesa, attuando una ricerca e un superamento della relazione giuridico-formale sin qui vissuta. Un primo cambiamento fu il significato dato alla sigla ASCI - Associazione degli Scout Cattolici Italiani - dove l'aggettivo cattolico si sposta dall'associazione ai suoi componenti; un secondo cambiamento fu lo stabilire un rapporto che passava dalla diplomazia (Santa Sede) al piano pastorale (Conferenza Episcopale Italiana), di riflesso un più naturale raccordo con la Chiesa locale. L'AGI, oltretutto e per di più, va collocandosi su posizioni molto avanzate, si dichiara per i poveri, gli umili, i piccoli, contro ogni integralismo o posizione teocratica; propugna l'ammissione nelle unità di ragazze di nessuna o di altre confessioni, ciò per sanare situazioni già presenti in alcuni fuochi; rifiuta la posizione di apostolato e di servizio ecclesiale per abbracciare, nella sua ricerca, il mondo intero inserendosi in esso e per servirlo, tralasciando la strada del perfezionamento della Fede.
Tutti questi fermenti, queste esigenze evolutive delle associazioni, la ricerca di nuovi assestamenti pedagogici e metodologici portarono il 4 maggio del 1974, alle ore 23,50, alla votazione i Consigli Generali, i quali approvarono l'unificazione tra l'AGI e l'ASCI. La nuova associazione prende il nome di AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
Quest'unificazione, seppur da tempo preannunciata e programmata, avvenne, di fatto, nelle strutture, ma era priva, ancora, di una proposta educativa unitaria.
Le differenze più evidenti tra AGI e ASCI erano:
1. Sui valori fondamentali: Legge e Promessa Scout. L'ASCI si rifaceva ai testi tradizionali di BP, nell'AGI la conoscenza di detti testi era minore e, pertanto, in vari documenti si affermava che Legge e Promessa potevano essere ideate nelle unità.
2. Sull'atteggiamento nei confronti dell'associazione. L'ASCI riteneva un bene svolgere il metodo in una comunità associativa, l'AGI, nell'anno precedente, aveva soppresso tutta la sua struttura organizzativa.
3. Sul rapporto Capo/Ragazzo. La responsabilità del Capo ASCI era nella proposta educativa, nell'AGI le Capo avevano una presenza di riferimento (prima fra eguali); inferiore o nullo era il peso della responsabilità di proporre un programma educativo.
4. Sul metodo. L'ASCI credeva e applicava un metodo unico a livello nazionale, con continuità e serietà educativa divenendo, detta applicazione, identità dell'intera associazione. L'AGI aveva ripudiato il metodo della branca Coccinelle, le singole unità avevano autonomia applicativa del metodo, sia se si fosse trattato di quello tradizionale sia se inventato della singola Capo; anche i campi scuola, quindi, assumevano la funzione di scambio di esperienze, non inquadrate in valutazioni metodologiche né, quindi, sulla validità stessa di tali esperienze.
Il decennio che segue l'unificazione sarà il tempo che occorrerà a perfezionare la proposta educativa unitaria e ad offrire tutti i chiarimenti richiesti in un documento del 2 dicembre 1974 dall'episcopato italiano. La CEI, infatti, "avvertiva la necessità di importanti chiarimenti, strutturali e orientativi, affinché l'associazione, …., resti fedele alla sua originaria ispirazione di contenuti e di metodo,,.
Quali erano, in sostanza, i chiarimenti che la CEI chiedeva per approvare il nuovo statuto? Sono compresi nella lettera di mons. Bartoletti, segretario della CEI, inviata il 24 aprile 1975, ai consiglieri generali dell'AGESCI. In sintesi i temi da chiarire erano: il ruolo dell'Assistente Ecclesiastico - le forme di coeducazione - la scelta politica del movimento. Nel 1976 fu chiarito il ruolo dell'Assistente Ecclesiastico e l'origine del suo mandato da nomina vescovile, l'associazione confermò la sua vita nella comunione ecclesiale. Sulla coeducazione il tempo necessario al chiarimento fu più lungo, il problema fu superato con una seria impostazione coeducativa e garanzie metodologiche e pratiche. Il problema della scelta politica fece pensare ai vescovi che nulla potesse impedire sconfinamenti in impegni politici diretti e che l'AGESCI fosse una specie di "cavallo di troia" dei marxisti all'interno del mondo cattolico giovanile. La modifica statutaria "l'AGESCI realizza nell'azione educativa il suo impegno politico", ed altre piccole variazioni e precisazioni, fecero sì che la CEI superasse le perplessità iniziali e approvasse lo statuto nel 1976; nell'anno seguente nominò gli Assistenti Centrali.